Le rivelazioni di Christopher Wylie, il whistleblower di Cambridge Analytica, raccolte e pubblicate dall’Observer e dal New York Times[1] hanno riaperto il dibattito sulla raccolta dati e il tracciamento online. Grazie ad un’applicazione, thisisyourdigitallifeun semplice quiz sulla personalità, utilizzata da 270 mila utenti di Facebook[2] la società di comunicazione Cambridge Analytica è riuscita a raccogliere i dati di circa 50 milioni di persone. Secondo Wylie questi dati sarebbero stati utilizzati per promuovere la propaganda online di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali in maniera mirata e personalizzata.
Ovviamente il fatto che ci fossero di mezzo alcuni collaboratori del presidente degli Stati Uniti ha dato alla vicenda una lettura quasi esclusivamente politica. D’altronde lo scoop rientra perfettamente nella complessa ed intricata discussione riguardo possibili influenze russe nelle elezioni americane e il ruolo delle fake news nelle ultime campagne politiche. Tuttavia sarebbe un errore non provare ad andare oltre questa prima interpretazione, l’elezione di Trump va aldilà dell’uso di target pubblicitari individualizzati. Quello che lo scandalo di Cambridge Analytica ci mostra chiaramente è il metodo con cui una società privata è riuscita a raccogliere, analizzare e utilizzare i dati di milioni di persone tramite Facebook, senza che gli utenti ne fossero informati. Non si tratta di un’agenzia di sicurezza nazionale come la NSA ma di una società di comunicazione che personalizza le sue strategie di marketing a seconda dei dati che riesce ad ottenere. Dati forniti inconsapevolmente dagli utenti, sepolti nei grovigli delle condizioni d’uso e sui quali si basa l’attuale struttura del web. Il caso sollevato da Wylie porta finalmente alla luce quella zona grigia delle terze parti che regolano l’advertising online e contribuiscono a costruire l’architettura dello spazio digitale in cui ci muoviamo, svelando un meccanismo rimasto troppo a lungo escluso dal dibattito pubblico.
In questo senso ritorna utile un saggio uscito nel 2015, Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age di Bernard E. Harcourt, professore di scienze politiche e diritto alla Columbia University e studioso di Michel Foucault. Per l’autore il mondo digitale riprende la struttura dell’opera paesaggistica di Dan Graham Hedge Two-Way Mirror Walkabout: due sezioni di curve di vetro a rifrazione differenziata divise da una siepe: un pavillon di specchi tra cui passeggiare ridendo della propria immagine distorta. A metà tra il palazzo di cristallo e un Applestore, questo spazio ludico-distensivo ricrea le condizioni dell’ambiente mediatico in cui siamo costretti, e dove, circondati dai nostri riflessi trasparenti, cediamo la nostra visibilità in cambio di pochi secondi di divertimento. Per Harcourt, si tratta di una nuova condizione esistenziale ormai radicalizzata nel mondo contemporaneo. L’individuo che è pronto a condividere pubblicamente la sua intimità per ottenere gratificazioni narcisistiche di vario genere (like, followers, messaggi) si confeziona un io digitale che una volta «esposto» diventa disponibile a qualsiasi forma di controllo e di sorveglianza, sia essa esercitata dallo Stato o dalle agenzie di advertising. Tramite le nuove possibilità di raccolta dati viene così a costituirsi un alter ego digitale in costante aggiornamento che acquisisce forma e senso al di fuori della sfera individuale. Nella presunta leggerezza del Cloud, tra le banche dati delle varie piattaforme il “nuovo sé digitale permanente”, solido e concreto annichilisce i “nostri mortali analogici sé”[3].
Per il suo taglio, Exposed si iscrive esplicitamente nella tradizione novecentesca della French Theory. L’attuale società mediatica, secondo Harcourt, può essere considerata un’evoluzione delle distopie denunciate da Debord e Foucault, e le sue dinamiche pulsionali si adattano a essere analizzate con gli strumenti di Deleuze e Guattari. In un mélange di società dello spettacolo, società disciplinare e società del controllo prende forma l’«Expository society», la società dell’esposizione totale. Questa si presenta come un mondo in cui il potere offre all’individuo la possibilità di dare interamente sfogo al suo desiderio. Nella rilettura che Harcourt fa dell’Anti-Edipo, il soggetto contemporaneo è diventato una macchina desiderante attaccata ad un alimentatore illimitato, il web, che gli promette un godimento infinito e all’apparenza gratuito. Pur di partecipare al suo gioco, il soggetto cede entusiasta dati e informazioni, scambia la propria privacy per un effimero palliativo al proprio desiderio. E proprio in questo scambio iniquo consiste il ricatto occulto della società dell’esposizione: ci illudiamo che l’uso illimitato di prodotti digitali ci sia offerto in dono e ignoriamo, spesso perché non vogliamo sapere, il prezzo che paghiamo in termini di difesa della vita personale.
Questa chiave di lettura rende obsoleto il vecchio e abusato confronto tra Internet e il Grande Fratello. A differenza di ciò che succede nel romanzo di Orwell, il piacere non è bandito dal nostro mondo, ma né è il nucleo, il motore vitale. L’essenza della rivoluzione digitale risiede nel fatto di aver promesso e resa possibile una soddisfazione edonistica senza limiti. Tra il desiderio e la sua soddisfazione non si frappongono né ostacoli né intermezzi di tempo: al soggetto basta solo chiedere. La superficie palmare dello smartphone reagisce docile ai suoi stimoli, il suo pollice non deve far altro che scostare il velo dello schermo per accedere ad uno spazio ludico sconfinato – e perdere fatalmente la sua libertà. In questo scambio tra godimento e asservimento consiste il meccanismo dell’alienazione su cui si concentra la critica di Harcourt: «Desideriamo questi spazi digitali, queste esperienze virtuali, tutti questi gadget elettronici e ne siamo divenuti a poco a poco schiavi. Schiavi di tutto questo e del nostro desiderio, il nostro desiderio di condivisioni, click, amicizie e like»[4].
Siamo troppo presi dalle multiformi possibilità offerteci per poter dubitare di uno scambio che non ci costa apparentemente nulla. Il potere della società dell’esposizione ha trovato il modo per scardinare ogni possibile resistenza procurandoci riserve infinite di sensazioni con cui appagarci. Ha abbandonato il suo lato violento puntando sulla seduzione, ed ha vinto. La società dell’esposizione di Harcourt, da questo punto di vista, somiglia a quello che Gilles Lipovetsky e Jean Serroy chiamano il Capitalismo artistico nel saggio L’estetizzazione del mondo[5]appena tradotto in Italia da Sellerio. La seduzione avvolge la società dell’esposizione nella sua interezza. La competizione online si gioca infatti sulla capacità estetica del prodotto di se-ducere, di condurre a sé. Ottenere l’attenzione del cliente è il prerequisito fondamentale per poter accedere alle sue informazioni con cui personalizzare ancora di più la proposta grafica e contenutistica in modo da irretire l’individuo in un regno di richiami e ammiccamenti.
Navigando online, indossando uno smartwatch, l’individuo espone la sua persona a quello che Harcourt chiama trasparenza virtuale. La sua condizione di visibilità lo rende trasparente permettendo l’accesso alla sua autenticità virtuale: un io identificato attraverso i dati da lui prodotti, quantificato, archiviato e reso disponibile a qualsiasi tipo di sorveglianza. D’altronde, spiega Harcourt, il sé digitale è un sé narrante che non può far altro che raccontarsi per esistere, producendo delle vere e proprie confessioni digitali a uso e consumo di governi, agenzie pubblicitarie e agenzie di sicurezza che non devono neanche più sforzarsi per ottenerle[6].
Exposed sembra rilanciare l’ennesima condanna di una nuova tipologia di alienazione, identificata in questo caso nella perdita della propria individualità digitale. Difatti, nella sua critica, Harcourt sembra leggere qualsiasi attività online sotto una lente passivo-istintiva. L’individuo sembra non aver alcun controllo del suo desiderio né della tecnologia con cui interagisce. Ogni forma di presentazione di sé viene reinterpretata come un’irresponsabile esposizione edonistica del proprio io. In questo modo Harcourt esclude a priori che possano esserci alternative. Tutte le nuove forme di socializzazione e costruzione identitaria che si sono affermate con l’avvento dei social network sono per lui espressione di un esibizionismo desiderante privo di qualsiasi tipo di consapevolezza: un selfie non può essere un nuovo modo di raccontare e gestire la propria immagine ma solamente lo specchiarsi inebetito nel proprio riflesso. Non c’è alcuna forma di mediazione: visibilità significa trasparenza. L’espressione nel nuovo spazio mediatico ci rende del tutto leggibili e gestibili, la presenza nel mondo digitale è dunque sinonimo di totale vulnerabilità.
Questa fragilità è la conseguenza diretta, per Harcourt, del nostro narcisismo esacerbato dalle promesse strabilianti e dal luccichio accattivante dei nuovi dispositivi digitali. Le nuove modalità espressive non sono mai viste come una forma democraticizzata di visibilità attraverso la quale, potenzialmente, ognuno di noi ha la possibilità di raccontare e proporre il proprio io in maniera autonoma e non più legata a forme di rappresentazione dall’alto. Al contrario, ogni espressione di sé non è altro che esibizione, uno sfogo narcisistico alimentato dal desiderio che produce un’esposizione indifesa alle nuove tipologie di potere. Una bulimia autobiografica che ci spinge a rilasciare liberamente informazioni che fino a dieci anni fa avremmo considerato esclusivamente private. Questo punto meriterebbe una discussione a parte. Il concetto di privacy elaborato alla fine del diciannovesimo secolo non combacia più con gli strumenti digitali che utilizziamo ogni giorno. Gli smartphone, infatti, non ci appartengono del tutto: per poterne far uso dobbiamo accettare un’infinità di illeggibili condizioni che istaurano una sorta di nuova giurisdizione all’interno di quella che un tempo sarebbe stata una nostra esclusiva proprietà. Quello di cui disponiamo non è altro che un’interfaccia grafica, il software è escluso dal contratto di vendita. I cavilli che accettiamo senza leggere regolano la gestione delle nostre informazioni. Spuntare la casella “accetto” permette alla piattaforma o app con cui entriamo in contatto di comporre un nostro alter ego digitale a cui non abbiamo accesso e di cui non conosciamo i dettagli. Harcourt spiega il principio in maniera particolarmente chiara: il nostro sé è diventato sempre più trasparente e i dispositivi sempre più opachi. Sono scatole nere a cui non abbiamo più accesso. Provate a rimuovere la batteria dei vostri cellulari…
Harcourt purtroppo non approfondisce la critica del rapporto sbilanciato tra dispositivi e individuo, del vuoto legale che permane all’interno delle regolamentazioni delle piattaforme web, ma preferisce scagliarsi contro il bisogno espressivo dell’internauta. Seguendo il suo ragionamento, la sorveglianza di massa, le banche dati e tutti gli altri tipi di controllo di cui descrive il funzionamento sono la diretta conseguenza dell’attitudine esibizionistica dell’individuo. Nel saggio non viene mai menzionata la possibilità che questo bisogno espressivo sia necessario al confronto con l’altro e alla costruzione di un sé riconoscibile. Per questo motivo è bene ricordare che il rapporto tra soggetto e medium non si limita ad uno scambio pericoloso tra desiderio e informazioni. Per cercare di capire meglio il contesto mediatico attuale possiamo provare a ripensare la correlazione intima tra individui e media seguendo l’esempio di Yves Citton, una delle voci più originali della critica sociale contemporanea, nel suo recente Médiarchie[7].
Ispirandosi al concetto di medium di Walter Benjamin (il medium inteso come l’ambiente percettivo, il milieu interno e esterno, in cui agisce il soggetto[8]) e riattualizzando il pensiero di Marshall McLuhan, Citton descrive la compenetrazione assoluta tra uomo e medium. In questo senso i media digitali possono essere considerati estensioni delle sensibilità umane (parafrasando la celebre definizione di McLuhan) che modificano e sono modificati dal mondo che riproducono. Il titolo Médiarchie (Mediarchia) va pertanto inteso nel duplice valore che riveste il termine arché: i media come «principe» e come «principio».
All’interno di questo sistema mediatico universale, l’essere esposti non è più la conseguenza di un presunto esibizionismo, ma la condizione di partenza di ogni presenza sensibile. I nostri sensi prolungati attraverso i media digitali non possono far altro che condizionare ed essere condizionati dall’ambiente circostante. Si tratta di un fenomeno antecedente a qualsiasi pulsione desiderante[9]. A questo punto la sorveglianza online assume un’altra sfumatura. L’invasione nella nostra sfera privata è un’invasione nella nostra sensibilità. Ciò che è delineato, catalogato, archiviato è la nostra superficie sensibile. Nella collezione illimitata di dati viene tratteggiato il nostro profilo come superfice mediale, la nostra “pelle” digitale.
Secondo la prospettiva aperta da Citton, per rispondere all’invasività dei nuovi media non si tratta di limitare la nostra volontà desiderante, come invece lascia pensare Harcourt. Non è quella la causa scatenante. Qualsiasi forma di mediazione o di trasmissione produce un prolungamento dei nostri sensi che comporta inevitabilmente una perdita di controllo. L’evoluzione degli strumenti mediali e la loro democratizzazione hanno comportato un ampliamento del nostro campo sentivo-percettivo che ci rende inevitabilmente exposed. Tuttavia il rischio di essere visti senza poter vedere fa parte della nostra stessa corporalità. Il filosofo tedesco Hans Blumenberg descriveva il passaggio antropogenico alla postura bipede come un ampliamento incontrollato della visibilità umana carico di ambivalenza: l’uomo guadagnava una percezione elevata del mondo, ma allo stesso tempo si condannava ad una visibilità indifesa, offrendo ad esempio la schiena a potenziali aggressori. Allo stesso modo, se connettendoci al mondo online abbiamo guadagnato una visione ancora più ampia sul mondo esterno, questo ci ha reso inevitabilmente più esposti. Percepiamo e siamo percepiti in maniera più estesa.
Per questo motivo il “potere” (sorveglianza di stato, piattaforme digitali, agenzie di advertising…) non approfitta delle nostre debolezze edonistiche ma di qualcosa di molto più profondo e primordiale. Segmentato tra gli interstizi della rete, il potere registra, archivia, cataloga la nostra estensione virtuale. Poter seguire le nostre interazioni, le nostre preferenze, le nostre scelte, poter entrare in contatto con produzioni sensibili individuali permette il funzionamento del mondo online così come lo conosciamo attualmente, sia a livello economico (la pubblicità) sia a livello informatico (le varie forme di riconoscimento algoritmico che producono il paesaggio digitale in cui ognuno di noi si muove). In questo risiede il valore inestimabile delle nostre informazioni: nella loro capacità di produrre senso. Dal momento in cui queste informazioni non rispondono più al controllo dell’individuo che le rilascia, ma producono senso solo ed esclusivamente per le piattaforme ed agenzie in grado di raccoglierle si produce la frattura tra il sé analogico e il sé digitale di cui parla Harcourt.
Il nuovo fronte percettivo del sé digitale non risponde alle nostre sollecitazione ma appartiene a server e banche dati di cui ignoriamo persino l’esistenza ed è su questo punto che convergono infine le analisi di Citton e Harcourt: l’individuo contemporaneo è vittima di una nuova tipologia di alienazione e deve trovare il modo di riconquistare gli spazi mediatici con cui si confronta quotidianamente. Purtroppo le soluzioni avanzate dagli autori restano aleatorie: non si va oltre gli esempi di casi di resistenza isolati quali Edward Snowden, Chealsea Manning, gli hacker, difficili se non impossibili da replicare per la persona comune. Leggendo le ultime pagine dei due saggi quello che resta è la sensazione di inadeguatezza delle nostre risposte alle nuove condizioni mediatiche ed esistenziali che si sono venute a creare con l’avvento del mondo digitale. Aldilà della nuova pedagogia dei media immaginata da Citton – presupposto comunque inaggirabile di ogni ipotesi costruttiva – non sembra esserci nessuna prospettiva concreta di miglioramento. Gli open data o i consigli per la privacy elencati da Harcourt non sono altro che palliativi, come dimostra il caso Cambridge Analytica. Forse ciò che deve destare più preoccupazione è l’incapacità della critica di immaginare nuovi modelli interpretativi con cui predisporre una resistenza o, più prosaicamente, una convivenza con le nuove tecnologie.
[1] https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
[2] L’intervento del proprietario di Facebook Mark Zuckerberg : https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071
[3] Bernard Harcourt, Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2015, p.13
[4] Ibid. p. 228
[5] Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, L’estetizzazione del mondo. Vivere all’era del capitalismo artistico, Sellerio, Palermo, 2017. Si veda anche il nuovo volume appena pubblicato, Gilles Lipovetsky, Plaire et toucher. Essai sur la société de séduction, Paris, Gallimard, 2017.
[6] Harcourt cita a più riprese i documenti resi pubblici da Edward Snowden mettendo l’accento sul bassissimo costo delle nuove forme di sorveglianza di massa. Ad esempio PRISM il programma lanciato nel 2007 dalla NSA che permette l’accesso ai dati di Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple e altri ha un costo di “appena” 20 milioni l’anno. Per dare un’idea secondo le rivelazioni del giornalista Glen Greenwald nel 2010, grazie a PRISM e altri programmi, l’NSA era in grado di intercettare e archiviare 1,7 miliardi di messaggi al giorno tra mail, chiamate e altri tipi di comunicazione.
[7] Yves Citton, Médiarchie, Seuil, Paris 2017.
[8] Come proposto dalla lettura di Benjamin di Antonio Somaini in, ad esempio, A. Pinotti, A. Somaini, Cultura visuale immagini, sguardi, media, dispositivi, Einaudi, Torino 2016.
[9] Yves Citton fa esplicitamente riferimento alle ricerche di estetica sociale portate avanti da Barbara Carnevali, in particolare in Le apparenze sociali, Il Mulino, Bologna 2012.




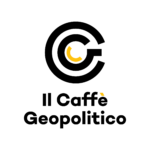




























Commenti recenti