Thomas Fazi, William Mitchell, “Sovranità o barbarie”
di TEMPO FERTILE (Alessandro Visalli)
Un libro importante e coraggioso, che affronta alcuni dei nodi fondamentali oggi davanti ai nostri occhi e che bloccano la nostra azione, costruito con un profondo sguardo storico e capace di ripercorrere in poche e dense pagine gli snodi che hanno costituito il presente. Il presente come storia, dunque.
A me pare che una delle chiavi interpretative del testo sia da rintracciare nella dialettica delle durate, proposta da Braudel nel 1949[1], tra increspature superficiali, movimenti lenti dati dalle trasformazioni dei rapporti di produzione e mutamenti del sentire collettivo ed evoluzioni tecnologiche[2], e, al fondo, trasformazioni del sistema naturale, lentissime ma potenti. Quel che compiono gli autori, per gran parte del testo, è quel che Cervantes[3] chiama scrivere di storia, “madre della verità”. Storia, cioè, come verità narrata; non ciò che avvenne, ma ciò che giudichiamo essere avvenuto[4]. Una narrazione nella quale compare il problema del nesso tra la volontà dei singoli, nella loro interazione reciproca, e i fattori determinanti inerenti le ‘durate’ più lente, le strutture nella loro dialettica. Quanto valgono i piani dei capi nello svolgimento di una battaglia? Quanto conta che Kutuzov si addormenti mentre altri fanno complessi piani in “Guerra e pace”[5]?
Ancora più, la storia narrata da Fazi e Mitchell è storia militante; serve, la loro narrazione, a scopi evidenti nel testo. Ma il pathos narrativo che appare evidente in ogni pagina (con la loro partecipazione emotiva e la tensione morale) è esso stesso strettamente parte della storia narrata. Perché, come sostengono gli autori, questa storia, la sua verità, ci riguarda e ci contiene.

Si sta parlando dunque del nostro presente, incorporato nell’imperialismo dell’economico e nella onnipresenza di una dinamica di contrazione (e di espansione per pochi privilegiati) che origina nella ‘crisi’ degli anni settanta. O meglio, come scrivono, “almeno” degli anni settanta.
Cosa finisce, insieme al regime di Bretton Woods e al “trentennio keynesiano”[6]? E soprattutto perché?
Un passo indietro, le stesse ‘conquiste’ keynesiane, sono frutto della rivoluzione intellettuale[7] di alcuni generosi e illuminati intellettuali, come lo stesso John Maynard Keynes, o Michal Kaleki, negli anni venti e trenta, e quindi dal rovesciamento intellettuale del paradigma neoclassico dei mercati autoregolati, o dall’insieme di fenomeni interconnessi che chiamiamo “Grande Depressione”[8] degli anni trenta?
L’insieme di politiche che Franklin D. Roosevelt promosse durante gli anni trenta in America, sostengono gli autori sulla scorta di una lettura di Riccardo Bellofiore[9] promuovono la domanda e ridefiniscono la produzione, e poi sono completate dall’enorme crescita della spesa pubblica in armi e uomini della guerra. Ma la svolta si ottiene, secondo la ‘teoria della regolazione’[10] sposata dai nostri, per effetto dell’alternanza di cicli di crescita contraddistinti da un paradigma industriale ed un ‘regime di accumulazione’ (ovvero un modello di produzione e consumo che consente l’accumulazione di capitale e dunque la stabilità[11]) a questi modelli corrisponde infine un “modo di regolazione”, leggi, istituzioni, regole…
Il regime fordista – keynesiano era dunque un simile ‘regime di accumulazione’, che ad un certo punto è venuto meno, ed era caratterizzato da un forte intervento dello Stato a sostegno dei processi di accumulazione. Il punto è questo: il sistema era costruito a vantaggio dell’accumulazione e non malgrado questa e scaturiva da una esperienza storica nella quale non era stata più possibile ed aveva provocato la Grande Depressione. Il keynesismo è, insomma: “il risultato della convergenza fortuita, nel secondo dopoguerra, delle ‘giuste’ condizioni sociali, politiche, economiche, tecniche e istituzionali” (p.27).
Esso, non fu, insomma, accettato a malincuore o imposto dalle lotte operaie (come immagina una influente corrente italiana), ma era indispensabile al modo di regolazione che garantiva la profittabilità degli investimenti e quindi il consenso anche dei ceti possidenti. Questo modello, con il vasto consenso sostanziale che lo contraddistinse (cosa che non impedisce ci fossero tensioni e lotte entro di esso tra chi voleva andare oltre e chi, invece, limitarlo), non era, in altre parole, affatto un’applicazione delle teorie keynesiane, ma in certo senso un tradimento. Come ricorda la Robinson, ma anche Minsky[12], fu opportunamente dimenticata la necessità di un certo grado di controllo degli investimenti e quindi della produzione. Le lotte operaie che andarono in quella direzione furono sempre aspramente osteggiate, anche dall’interno del movimento[13]. Invece tutte le nozioni più radicali della teoria keynesiana andarono perse nella formalizzazione matematica e nella successiva recezione da parte dell’accademia della cosiddetta “sintesi neoclassica”[14].
Ma negli anni settanta un diverso paradigma, pazientemente messo in piedi in alcune università fortemente sostenute da flussi di capitale privato e connesse con potentissimi think thank, emerge quasi improvvisamente. Si tratta del “monetarismo”, promosso da una pattuglia di docenti dell’Università di Chicago il cui più famoso esponente è Milton Friedman[15], concentrati sul valore della ‘libertà’ e la ripresa della vecchia tesi che i mercati tendono comunque ad autostabilizzarsi ed impiegare al meglio tutte le risorse di cui dispongono. Tra i punti fondamentali la teoria che ancora oggi determina la logica dell’austerità imposta all’Italia, troviamo il “tasso naturale di disoccupazione”, unico tasso (alto) di disoccupazione al quale corrisponde la stabilità dei prezzi, superato il quale, cioè, dovrebbe partire l’inflazione. Come dalla lunga tradizione liberista l’inflazione è, per i monetaristi, il nemico principale da combattere, anche al costo di avere milioni di disoccupati (viceversa il nemico principale per Keynes era la disoccupazione).
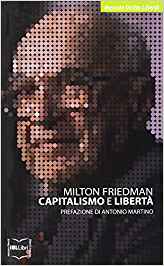
Ci fu in effetti una grande offensiva ideologica, ma non per questo il keynesismo “bastardo” del trentennio fu rovesciato, come disse anche Milton Friedman nella prefazione a “Capitalismo e libertà”[16], le idee dovevano aspettare le giuste condizioni[17]. Quando le condizioni generali che avevano indotto il precedente modo di regolazione vennero meno la tensione si scaricò in una rottura sistemica. I fattori sono molteplici, ma gli autori ricordano la crescente concorrenza intercapitalista (ovvero la perdita dell’egemonia economica americana), l’aumento del prezzo delle materie prime come conseguenza dell’accresciuta domanda, e della decolonizzazione in corso da decenni, un improvviso rallentamento della crescita della produttività, il clima politico con richieste crescenti dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Friedman ricorderà, invece, come visto, fattori economici e culturali come: l’appannamento nei confronti delle élite intellettuali e delle classi medie del fascino di Russia e Cina, la crisi dell’economia inglese, l’effetto demotivante della guerra del Vietnam, il senso di fallimento e di oppressione burocratica che si collegava con molti programmi del New Deal, divenuti dopo la ‘grande società’ di Johnson enormi e costosissimi, e quindi la tassazione oltre che l’inflazione derivante dalla bassa disoccupazione.
I limiti posti sotto attacco dai monetaristi sono visti, insomma, in parte come ‘oggettivi’, in quanto la crescita stabile dei salari non si coniugava più bene con la crescita dei profitti.
Nel vecchio mondo uno dei punti nei quali la tensione economica si scaricava era il sistema di Bretton Woods, e precisamente l’accordo di convertibilità delle monete, il cui tasso di cambio era fissato politicamente, in oro. Dato che i paesi in disavanzo commerciale subivano una pressione al ribasso delle monete erano costrette a sostenerle vendendo le riserve, oppure aumentare i tassi di interesse per attrarre capitali (ma in questo modo riducendo i prestiti, divenuti più costosi, deprimere l’economia ed aumentare la disoccupazione). In altre parole, quando andavano in disavanzo (le importazioni superavano le esportazioni) i paesi dovevano fare austerità.
C’era un’eccezione: gli Stati Uniti che quando andavano in deficit potevano semplicemente pagare le importazioni stampando altra moneta, in teoria avendo una scorta frazionaria di oro. Di fatto era però sul deficit di bilancia commerciale americano che il sistema poteva trovare equilibrio, ma l’ulteriore condizione era che questa massa di dollari che defluiva fosse affidabile. E la fiducia si basava sulla convertibilità in oro. Nel 1970 la cosa non era più sostenibile e crollò quando la richiesta di conversione della Francia (che aveva l’appoggio dell’Inghilterra) mostrò quale era il vero potere alla base del dollaro: la potenza americana, non ultimo militare. Nixon, infatti, in modo unilaterale e senza alcuna discussione, né opposizione, denunciò la convertibilità in oro, “sospendendola” (fino ad oggi).
La moneta diventa da ora ‘fiat’.
A questo punto gli Stati Uniti continuano ad essere in deficit commerciale, fornendo liquidità al mondo, ma i paesi che vendono merci al bulimico consumatore americano (ovvero quelli in surplus) per evitare che il dollaro con il quale sono pagati si deprezzi hanno, loro, l’onere di sostenerlo comprando i titoli di Stato Usa. Il legame si è, in altre parole, stretto ancora di più.
In questo contesto gli Stati occidentali si mossero per ridurre la fluttuazione monetaria (in Europa prima lo Sme e poi l’Euro) e nel contesto di stagnazione ed inflazione alta (importata e quasi eguale in tutti i paesi del mondo[18]) si affermò un diverso equilibrio economico intensamente voluto: quello che chiamiamo ‘neoliberismo’.
L’eccesso di produzione fu risolto non più con l’incremento della domanda interna, ma con l’esternalizzazione, la mondializzazione, la deregolamentazione; inoltre con l’ampliamento dei mercati, grazie alle privatizzazioni ed alla finanziarizzazione. Effetti sono la flessibilizzazione del lavoro, la compressione dei salari in occidente, esposti alla concorrenza delle importazioni di merci a basso costo prodotte all’estero dalle stesse imprese multinazionali occidentali (e quindi dalla minaccia della delocalizzazione), l’aumento costante della disoccupazione.
Chiaramente per transitare in questo nuovo mondo, nel quale le classi lavoratrici coltivate nel modello keynesiano erano sconfitte e sacrificate all’altare della redditività del capitale, era indispensabile che il potere guadagnato nel novecento attraverso il diritto di voto e le Costituzioni repubblicane, venisse neutralizzato. La cosa si ottiene promuovendo la cosiddetta “governabilità”, ovvero la depoliticizzazione del processo decisionale. Si passa alle post-democrazie[19] ed alla loro piena istituzionalizzazione da parte dell’Unione Europea.

La sinistra, dunque, sconfitta sul piano ideologico ed organizzativo, si acconcia a gestire le crisi del capitale per conto di quest’ultimo[20]. Aiuta a considerare tale strada inevitabile il rifiuto della proposta alternativa di Minsky ed alcune influenti letture, come la “crisi fiscale dello Stato”, proposta da O’Connor in un fortunatissimo libro[21], che non avendo ben compreso l’evento del ’71 (ma il libro è del 1973), presume che siano sempre le tasse a finanziare la spesa e quindi diagnostica un inseguimento costante e perdente tra queste e quella. Ne segue una ricezione ultrasemplificata nel mondo della sinistra (che per lo più orecchia e non legge davvero il libro) che recepisce il titolo come una “formula ad effetto”[22] e ne conclude che sia all’opera inevitabilmente un inseguimento tra spese richieste da vari gruppi sociali in imitazione reciproca e la reazione dei contribuenti chiamati a sostenere la stessa. Un altro libro chiave è “Sovranità nazionale in crisi” di Raymond Vernon che collega la perdita di autorità fiscale dello Stato alla crescita delle multinazionali, orientate dal progresso tecnologico dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Si afferma l’idea che le multinazionali sfuggano al controllo statale (mentre restano connesse con molti e diversi rapporti, ed in alcuni casi ne sono diretta emanazione) e che la mondializzazione sia determinata in ultima analisi da quel vettore del progresso che per l’occidente è sempre stato lo sviluppo tecnologico.
Le cose stanno diversamente, una più attenta ricostruzione storica mostra come siano piuttosto gli Stati, guidati da élite e ceti sociali che portano in primo piano i loro interessi, a intervenire attivamente nell’orientare il sistema mondiale verso l’interconnessione e alcuni generi di dinamiche competitive disciplinanti i lavoratori (e rassicuranti i consumatori). Un esempio è il governo Challagan[23], il primo a dichiarare morto il keynesismo e la fine del “mondo confortevole”. Quindi Mitterrand[24] con la sua repentina svolta negli anni ottanta. Ma ha un ruolo anche la vicenda cilena (1973) e la repentina caduta del governo Brandt[25].

Ma il libro, giustamente, si concentra particolarmente sull’Italia, spendendo alcune delle sue pagine più interessanti, in poco più di centotrenta pagine ripercorre analiticamente, con abbondante riferimento a testi scelti noti e meno noti, la storia economica e politica del paese dalla fine del ‘miracolo economico’ ad oggi. Il periodo 1948-73 si caratterizza per una crescita molto forte in assenza di inflazione trainata dalle esportazioni, dalla spesa pubblica, fino agli anni sessanta con tassi del 6% e poi rallentando. Fu determinante il ruolo dell’intervento pubblico, ed in particolare dell’IRI che realizza una imponente rete infrastrutturale e della grande industria (siderurgia, cantieristica, navigazione marittima, telecomunicazioni, energia elettrica, metalmeccanica). Quindi c’è la costituzione nel 1953 dell’Eni, sotto la guida di Enrico Mattei, ed il settore bancario con la separazione tra la gestione del risparmio e l’investimento che garantisce, per anni, l’orientamento del credito a fini sociali. Naturalmente, come in tutto lo schema di Bretton Woods, erano presenti controlli sui movimenti di capitali ed il finanziamento monetario della spesa pubblica. Tra i problemi che permanevano gli imponenti spostamenti migratori interni ed esterni (in uscita), e lo squilibrio civile ed infrastrutturale tra le diverse aree del paese (non solo al sud, ad esempio permanevano vari ‘sud’ interni anche al nord).
Come ebbe a dire Lelio Basso il sistema sociale ed economico era organizzato intorno al nesso tra la realizzazione del diritto al lavoro (sempre tendenziale e mai raggiunto) e la democrazia costituzionale (sempre imperfetta ed anche qui sede di confronto più che realizzazione). La “libera” iniziativa economica si doveva collegare, in base all’art 41 Cost, ai fini sociali che spettano all’indirizzo della legge. Una Costituzione che Guido Carli giudicò come “punto di intersezione fra la concezione cattolica e la concezione marxista dei rapporti tra società ed economie, tra società e Stato”, e che fu sempre orientato a superare.
Presupposto, come fu riconosciuto sia dallo stesso Basso, come da esponenti comunisti come Togliatti, di tale adempimento era la difesa della sovranità democratica. Il libro ricostruisce le posizioni dei partiti della sinistra italiana nei confronti del processo di unificazione europea, iscritto nella logica atlantica, e soggetto alle “evasioni sul giardino di infanzia delle illusioni federaliste”, come ebbe a dire Pietro Nenni nel 1948[26] o Lelio Basso nel 1949[27], denunciando la natura imperialista del nascente progetto europeo (natura mai venuta meno, se mai accentuata nel tempo) e quindi la necessità di difendere la sovranità e anche gli interessi nazionali. Ma anche, con sguardo lungo, la “decadenza del Parlamento”, perché, come naturale “i grandi Trusts e i grandi monopoli preferiscono risolvere i grossi problemi dell’economia, della finanza e della politica nel chiuso dei consigli di amministrazione e dei gabinetti dei ministri”. Fa parte di questo discorso, che abbiamo già letto[28], un significativo chiarimento sulla distinzione tra ‘cosmopolitismo’ e ‘internazionalismo’[29]. Analogamente, viene ricordata la posizione di Di Vittorio, nel 1952 sul “Piano Schuman” e l’industria italiana.
Questa fase inizia ad essere chiusa nel 1963-4, dall’azione della Banca d’Italia, che, in accordo con la parte conservatrice del governo, attiva non appena si presenta il ciclo di lotte operaie del 1962-3 nel nord ovest in piena occupazione, che nelle condizioni date porta all’aumento dei prezzi dei beni industriali, per non perdere margini di profitto e quindi le prime tensioni di bilancia dei pagamenti, una brutale manovra per arrestare gli investimenti, creare disoccupazione, e quindi riequilibrare per questa via i conti esteri. È il prototipo della stessa logica ancora all’opera.
Come scrive Guido Carli: “una crescita trainata dalla domanda estera costringe a una politica salariale restrittiva e attua una redistribuzione a favore di quei limitati settori industriali sottoposti alla concorrenza internazionale”.

Questo è il quadro nel quale l’Italia aderisce allo Sme non prima di aver attraversato la stagione di lotte operaie più aspra nel cui clima, siamo al 1975, le sinistre ottengono la “scala mobile” (indicizzazione dei salari all’inflazione, neutralizzandola e quindi scaricandola sulla rendita), lo Statuto dei lavoratori (con l’art 18), la riforma pensionistica, norme per la tutela del lavoro femminile, parità di trattamento tra uomini e donne, e soprattutto il servizio sanitario nazionale. Nel biennio 1976 -78 si svolge la scena della controffensiva: il governo vara misure di austerità finalizzate a ridurre il deficit commerciale, come al solito al prezzo dell’aumento della disoccupazione. In questo clima si arriva all’adesione allo Sme.
Gli autori si concentrano, nel raccontare quegli anni cruciali, sul ruolo del Pci, che nel 1975 aveva raggiunto il suo massimo risultato storico, e promosse la strategia del cosiddetto “compromesso storico”, per superare l’esclusione dal governo su una linea di minore conflitto con le forze atlantiste e cattoliche che da quaranta anni ininterrotti governavano il paese. Ci fu un forte dibattito interno di cui è paradigmatico il Convegno del Cespe del 1976. Lo scontro intellettuale si tenne tra il professore neokeynesiano Franco Modigliani e alcuni economisti non liberisti tra i quali Augusto Graziani, Domenico Nuti, Federico Caffè, Claudio Napoleoni, Massimo Pivetti. Per Modigliani la scala mobile era da abolire perché conduceva ad un aumento del salario reale (perché gli imprenditori, a causa della competizione, non riuscivano a scaricare sui prezzi interamente l’aumento) e ciò portava a perdere competitività e peggiorare la bilancia commerciale (dai due lati). Inoltre, secondo una tipica ipotesi neoclassica, la contrazione dei profitti avrebbe portato meno investimenti, e quindi in ultima analisi un danno alla stessa occupazione. Bisognava quindi accettare dei ‘sacrifici’ per l’interesse generale e lo stesso interesse dei lavoratori. La perdita di salario e di diritti, secondo una equazione da allora sempre riproposta, sarebbe stata compensata dalla difesa dell’occupazione e dalla fine dell’inflazione.
La tesi di Friedman, insomma, che proprio Modigliani contribuì a legittimare negli anni settanta.
La controtesi avanzata da molti, tra cui Caffè, e oggi ripresa ad esempio in forma contemporanea da Sergio Cesaratto[30], era che il livello salariale compatibile con la piena occupazione dipende da diversi fattori e non è univoco, come vorrebbe Friedman, ma nel breve periodo avrebbe comunque richiesto controlli sui movimenti di capitale e delle importazioni e una radicale riforma del sistema capitalistico.
La proposta di Modigliani, invece, da allora egemonica e che gli valse il nobel, era di accettare che ogni barriera dovesse cadere e tutti paesi dovessero alla fine equalizzare livelli del costo del lavoro (e dunque tenore di vita diffuso) per effetto della concorrenza.
Effetto inevitabile: i gilet gialli a Parigi.
Ovvero la distruzione della classe media occidentale, per uniformarla ad una ‘classe media mondiale’ naturalmente ad un livello di reddito e stile di vita notevolmente minore (oggi viaggia tra gli 8 e i 10.000 dollari all’anno). Questo è l’obiettivo reale della globalizzazione[31].
Il Pci, senza capire la reale portata della proposta ricevuta, scelse di proporre ai lavoratori “sacrifici senza contropartite”, e così fece il sindacato[32]. Fu in tal modo accettata l’idea di un inevitabile vincolo esterno, che ancora è dominante nell’establishment derivato da quella tradizione, e quindi della progressiva contrazione salariale, richiesta “dallo stato delle cose”. Completano questa visione l’accettazione dell’austerità come prospettiva generale[33] e la denuncia del ‘pericolo dell’inflazione’.
Questa svolta detta “dell’Eur”, è l’avvio del distacco, anche elettorale, del partito comunista dai ceti popolari e l’accettazione da parte sua della linea liberista. Che viene completata successivamente dalla denuncia della cosiddetta “spesa pubblica improduttiva”[34] e la “questione morale”[35].
Naturalmente la sinistra, che ancora nel 1978 per l’ultima volta si oppone ai meccanismi europei[36], completa la sua trasformazione aderendo alla prospettiva europea che gradualmente va a sostituire la prospettiva socialista. Seguirà il “divorzio” tra la Banca d’Italia ed il Tesoro[37], e le sue inevitabili conseguenze, tra le quali l’esplosione del debito pubblico.
Segue un aumento significativo del tasso di disoccupazione, che si porta dalle parti del 10% ed inizia una decisa compressione della quota salari e la crescita dell’ineguaglianza.
I passi successivi sono l’Atto Unico Europeo, firmato nel 1986 da Craxi e i passi successivi verso l’euro, negoziato per l’Italia da una delegazione formata da Guido Carli e Mario Draghi.
Il 1992 ci sarà quindi lo smantellamento della scala mobile da parte del governo Amato e la sospensione dello Sme, dopo l’attacco sui mercati. Seguirà la richiesta sempre più pressante di riforme ‘drastiche’, e la stipula del Trattato di Maastricht in condizioni che sono state molte volte raccontate[38]. Solo poche voci si alzano fuori del coro, tra queste Lucio Magri (p.147) e Giuseppe Guarino. Seguirà la più impressionante serie di riforme economiche di stampo neoliberale d’Europa e l’autentica distruzione dell’industria italiana (come disse De Cecco, p.164).
Queste riforme sono sistematicamente promosse attraverso la retorica messa a punto negli anni settanta: sacrifici, austerità, e vincolo esterno. L’Unione Europea diventa la soluzione ai problemi che non si riesce ad affrontare politicamente nel Parlamento o nel paese.
In effetti, come si sono trovati a dire in molti, aderendo all’euro gli stati membri si sono trovati ad essere ridotti al rango di colonia, attraverso la denazionalizzazione della moneta. Quel che si genera è, insomma, un sistema perfettamente adatto alla sua funzione, compiuto secondo il suo programma e del tutto completo. Un processo di integrazione al giusto livello per garantire gli esiti post-democratici resi necessari dalla grande paura degli anni settanta. Quella che gli autori chiamano “una dittatura di fatto” (p.184).
Non un vero sistema ordoliberale, ma ‘alla carte’, solo fino a che serve gli scopo dei più forti e in quei limiti.

Il resto della storia proposta da Fazi e Mitchell vede la Francia fallire il suo tentativo di controllare il processo europeo e la Germania prendere il sopravvento con la forza della sua economia da esportazione. Hanno rilevanza le riforme Hartz[39], nel comprimere la domanda interna e guadagnare spazi di competitività di prezzo non più neutralizzata dalla normale dinamica della moneta. Ma questa strategia economica, cosiddetta mercantilista, viene da lontano. È ricordata l’impostazione negli anni cinquanta di Ludwig Erhardt (p.210) e il processo brutale di unificazione tedesca.
Queste sono le dinamiche che determinano la cosiddetta “mezzogiornificazione” dell’Italia e l’emergere di una sorta di capitalismo comprador, che continua a perdere competitività per una costante riduzione degli investimenti. Le conseguenze generali del processo di adesione all’unione monetaria, anche considerando che manca il controfattuale, sono disastrose. Il prevalente disegno nordico di porre sotto controllo la concorrenza industriale del sud appare, con il senno di poi, di pieno successo; la crescita media italiana, che fino agli anni ottanta è la più alta d’Europa[40], negli anni novanta si arresta e diventa la più bassa d’Europa. Chi, sulla scorta di una perversione fossile dei vecchi modi di pensiero sedimentati nella sinistra, pensa che il rallentamento deriva da strutture antropologiche e orientamento al familismo amorale proprio della mancanza di una riforma protestante, o di altre consimili determinanti[41], ha l’onere di spiegare perché prima della svolta qui riassunta andava diversamente.
Anche la bassa produttività parte in realtà dalla metà degli anni novanta durante i quali accadono molte cose nel mondo, ma per tutti i paesi europei. Alcuni riescono a reagire meglio (alla crescita della mondializzazione, che, però, è un processo lento e progressivo, ed accelera casomai nei primi anni duemila, dopo l’adesione della Cina, non prima), altri peggio. Per reagire a stimoli esterni negativi (per la struttura del paese), del resto bisogna prima di tutto poter operare, e quel che succede in questi anni è una drastica riduzione delle leve di azione politica: fissaggio del tasso di cambio[42], stretta fiscale eterodiretta[43], liberalizzazione a partire dalla finanza[44], smantellamento e privatizzazione della base industriale strategica[45], deregolamentazione del mercato del lavoro[46]. Il crollo della produttività ha una relazione diretta con la rivalutazione della lira del 1995, fino alla fissazione a valori troppo alti. La bilancia commerciale tornata attiva nel 1993 torna negativa nel 2002, sono questi fattori, insieme alla scarsa crescita del mercato interno, sottomesso ad ondate successive di austerità, a pesare sulla situazione italiana molto più dell’apertura internazionale e della competizione dei paesi del sud-est (prima le tigri asiatiche negli anni novanta e poi la Cina)[47]. Ma conta anche la crescente flessibilità del lavoro, che lungi dal proteggere l’occupazione, induce a disinvestire in efficienza e tecnologia, impoverendo il lavoro e favorendo il posizionamento del paese su segmenti a basso valore aggiunto e scarsa competitività. Dal Pacchetto Treu, del 1997, al Job Act del 2014, per venti anni si è lavorato contro il posizionamento competitivo del paese, mentre la macchina gerarchizzante europea prendeva velocità.
L’Italia è come noto (fonte Ocse) il paese europeo che ha liberalizzato di più, mentre probabilmente, era quello che doveva farlo di meno soprattutto in assenza della possibilità di promuovere altre politiche industriali[48], ed in presenza dello smantellamento della grande impresa pubblica, che era l’unica, insieme all’università, a sua volta sacrificata, a fare ricerca industriale.
Insomma, gli autori, non senza aver analizzato la politica di Monti, rivolta ancora una volta alla ‘distruzione della domanda interna’[49], concludono su questo punto in questo modo: “dal punto di vista dell’establishment politico-economico italiano, il fatto che l’unione monetaria europea abbia comportato la deindustrializzazione e ‘mezzogiornificazione’ dell’Italia – a beneficio della Germania – e la retrocessione del nostro paese a un ruolo fortemente subordinato all’interno della gerarchia di potere europea, come era perfettamente prevedibile[50], è stato il prezzo da pagare (non da loro ovviamente) per ‘spezzare le reni’ ai lavoratori italiani ed espropriare la collettività tutta di una serie di beni materiali e immateriali. In questo senso, il regime economico post-Maastricht può essere accostato ad una forma di capitalismo comprador: un regime semicoloniale in cui le classi dominanti di un paese si alleano con interessi stranieri in cambio di rapporti di classe più favorevoli in patria” (p.238).
Uno strabiliante successo sotto questo profilo. E una ripetizione, peraltro, di una mossa che le élite italiane, in particolare del centro, ma anche del sud, compirono alla metà dell’ottocento[51].
La sinistra europea, erede della lunga tradizione del movimento dei lavoratori, gioca quindi un ruolo centrale nella transizione al neoliberismo, fornendogli una fondamentale legittimazione ideologica e quadri, ma anche ‘coprendola a sinistra’ e quindi rendendola molto più accettabile. Uno degli snodi messi in evidenza dagli autori di questo complesso e per certi versi misterioso puzzle, è l’idea che la mondializzazione non sia una scelta politica, derivante da una transizione egemonica multifattoriale, ma un aspetto ineluttabile della modernità, ovvero dello sviluppo materiale e tecnologico, destinato altrettanto inevitabilmente ad erodere la sovranità economica e politica degli Stati-Nazione. Quindi che le politiche ‘keynesiane’ erano giunte al termine del loro ciclo vitale e, se perseguite, assumevano un tono antistorico, e per ciò stesso reazionario. Si può verificare questa posizione su un arco amplissimo, da Renzi a Negri[52], per così dire, ovvero dal “nazionalismo in grande taglia” di molti, incluso Prodi[53] alla dissoluzione post-anarchica del potere nella ‘moltitudine’.
In qualche interprete più lucido[54] la cosa si collega con la liquidazione non solo delle conquiste dei lavoratori degli anni sessanta e ottanta, ma con l’intera parabola del novecento, riportando l’orologio della storia all’assetto del liberalismo ottocentesco all’ombra delle cannoniere britanniche (sostituite dalle portaerei americane).
È chiaro che in questo contesto, che ha notevole coerenza e profondità, il regime europeo realmente esistente è vantaggioso per alcune élite il cui stile di vita e tenore dipende strettamente dalla sua esistenza. Dunque un serio tentativo di riforma, molto semplicemente, potrebbe portare direttamente alla sua fine.
Gli autori vanno oltre: a loro parere “una riforma in senso democratico-progressivo dell’Unione europea e in particolare dell’Unione monetaria è non solo impossibile in termini pratici – come riconosciuto ormai anche da un numero crescente di economisti mainstream quali Joseph Stiglitz, Paul de Grauwe e altri, nonché da analisi di istituti europei come il Bruegel – ma anche inauspicabile dalla prospettiva del controllo democratico dell’economia” (p.252).
La soluzione a questi dilemmi è ricondotta in una mossa molto semplice: bisogna partire dal riconoscimento che non sono affatto ‘i mercati’ a ricattare gli Stati nazionali, ma casomai le oligarchie nazionali (incluso molte ex di sinistra) a ricattare surrettiziamente i lavoratori e le classi popolari, determinando uno schema di gioco nel quale queste possono solo perdere. Quindi bisogna compiere il percorso inverso e rifunzionalizzare lo Stato nazionale.
Ridemocratizzare e ripoliticizzare, dunque i processi politici ed economici come condizione necessaria per ritornare alla piena e buona occupazione. Quindi alla difesa ed espansione del welfare, la redistribuzione della ricchezza, attraverso la rinazionalizzazione di molte aree strategiche, etc[55].
Nella parte finale del libro questa prospettiva è connessa con un quadro teorico macroeconomico che parte dalla specifica caratteristica dei sistemi monetari ‘fiat’ (e dunque supera l’obiezione posta da O’Connor al quale schema mentale sono ancora connesse, dopo oltre quaranta anni, la maggior parte delle sinistre liberali): la possibilità di emettere moneta senza vincoli ex ante. Uno Stato realmente sovrano, in altre parole, non può mai finire i soldi. Questa è, a ben vedere, la minaccia all’egemonia di chi i ‘soldi’ (che sono, per loro stessa natura, rapporti sociali e quindi di potere) li ha, che si volle contrastare con la gabbia monetaria messa in piedi.
Se la capacità di spesa dello Stato non dipende direttamente dalle entrate fiscali i margini di libertà, pur non essendo infiniti, sono molto più ampi di quelli che sono scolpiti nelle regole giuridiche dell’eurozona. Più importante, non è inevitabile che se uno Stato è ‘troppo’ indebitato siano i ceti lavoratori a doverne fare sempre le spese.
L’eventuale ‘monetizzazione’ della spesa pubblica, ad esempio a fini di riequilibrio sociale o di incremento della produttività attraverso investimenti in infrastrutture, ricerca, istruzione, porterebbe la politica monetaria a liberarsi dell’incantesimo friedmaniano (inclusa la sua ossessione interessata per l’inflazione) per tornare ad essere “una componente della politica economica generale del governo, subordinata al sostegno di livelli occupazionali, al rafforzamento della protezione sociale e a una distribuzione del reddito più equa”[56]. Appare evidente a chi tale prospettiva può apparire deleteria ed a chi vantaggiosa.
Di seguito anche l’ossessione per una bilancia commerciale in attivo (nella quale, cioè, si esportano beni, vendendoli ad altri, e si acquisiscono capitali in misura maggiore rispetto a quella in cui si importano beni, aumentando il tenore di vita, in cambio di spesa diretta all’estero) sia automaticamente e sempre un danno è messa in discussione. Chiaramente un disavanzo estero di bilancia commerciale è accompagnato da un incremento di debito estero, ma quel che conta, caso per caso, è piuttosto se cresce o meno la capacità del paese di servire questo debito. Conta, cioè, per cosa si ha questo disavanzo: se va a finanziare investimenti, come dice il FMI, con “un prodotto marginale più alto del tasso di interesse che il paese deve pagare sulle proprie passività estere” (p.304), o no. Qualora si dia, comunque, una crisi di fiducia (sul modello delle ricorrenti crisi internazionali verso i paesi più vari) sarebbe comunque meno doloroso (per le classi lavoratrici) lasciar svalutare la valuta che non il lavoro.
Quest’ultima osservazione è esemplare, perché appare del tutto evidente che si tratta di punti di vista: è meno doloroso per le classi lavoratrici lasciar svalutare la moneta (e quindi la capacità di acquisto di beni esteri) che non il lavoro, ovvero i salari. E’ del tutto opposto per i ceti internazionalizzati e cosmopoliti che dispongono di ingenti risorse accumulate.
La tragedia della sinistra è tutta, interamente, qui.
[1] – In Ferdinand Braudel “Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II”,
[2] – Tratteniamoci dal porli in gerarchia secondo un mani davvero compreso schema ‘struttura/sovrastruttura’, anche i ‘modi di produzione’ sono incorporati nella società che li rende possibili, come il ‘sentire collettivo’ ne è insieme espressione e causa, per non parlare della tecnologia.
[3] – Nel capitolo IX della prima parte del “Don Chisciotte”.
[5] – Tolstoj, “Guerra e pace”, la battaglia è l’esito della miriade di comportamenti individuali o della struttura progettata dai capi nei loro conciliaboli?
[6] – Il trentennio del dopoguerra è lontanissimo, in realtà, dall’essere keynesiano. Si tratta di un punto di congiunzione altamente complesso di molte dinamiche diverse, dal completamento del passaggio di potenza dall’Europa agli Stati Uniti, al crollo della fiducia nella capacità autoequilibrante del mercato, ma anche la condizione dei debiti e crediti internazionali lasciata dalla guerra che, come scrive Kiran Patel in “Il New Deal”, “creò una complessa rete di passività che investì l’intero pianeta e intrecciò i destini di tantissimi paesi come mai era accaduto prima. Inoltre queste dinamiche attribuirono all’America il ruolo senza precedenti di banchiere mondiale” (p.36).
[7] – Nel testo è proposta questa sintesi: il livello generale dell’attività economica è determinato dalla ‘spesa aggregata’ (quantità di beni e servizi complessivamente richiesta dai soggetti economici e dal governo) e quindi un livello inadeguato determina un corrispondente insufficiente livello di produzione e inutilizzo dei fattori produttivi, in particolare del lavoro. Si genera un “equilibrio di sottoccupazione”. Infatti gli investimenti non sono funzione del risparmio (che cresce in queste condizioni, anche se solo nel vertice della piramide sociale) ma è il contrario, per risparmiare bisogna spendere. Insomma, “il governo ha sempre la capacità di determinare il livello generale di spesa e di occupazione di un’economia” e la piena occupazione diventa un credibile e perseguibile obiettivo politico. Cfr John Maynard Keynes “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta”.
[8] – Che viene attribuita in modo semplificato al crollo del mercato azionario del 1929 e quindi dallo scoppio dell’enorme bolla creditizia che si era accumulata nella ‘golden age’ degli anni venti.
[9] – Riccardo Bellofiore, “La socializzazione degli investimenti: contro e oltre Keynes”, in Alternative per il socialismo, aprile 2014.
[10] – Michel Aglietta “Règulation ed crises du capitalisme”, Parigi, 1976.
[11] – Il capitale deve crescere sempre per restare stabile.
[12] – Cfr. Hyman Minsky, “Keynes e l’instabilità del capitalismo”.
[13] – Cfr. “Le lotte operaie alla Fiat negli anni settanta: il lavoro e la questione del potere” e Bruno Trentin “La città del lavoro”
[14] – I cui passaggi furono il modello di equilibrio generale IS-LM di John Hicks e la versione addomesticata di Samuelson.
[15] – Di cui abbiamo letto “Liberi di scegliere” e ”La metodologia dell’economia positiva”.
[16] – Milton Friedman, “Capitalismo e libertà”, 1962.
[17] – Milton Friedman nella prefazione all’edizione del 1982 di “Capitalismo e libertà” (raccolta di saggi degli anni cinquanta), scrive, in riferimento al cambio di clima politico che ha fatto emergere il liberismo da lui difeso, che la disparità di trattamento alle sue idee (“Capitalismo e libertà” esce nel 1962 nel disinteresse generale, mentre “Liberi di scegliere”, che è inferiore per sua ammissione, esce nel 1980 e diventa subito un enorme successo) non è spiegata dalla differenza di qualità delle idee, né tanto o solo dai media (il secondo andò subito in televisione), quanto dal “cambiamento del clima intellettuale”. A sua volta questo non è determinato da libri (come “La via della schiavitù” o “La società libera” che cita come esempi significativi), ma, come dice, “dall’esperienza concreta .. la Russia e la Cina, un tempo la grande speranza delle classi intellettuali, avevano chiaramente deluso. La Gran Bretagna, il cui socialismo di stampo fabiano aveva esercitato un’influenza dominante sugli intellettuali americani, si trovava in una grande situazione di crisi. Entro i nostri confini gli intellettuali, immancabilmente fautori di uno Stato interventista e in gran parte sostenitori del Partito Democratico, si erano sentiti traditi dalla guerra del Vietnam e, in particolare, dal ruolo svolto dai presidenti Kennedy e Johnson. Molti dei grandi programmi di riforma, in passato assurti al ruolo di veri e propri vessilli, come i programmi assistenziali, l’edilizia popolare, il sostegno ai sindacati, l’integrazione razziale nelle scuole, l’assistenza federale all’istruzione, la ‘discriminazione positiva’ , stavano dimostrando il loro fallimento. il resto della popolazione era duramente colpito nel portafoglio dall’inflazione e da una tassazione eccessiva. Sono questi fenomeni, e non la capacità di convincimento delle idee illustrate in imponenti tomi teorici, che spiegano la trasformazione che ha portato dalla schiacciante sconfitta del candidato conservatore-libertario Barry Goldwater del 1964 alla travolgente vittoria di Ronnie Reagan nel 1980, sebbene i due uomini avessero sostanzialmente lo stesso programma e portassero il medesimo messaggio”. Dunque il libro, che pure ha scritto cercando di argomentare al suo meglio (che non è gran che), ha la funzione “di mantenere aperte le possibili opzioni fino al momento in cui le circostanze fanno sì che il cambiamento diventi necessario. Nelle organizzazioni e nei meccanismi istituzionali privati, ma specialmente in quelli pubblici, esiste un enorme grado di inerzia, una tirannia dell’esistente. Solo una crisi (reale o percepita) può produrre il cambiamento. Quando la crisi si verifica, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee disponibili. Questa, io credo, è la nostra funzione essenziale: sviluppare alternative alle politiche attuali, in modo che siano a portata di mano fino al momento in cui ciò che oggi è politicamente impossibile diventerà politicamente inevitabile”.
[18] – Una delle cose meno note, e pure a disposizione di una ricerca di pochi secondi, è che l’inflazione è quasi perfettamente sincronizzata in tutto l’occidente, dipendendo in grandissima parte da fattori strutturali mondiali, e non dipende, se non in minima parte, da fattori interni, come l’indisciplina dei lavoratori, le richieste dei sindacati, il sistema distributivo o la struttura industriale e via dicendo.
[19] – Termine proposto da Colin Crouch.
[20] – Si veda anche per questa narrazione: L.Paggi, M.D’Angelillo, “I comunisti italiani ed il riformismo”, Aldo Barba, Massimo Pivetti, “La scomparsa della sinistra in Europa”, Jean-Claude Michéa, “I misteri della sinistra”.
[21] – James O’Connor, “La crisi fiscale dello Stato”.
[22] – Come dirà Federico Caffè nella prefazione del 1979: “Vi sono casi in cui la suggestione del titolo di un volume finisce per assumere un significato largamente svincolato dal contenuto effettivo dell’opera. L’esempio più illustre mi sembra costituito dall’ “Economia del benessere” di A Pigou, espressione adoperata, nel corso del tempo con un’evasività e un’ambiguità di connotazioni del tutto estranee alla minuziosa e precisa sottigliezza del testo. Analogo pare essere il destino di questo libro di O’Connor. Il titolo è divenuto, infatti, una specie di formula ad effetto che non riguarda esclusivamente gli specialisti di problemi fiscali, ma chiunque si occupi, in genere, dell’azione dei pubblici poteri nel campo economico.
[23] – Challagan nel 1976, ben prima della Thatcher, si trova a confrontarsi con quella inflazione galoppante e mondiale che è il sintomo di molti mali e viene trainato dal raddoppio del prezzo del greggio nel biennio 1973-74 (Guerra del Kippur e formazione del cartello dei produttori) e con le conseguenze della tempesta avviata quasi dieci anni prima dalle conseguenze dello squilibrio commerciale e finanziario americano, esposto per 70 miliardi (una delle ricostruzioni migliori delle conseguenze in Amato e Fantacci “Fine della finanza”). La sospensione della convertibilità del dollaro in oro, pilastro del sistema di Bretton Woods, apre quindi la guerra delle valute e delle reciproche svalutazioni competitive. L’oro arriva in poco tempo a moltiplicare per dodici il suo valore e il dollaro perde il 30% sul Marco e il 20% sullo Yen, il petrolio sale di dieci volte in otto anni (da 3$ nel 1971 a 30$ nel 1979), ma non solo, la bauxite del 165%, il piombo del 170%, lo stagno del 220%, l’argento di dieci volte. Questo aumento delle materie prime, in termini del potere di acquisto delle monete e in termini reali (per effetto di mutati rapporti di forza e anche della decolonizzazione che aveva preso tutto il ventennio precedente) porta un aumento dei costi di produzione, dell’inflazione e quindi anche della disoccupazione. Agisce, cioè, come potente motore di ridisciplinamento; contribuisce anche la politica monetaria imposta, come surrogato di altri mezzi di offesa, da Volcker a partire dal 1978 (viene nominato da Carter) il quale avvia coscientemente “una disintegrazione controllata nell’economia mondiale”, come dirà, innalzando i tassi della FED e lavorando per contenere i costi della manodopera. Challagan sceglie di ascoltare chi indica la necessità di lasciare i vecchi obiettivi di politica economica e sociale, imperniati sulla piena occupazione e la giustizia sociale, per concentrarsi invece sulla lotta alla inflazione che presuppone l’abbandono della logica keynesiana. Nello scontro culturale che seguì con l’ala sinistra del Partito Laburista (rappresentata dall’indimenticato Tony Benn) una “Alternative Strategy” fatta di controllo delle importazioni per dare il tempo ad appropriate politiche industriali di condurre alla trasformazione della struttura produttiva, riducendo l’enorme deficit commerciale del paese, perde e viene accantonata in favore di un approccio deflazionario che abbandona le classi lavoratrici al loro destino. L’esito sarà, nel “Winter of discontent” della base elettorale del partito, quindi il disastro del 1979 e la vittoria della Thatcher.
[24] – Si veda “Francois Mitterrand e le svolte degli anni ottanta”.
[25] – Nel 1973, si era avuto sia la feroce repressione degli esperimenti cileni (il cui impatto, quale monito, fu rilevante almeno in Italia) sia la repentina caduta nel 1974 del governo socialdemocratico di impronta keynesiana di Willy Brandt in Germania e la sua sostituzione con il più “Atlantico” governo di Schmidt. In Italia, intanto, i tentativi del PCI di avvicinarsi alle componenti “più progressiste” della Democrazia Cristiana, e di accreditarsi come forza responsabile, incontrano la dura opposizione di La Malfa e Guido Carli, che negoziano un prestito al FMI per indurre un vincolo esterno, rappresentato dalla “Lettera di impegni” che obbligava a politiche fortemente deflattive. Le pressioni economiche indotte dall’esterno sono utili ad impedire ogni politica di redistribuzione, di espansione e piena occupazione, che dal punto di vista dell’establishment economico-politico al governo sarebbe solo utile a spingere ulteriormente i prezzi, quindi ridurre i profitti e dunque accumulazione del capitale e quindi investimenti. A seguito di questa strategia il PCI fu messo davanti al fatto compiuto; ad esempio, nella visita in USA il 6 e 7 dicembre 1976, Andreotti mette sul tavolo del FMI e del Tesoro un denso documento preconcordato di 54 pagine (oggi nell’Archivio Andreotti) che articola una politica di “risanamento” fortemente basata su incremento della tassazione e contenimento delle pressioni sociali e sindacali. La manovra mette i comunisti nelle condizioni di dover accettare “sacrifici senza contropartite”, seguirà “l’affare Moro” e quindi l’adesione allo SME.
[26] – Seduta del 2 dicembre 1948.
[27] – In occasione dell’accordo per la costituzione del Consiglio d’Europa.
[28] – Vedi “13 luglio 1949, Lelio Basso, ‘internazionalismo e nazione’”.
[29] – Come dice: “So che a questa nostra impostazione si è fatta e si fa questa obiezione: ma allora, voi socialisti avete abbandonato l’internazionalismo, siete diventati i difensori e custodi gelosi della sovranità dello Stato, che è una concezione ormai superata? Ebbene, no: noi siamo fermi più che mai nella nostra posizione internazionalistica: noi siamo sempre perfettamente coerenti con la nostra concezione. Noi sappiamo che Marx scrisse: «gli operai non hanno patria», ma Marx ci insegnò altresì che il proletariato deve acquistare la sua coscienza nazionale e che esso l’acquista a misura che esso si emancipa, a misura che esso strappa dalle mani della borghesia l’esercizio esclusivo del potere politico e si presenta sulla scena della storia come classe che esercita la pienezza dei suoi diritti. Perciò l’internazionalismo del proletariato si fonda sull’unità e sulla solidarietà di popoli in cui tutti i cittadini, attraverso l’abolizione dello sfruttamento di una società classista, conquistano la propria coscienza nazionale.
In questo senso, oggi, la lotta che combattiamo sul terreno della lotta di classe, la lotta per l’emancipazione del proletariato è un tutt’uno con la lotta per difendere il nostro paese dalla invadenza del capitalismo americano. I lavoratori che lottano, lottano congiuntamente contro lo sfruttamento di classe e contro lo sfruttamento che di essi pretende fare il capitalismo americano, il quale vuole essere associato al capitalismo nostrano nella spartizione dei profitti ottenuti attraverso lo sfruttamento delle classi lavoratrici.
Noi sappiamo che in questa lotta il proletariato combatte insieme per due finalità e che in questa lotta esso acquista contemporaneamente la coscienza di classe e la coscienza nazionale ponendo le basi per un vero internazionalismo, per una federazione di popoli liberi che non potrà essere che socialista! In altre parole, il movimento operaio si inizia in un’epoca in cui l’operaio è quasi posto al bando della società, in cui l’operaio è sfruttato fino al punto di essere praticamente escluso da ogni diritto da una classe che in questo modo gli nega veramente l’appartenenza alla patria, in quanto fa dello Stato e della nazione uno strumento della sua politica e uno strumento del suo dominio e del suo sfruttamento, ma l’evoluzione del movimento operaio porta il proletariato ad inserirsi sempre più vivamente nel tessuto della vita nazionale per strapparne il monopolio alla borghesia, e fa coincidere sempre più la lotta per l’emancipazione, la lotta di classe con l’acquisto della coscienza nazionale, nel senso che toglie alla nazione il carattere di espressione esclusiva della classe dominante”. E dunque, di seguito: ““Ma così come il sentimento nazionale del proletariato non ha nulla in comune con il nazionalismo della borghesia, così il nostro internazionalismo non ha nulla in comune con questo cosmopolitismo di cui si sente tanto parlare e con il quale si giustificano e si invocano queste unioni europee e queste continue rinunzie alla sovranità nazionale.
L’internazionalismo proletario non rinnega il sentimento nazionale, non rinnega la storia, ma vuol creare le condizioni che permettano alle nazioni di vivere pacificamente insieme. Il cosmopolitismo di oggi che le borghesie, nostrana e dell’Europa, affettano è tutt’altra cosa: è rinnegamento dei valori nazionali per fare meglio accettare la dominazione straniera”.
[30] – Si veda Sergio Cesaratto, “Sei lezioni di economia”.
[31] – Si può vedere la franca dichiarazione di Spence, al termine del suo libro, “La convergenza inevitabile” o più di recente di Milanovic in “Ingiustizia globale”.
[32] – Si veda, ad esempio, l’intervista di Luciano Lama nel 1978 ed il post “Sacrifici senza contropartite, il biennio 1976-78”.
[33] – Si veda l’ambiguo discorso condotto in proposito da Berlinguer sulla “Austerità”, nel 1977.
[34] – A rigore in termini keynesiani non esiste, e non può esistere una spesa pubblica improduttiva. Ogni spesa è il reddito di qualcun altro, e comporta un qualche effetto di moltiplicazione e di attivazione.
[35] – Come noto al centro dell’azione dell’ultimo Pci, in particolare dopo il fallimento del tentativo di andare al governo con il “compromesso storico” e gli anni del cosiddetto “pentapartito”.
[36] – Il Pci vota in modo contrari all’adesione allo Sme, anche se in un complesso contesto di trattativa e in seguito di rottura con il governo. Sono i mesi nei quali fallisce il “compromesso storico” e viene prima rapito e poi ucciso Aldo Moro.
[37] – Si veda “Beniamino Andreatta, il divorzio”.
[38] – Si veda questa lettura analitica della discussione parlamentare.
[39] – Si può leggere, per un quadro generale della politica tedesca del dopoguerra, Massimo d’Angelillo, “La Germania e la crisi europea”.
[40] – Chi ha memoria può riandare ai toni trionfali con i quali, sotto il governo Craxi, l’Italia, sentendosi in crescita costante, si appresta a superare l’Inghilterra.
[41] – La cui versione pop è il “casta e corruzione” dei fortunati libri dei primi anni duemila.
[42] – Appunto con la moneta unica.
[43] – E quindi impolitica.
[44] – Una sorta di istituzionalizzazione della fuga di capitali e quindi di stretta dipendenza delle scelte dalla necessità di frenarla e di attrarne, piegandosi ad ogni ditkat.
[45] – Attraverso la liquidazione dell’Iri, e più in generale la stagione delle privatizzazioni degli anni novanta, giustificata apparentemente con la necessità di ridurre il debito pubblico, in realtà per ampliare lo spazio del mercato, presunto più efficiente.
[46] – Attraverso reiterate riforme sempre in direzione di promuovere la flessibilità, e quindi il precariato.
[47] – Cfr Antonella Stirati, “Distruzione dei ceti medi e redistribuzione del reddito”, in Micromega 4/2017.
[48] – Politiche che paesi virtuosi (e ‘protestanti’) come la Germania non hanno mai smesso di promuovere, con apprezzabile senso pratico.
[49] – Al fine di riportare la bilancia commerciale in attivo per la via più breve, la contrazione delle importazioni e dunque del tenore di vita degli italiani, anziché per quella più sana, l’avvio di un pacchetto serio di politiche strutturali rivolte a favorire ricerca, innovazione, investimenti pubblici e privati.
[50] – E previsto, sin dagli anni settanta, anche dai successivi cantori del nuovo ordine: cfr. “Eugenio Scalfari, 1978, ‘parole al vento’ il dibattito sullo Sme”.
[51] – Si veda, ad esempio, “La questione dell’unità e della nazione”.
[52] – Sul quale gli autori spendono alcune pagine critiche.
[53] – Si veda “Angolature di nazionalismo: Prodi, il sogno europeo e il nemico americano”.
[54] – Come, ad esempio, Padoa-Schioppa la cosa si prolungava fino a riconoscere che il welfare doveva essere abbandonato e ripristinato l’assetto di classe e la divisione del lavoro dell’ottocento, si veda “Tommaso Padoa-Schioppa, interventi prima e dopo la crisi”, partendo da una diagnosi del keynesismo come ‘eccesso’ e della globalizzazione come ‘frutto della tecnologia e di impulsi umani che si possono disciplinare, non sopprimere’, nei suoi interventi legge lo Stato europeo come una necessità per affrontare i problemi ‘mondiali’. In un giustamente famoso intervento del 2003 sul Corriere della Sera ebbe a dire che bisognava “lasciar funzionare le leggi del mercato, limitando l’intervento pubblico a quanto strettamente richiesto dal loro funzionamento e dalla pubblica compassione”, e, in riferimento specifico alle riforme di Schroder (che aveva tenuto il discorso di lancio dell’Agenda 2010, davanti al Bundestag) definisce il suo campo di azione in questo modo: pensioni, sanità, mercato del lavoro, scuola. In tutti questi settori “attenuare quel diaframma di protezioni che nel corso del ventesimo secolo hanno progressivamente allontanato l’individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o il premio ai suoi difetti o qualità”.
[55] – L’elenco è a pag. 284-5
[56] – Massimo Pivetti, Micromega 4/17, cit. pag. 293






























Commenti recenti