Cina, nuova potenza egemone neoliberista o socialista e cooperativa?
di L’ANTIDIPLOMATICO
La Redazione dell’AntiDiplomatico ha rivolto alcune domande a Diego Angelo Bertozzi, autore di “Cina da sabbia informe a potenza globale” e assiduo collaboratore del nostro sito. La Cina di oggi è un fenomeno di cui molti (s)parlano con poca cognizione di causa. Questo libro vi aiuterà a trovare le giuste direttive per orientarvi.
Quando viene gettato il primo seme della Cina di oggi?
Se parliamo della Cina popolare non possiamo che fare riferimento a quello che oggi conosciamo come “socialismo dalle caratteristiche cinesi”. E questo vede il suo battesimo durante la Lunga marcia, per precisione nella conferenza di Zunyi del 1935 che certifica il ruolo di primo piano del giovane Mao. Qui si avvia il processo di “sinizzazione” del marxismo, vale a dire la sua applicazione alle condizioni specifiche del proprio Paese senza fare “affidamento su consigli di gente venuta da fuori o su un sapere libresco”. È lo stesso anno nel quale, di fronte all’aggressione giapponese, viene lanciata la politica del Fronte unito con la borghesia: nelle basi rosse nasce quella repubblica popolare che, in nome della liberazione nazionale, non abolisce la proprietà privata e coopera con il capitalismo nazionale per sostenere lo sviluppo economico e la resistenza. Una politica, quella del Fronte unito, che ancora oggi è al centro dell’azione politica comunista.
I problemi interni, l’aggressività del Giappone, la presenza Usa hanno contribuito a creare una sensazione di accerchiamento nel governo cinese?
Ci sono a proposito pochi dubbi: il Pivot to Asia lanciato dall’amministrazione Obama con la conseguente riattivazione delle alleanze e delle partnership militari ricorda al governo cinese quel “serpente” che la accerchiava all’indomani della guerra di Corea. C’è il timore che la revisione della costituzione pacifista del Giappone possa portare ad un rinnovato protagonismo militare nipponico e che le spinte indipendentiste in Tibet e Xinjiang, benché minoritarie, possano essere utilizzate per progetti di disintegrazione di una unità territoriale riconquistato dopo un secolo di lotte. In questo senso delicata è la situazione di Hong Kong, con la nascita di movimenti “indigeni” che mettono proprio in discussione l’appartenenza alla Cina. Va tuttavia sottolineato che, diversamente dagli anni Cinquanta, la Cina non è più un “paria” del sistema internazionale: è parte attiva del commercio internazionale, è attore politico di primo piano capace di creare nuovi organismi internazionali e, soprattutto, rappresenta un indispensabile partner economico per tutti gli alleati statunitensi in Asia orientale.
Nel tuo libro confuti il parallelismo Hitler-Mao… Potresti approfondire questo concetto.
La liquidazione della figura di Mao e la sua riduzione a semplice mostro al pari di Hitler è un’operazione superficiale e semplificatoria – da contabilità numerica – che impedisce la comprensione di un progetto di liberazione e riscatto nazionale, avvenuto per di più in un contesto di isolamento internazionale e persistente minaccia bellica. Tragedie e fallimenti, con il loro portato di morte, come il Balzo in avanti e la stessa Rivoluzione culturale, non sono il frutto di una pianificata operazione di sterminio dell’avversario preannunciata e poi messa in pratica, come fu per il nazismo. Furono terribili errori ai quali la stessa dirigenza comunista mise termine. Va poi ricordato come lo stesso Mao guidò una parte del Paese nella resistenza contro un progetto di schiavizzazione e sterminio messo in atto a partire dal 1937 dal Giappone alleato della Germania hitleriana. A rigettare questo parallelismo sono storici e studiosi come Linda Benson e Maurice Meisner, non certo teneri verso il comunismo cinese.
Cosa intendi per fase “prosaica” del socialismo all’indomani della fine della Rivoluzione culturale?
Si ritorna agli esordi della Repubblica popolare cinese, alle prime indicazioni politiche dello stesso Mao (per questo non ha senso parlare di un “tradimento” rispetto alla sua figura): allo slancio rivoluzionario, all’imperativo di bruciare le tappe nel nome del comunismo, all’insistenza sull’ideologia rispetto alle capacità, segue una politica di riforma che, senza abbandonare il richiamo al marxismo e al socialismo, punta sulle capacità tecniche, sull’acquisizione di sapere scientifico e tecnologia, sui rapporti con l’Occidente fino a poco prima nemico giurato, sulla collaborazione con le nuove figure sociali emerse via via negli anni dello sviluppo economico, sulla fine dell’isolamento internazionale per porsi il problema – una novità nella storia de socialismo reale – della creazione di uno stato di diritto.
Dedichi un lungo paragrafo al “mito Tienanmen”. Ritieni decisivo l’influsso occidentale nel definire i contorni della protesta di quel 1989?
Specifico subito: uso il termine “mito” non per negare la repressione avvenuta nel giugno del 1989, ma per sottolineare – sull’onda di testimonianze di inviati dell’epoca e protagonisti – come esiste una sorta di versione mitica che ancora perdura: la repressione ci fu ma non ebbe nella grande piazza di Pechino il suo teatro principale. In questo senso va il racconto di inviati del Washington Post e del New York Times, come di alcuni diplomatici. Non va poi sottovaluta l’operazione di selezione della memoria rappresentata dall’immagine simbolo di quei giorni: il ragazzo che ferma il carro armato.
Ma ci si deve chiedere: perché lo stesso trattamento non viene riservato alle tante immagini di giovani soldati brutalmente uccisi, dati alle fiamme, ed esposti pubblicamente? Forse perché in contraddizione con un oleografico racconto pacifista della ribellione? Eppure basterebbe leggere (anche in edizione italiana) le rivelazioni dei Tieanmen Papers.
Influsso occidentale? Le cause della ribellione non possono che essere interne (inflazione galoppante, fine delle precedente garanzie sociali, l’emersione di una agguerrita classe imprenditoriale), ma è indubbio che in quei giorni diversi governi occidentali sperano che la rivolta possa portare alla fine del regime comunista e quindi si attivano per sostenerla, sia con mezzi che con finanziamenti, e sfruttano le divisioni interne all’establishment comunista.
A tuo avviso la Cina è appiattita su posizioni economiche neoliberiste?
Personalmente – ma non sono certo l’unico – ritengo la Cina un Paese prevalentemente socialista che ha trovato nel mercato uno strumento utile per la fuoriuscita dal sottosviluppo e la propria modernizzazione. Uno strumento appunto, quale è, al contempo, quello della pianificazione che ancora prende la forma di un piano quinquennale. Uno strumento chiamato a dare risultati in un contesto nel quale lo Stato detiene la proprietà del suolo, delle industrie in settori strategici, anche del credito, e rilancia la guida politica nella proiezione internazionale delle grandi aziende statali, alle quali non vuole rinunciare. Va inoltre aggiunto che gran parte dei capitalisti cinesi sono cooptati politicamente nelle strutture di governo come di partito, e quindi per ora tenuti sotto controllo ed egemonizzati. Possono certo arricchirsi – e arricchire il Paese – ma ad oggi restano espropriati dal punto di vista politico. Una “diversità” del modello cinese che ora si riflette anche negli equilibri internazionali: la nuova banca di investimento (AIIB) non chiede, in cambio di prestiti, condizioni come liberalizzazioni o privatizzazioni, a differenza di strutture simbolo del liberismo con Fmi e Banca mondiale. Un liberismo ben strano, insomma.
Racconti di un diverso approccio al ruolo storico e politico di Stalin e Mao: uno dei motivi per il quale la Cina non ha fatto la fine dell’Urss?
Non solo questo, ovviamente. Ma è indubbio che il crollo dell’Urss sia ancora in questi giorni oggetto di riflessione da parte della dirigenza comunista cinese, con una attenzione particolare rivolta al piano ideologico, alla fedeltà ai principi cardine, alla solidità del partito e in questo rientra la valutazione e non la condanna della figura del Grande Timoniere. All’inizio del secolo sono stati istituiti due appositi gruppi di studio nell’ambito dell’Accademia di scienze sociali e il loro è un lavoro di ricerca ritenuto “tema nazionale fondamentale”. Come rileva lo studioso australiano Kerry Brown se per noi occidentali la caduta del Urss è un “fatto storico”, per la Cina è “una lente attraverso la quale analizzare la politica di riforma e apertura”. In sostanza il Pcc è da decenni impegnato in un processo di apprendimento permanente finalizzato ad evitare la fine miseranda del regime sovietico e alla conservazione del suo ruolo di guida anche nel pieno di un profondo processo di riforma. Un esempio: la capacità di aprirsi e riconoscere il ruolo alle nuove forze sociali emerse con lo sviluppo economico a doppia cifra.
Nell’approccio al multipartitismo la Cina non pensa alla competizione, ma alla collaborazione tra partiti non antagonisti. Quindi un rifiuto della democrazia occidentale?
Un aspetto è certo: per quanto la Cina popolare abbia ormai alle spalle lo “stato di eccezione”, e con questo anche i campi di lavoro, e sia impegnata a tutelare progressivamente maggiori libertà, non diventerà mai una il luogo della competizione fra partiti. La democrazia – si tratta della posizione ufficiale cinese – è il frutto di un percorso storico interno, delle diverse condizioni di ogni Paese, e non il portato di imposizioni esterne. Si parla certo di democrazia nelle riflessioni anche più attuali che riporto nel testo, di un minimo di competizione tra candidati a livello base, ma l’accento è posto più sull’aspetto consultivo e cooperativo tra partiti e settori della società che non mettono in discussione il sistema socialista. Si punta quindi a creare un sistema di democrazia consultiva con procedure razionali e a maglia larga nella quale sia moltiplicati i canali tra governo e organizzazioni sociali e gruppi di cittadini.
Nel prossimo futuro vedi una Cina potenza egemone?
Quello cinese, anche ora, è sempre stato un discorso anti-egemonico: nessun Paese ha il diritto di imporre il proprio modello politico e sociale ad altri Paesi. Su questa linea non avremo di fronte a noi una nuova potenza egemone, semmai la sua indubbia crescita a livello economico e politico porterà a forti cambiamenti nella struttura di “governo” del sistema internazionale, chiudendo definitivamente il periodo dell’indiscussa egemonia statunitense e riportando al centro principi giudicati inviolabili come la sovranità e l’integrità nazionale e il diritto all’autonoma scelta della via di sviluppo. Non è un caso che l’influente rivista statunitense National Interest in anni recenti, proprio di fronte alla crescita cinese, ha lanciato l’allarme per un possibile ritorno ad un “equilibrio Vestfaliano” fondato su sovranità nazionale e intervento pubblico nell’economia. In questo senso non va sottovalutato la forza di attrazione che la fuoriuscita dal sottosviluppo compiuta dalla Cina esercita su diversi Paesi ancora in lotta contro fame e povertà.



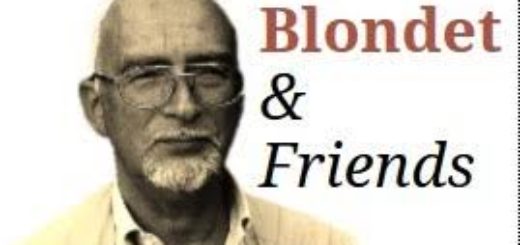




























Commenti recenti