Pubblichiamo la versione italiana dell’intervista realizzata da Vincent Dain a Samuele Mazzolini e pubblicata originalmente dal media francese Le Vent Se Lève il 4/12/2017.
Le elezioni municipali di giugno 2017 sono state vinte in modo netto dai due principali partiti di destra: Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega Nord di Matteo Salvini. Benché distanziate nei sondaggi nazionali dal Movimento 5 Stelle (M5S) e dal Partito Democratico (PD), le destre italiane sembrano avere il vento in poppa. Quali sono gli orientamenti e le strategie rispettive di queste due formazioni?
In effetti le destre italiane erano state date per morte troppo presto e le elezioni municipali di giugno 2017 l’hanno dimostrato, così come l’hanno fatto le recenti elezioni regionali in Sicilia. Con la caduta del governo di Berlusconi nel 2011 e una serie di scandali coevi che hanno interessato la Lega Nord, la destra ha vissuto certamente uno sconquasso, ma è riuscita a rientrare in carreggiata. Partiamo dalla Lega Nord che ha compiuto un vero e proprio exploit. Pochi giorni fa è stato definitivamente sancito che il suo nome sarà Lega e non più Lega Nord. Questa trasformazione nominalistica suggella un processo avviato dal segretario Matteo Salvini sin da quando ha preso le redini del partito nel 2013. In nuce, il progetto salviniano è quello di trasformare il proprio partito nel corrispettivo italiano del Front National di Marine Le Pen, con la quale – non a caso – ha mantenuto in questi anni una stretta vicinanza. Non più, quindi, un partito che si occupa di rivendicazioni regionaliste, a trazione settentrionale e con tinte secessioniste, bensì un partito nazionale che offre un discorso a uso e consumo di tutto il Paese. Internamente, Umberto Bossi – il fondatore della Lega – è stato messo in minoranza, anche se l’ampia vittoria del referendum sull’autonomia del Veneto promossa dal governatore Zaia ha parzialmente rimescolato le carte.
In cosa consiste la proposta salviniana? Il punto nodale che l’ha caratterizzata, sulla falsariga del caso francese, è sicuramente il tema immigrazione. Questo sentimento di insofferenza nei confronti del flusso migratorio che interessa il nostro Paese esisteva già e il suo aumento esponenziale non ha di certo aiutato, ma Salvini è stato capace di esacerbarlo a livelli preoccupanti. In più ha avuto la destrezza di impossessarsi di alcune lotte che non hanno un vettore ideologico dato, come l’opposizione alla riforma pensionistica di Elsa Fornero e l’euroscetticismo. Bisogna riconoscere che è un politico abilissimo, con uno stile comunicativo immediato e che fa della ripetizione e di alcune trovate eccentriche le sue maggiori risorse. Penso che, sebbene in termini contenutistici sia un vero obbrobrio, ci sia molto da imparare in quanto a capacità di creazione del consenso. Trova tuttavia un ostacolo ancora molto pesante nel proprio passato: banalmente, i video in cui Salvini intona canzoni contro Napoli e il sud non possono essere cancellati. Ogni sua apparizione in Meridione è accompagnata da mobilitazioni di protesta molto sentite. Sebbene abbia aumentato il suo consenso elettorale lì dove una volta il simbolo del partito non appariva nemmeno sulla scheda, la trasformazione in un vero partito nazionale non è ancora del tutto compiuta.
A 81 anni, dopo essere stato condannato per frode fiscale poi per corruzione, oggi ineleggibile, cosa potrebbe ancora diventare Berlusconi? Quale ruolo può giocare nella ricomposizione attuale delle destre e, più in generale, nella vita politica italiana?
Berlusconi è una sorte di araba fenice, è davvero sconvolgente come ogni volga riesca a riemergere dalle proprie ceneri. Certo, non ha più l’attrazione elettorale di una volta e, qualora dovesse ridar vita a una coalizione con la Lega, la sua leadership non è più un fatto naturale, tant’è vero che gli accordi preliminari prevedono che, in caso di vittoria, a dare le carte sarà il leader del partito della coalizione che otterrà più voti. Tuttavia, è bene ricordare l’ambiguità mantenuta da Berlusconi in questi anni nei confronti di Matteo Renzi. Sebbene questo tira e molla gli sia costato caro – diversi sono stati infatti i suoi parlamentari che hanno defezionato per appoggiare organicamente il PD -, si parla con insistenza della possibilità di un’alleanza post-elettorale tra lui e Renzi nella prossima legislatura a fronte dell’assenza di una chiara maggioranza in parlamento. Gli interessati negano, ma i contatti non mancano e in questi casi è bene fare attenzione ai mormorii e alle dichiarazioni dei rispettivi sottoboschi parlamentari. Dopo decenni di levate di scudi, la pregiudiziale anti-berlusconiana del centro-sinistra sta iniziando a venire meno. Forse è un bene, sarebbe un’operazione di disinganno dopo decenni in cui la faglia principale del Paese è stata Berlusconi sì/Berlusconi no. In questo modo, ci sarebbe un ricongiungimento tra chi ha incarnato simbolicamente l’ethos neoliberista – Berlusconi – e chi ha fornito invece il personale politico più affidabile al progetto neoliberista – il centro-sinistra.
Dopo la batosta del «no» al referendum sulla riforma costituzionale del dicembre 2016 e il fallimento cocente in occasione delle ultime elezioni municipali, Matteo Renzi è di nuovo in sella per condurre la campagna del Partito Democratico in vista delle elezioni legislative della prossima primavera. Qual è il suo bilancio alla testa del governo italiano (2014-2016)? Può ancora sperare di riunire le correnti democratiche dietro di sé?
Il bilancio di Renzi è sicuramente negativo e non lo dico solo da un punto di vista partigiano, ma anche dalla sua prospettiva. Rivediamo per sommi capi la sua ascesa. Renzi si presenta come il volto nuovo della politica, come l’innovatore fresco, dalla parlata sciolta e la battuta pronta, con le trovate ‘cool’ in linea con i tempi – anche qui l’analogia con la Francia è importante: Renzi è il Macron italiano, con la differenza sostanziale che Renzi riesce a impossessarsi di un apparato partitico attraverso lo strumento delle primarie aperte. Entrambi inscenano una sorta di paradossale populismo centrista, populista in quanto creano un antagonismo molto accentuato con la vecchia classe politica – in primis quella del suo partito nel caso di Renzi – ma paradossale in quanto centrista, cioè refrattario a mettere per davvero in scacco lo status quo. Quello di Renzi poi è stato un teatrino fatto di frasi iperboliche e americanate riviste in salsa italica, almeno nel caso di Macron – magra consolazione – si può dire che ci sia un respiro culturale e progettuale leggermente più ampio. Ma ad ogni modo, all’inizio il modello renziano si offre come particolarmente seducente: il giovane che brucia le tappe e si fa largo contro la vecchia burocrazia di un partito anchilosato, mettendo tutti al tappeto.
Dopodiché c’è stata una sorta di frenesia da parte di Renzi, che ha a che fare con quel suo fare smargiasso. Il suo arrivo al governo è stata una manovra di palazzo à-la House of Cards, tutt’altro che un investimento popolare. Qui la dimensione populista è venuta meno. Questa smania poco lungimirante si è ripercossa su molti aspetti. Il suo circolo intimo, per esempio, è rimasto perlopiù quello toscano da cui è partito: personaggi in taluni casi patetici, non all’altezza di un contesto nazionale. Non è cioè riuscito ad ampliare il raggio, a cooptare persone, correnti, competenze, se non in modo totalmente effimero. Ancora più significativamente, la sua azione di governo ha confermato i sospetti di chi l’ha avversato dal primo minuto: la sua scalata era caldeggiata e favorita dalle élite italiane, con gli interessi dei grandi gruppi bancari a svettare su tutti gli altri (non a caso sono 24 i miliardi offerti al sistema bancario in questa legislatura). Questo aspetto ormai è abbastanza chiaro a tutti.
Infine, l’errore più pacchiano è stata la proposta di riforma costituzionale, una proposta eccessivamente legata alla sua persona, ma soprattutto incapace di incorporare una serie di rivendicazioni che avevano grossa presa (come la soppressione definitiva del bicameralismo, mentre Renzi aveva previsto un Senato regionale con competenze diverse). La successiva bocciatura referendaria è stata sonora e ha ridimensionato di parecchio le sue ambizioni politiche. Da ultimo, ha forzato da dietro le quinte una legge elettorale molto contestata che ha dato adito ad aspre polemiche, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, anche qui dimostrando di non cogliere una richiesta così diffusa nel Paese come quella delle preferenze. A volte potrebbe concedere quel poco che basta per respingere le insidie che gli si presentano. Ma non lo fa. Politicamente, si è dimostrato molto più sciocco di quanto non si pensasse all’inizio.
Il Movimento 5 Stelle, fondato nel 2009 dal comico Beppe Grillo, si è imposto in modo duraturo sulla scena politica italiana al punto che oggi occupa il primo posto nelle intenzioni di voto. Come descrivere questo partito talvolta definito come «oggetto politico non identificato», non si tratta del movimento populista più trasversale d’Europa? Come spiegate il suo successo?
Quella del Movimento 5 Stelle (M5S) è una delle operazioni più geniali della politica italiana e lo dico senza esserne un sostenitore, anzi. Grillo ha compreso che i tempi erano cambiati, che la riproposizione delle faglie novecentesche aveva un appello decrescente e che la rappresentatività dei partiti politici era ampiamente erosa: in questo senso, c’erano praterie di elettorato da poter conquistare. A sinistra si tende semplicemente a stigmatizzare l’operazione grillina per via dei suoi tratti ambigui, perdendo così di vista gli aspetti performativi e la possibilità di imparare qualcosa: il M5S hanno dato vita a una tradizione politica ex nihilo che in pochi anni ha rivoluzionato le lealtà politiche nel Paese.
Non a caso, su un piano puramente formale e al netto di condizioni storiche e organizzative completamente diverse, mi piace paragonare l’operazione grillina al peronismo argentino. Perché? Perché come il peronismo, anche il M5S ha dato vita a un contenitore capace di appellare a identità, simboli e domande molto diverse fra di loro. C’è una sorta di ipertrofia, di stiracchiamento di quella che il filosofo Ernesto Laclau chiama la catena equivalenziale, ossia un discorso politico che sussume e crea un rapporto di analogia tra diverse istanze di cambiamento sociale. Così come nel caso argentino, queste diverse provenienze non vengono rielaborate nel solco di un orientamento ideologico chiaro, ma si mantengono unite, freudianamente, per un comune amore al padre. Ora, io trovo che mentre nel peronismo il padre è indubitabilmente Perón, nel caso pentastellato il minimo comune denominatore non è tanto Grillo, ma la questione morale, vero e proprio miraggio salvifico in Italia da qualche decennio a questa parte. È proprio il carattere tendenzialmente vuoto di questa bandiera a far sì che sia il movimento populista più trasversale d’Europa, come dici tu. Ed proprio ciò che la sinistra è incapace di fare: tornare ad impossessarsi di significanti polisemici per potervi imprimere la propria interpretazione. Ci sono troppi termini che la sinistra si è fatta soffiare.
Lo scorso settembre, i membri del M5S hanno scelto il loro candidato per le elezioni politiche. È il napoletano Luigi Di Maio, 31 anni, vicepresidente della Camera dei deputati che ambirà dunque al posto di Presidente del Consiglio. Questa scelta implica un qualsivoglia cambiamento nella linea e nella strategia del M5S?
Il M5S finora ha dimostrato di saper celare abilmente la sua geografia politica interna, anche grazie a un centralismo dispotico che sanziona qualsiasi velleità correntizia. Tuttavia, sento di poter dire che la sua designazione marca una certa normalizzazione del M5S, la cui responsabilità non è da attribuire al voto degli iscritti, perché di fatto a settembre è avvenuta solo la ratifica di una scelta compiuta dai piani alti del movimento già molto tempo fa. Per i modi, l’estetica e da quel poco che si è riusciti a capire dalle sue esternazioni, Di Maio incarna una scelta democristiana, di rispettabilità, di rassicurazione circa la non pericolosità del movimento nei confronti degli interessi economici più rilevanti, con una tendenza ad inseguire alcune delle pulsioni più retrive, specie sulla questione immigrazione.
La sua designazione ha portato a una serie di reazioni derisorie a sinistra. Ma sbagliano coloro che lo fustigano per non essere particolarmente colto, anche perché la politica non è una lotta per l’esibizione della propria erudizione. L’approssimazione di Di Maio risulta molto più vicina all’elettore medio rispetto alla fumosità dei leader della sinistra. Tuttavia, è vero che quel suo aspetto da venditore immobiliare risulta scarsamente carismatico e sicuramente in netto contrasto con i toni accalorati di Grillo. Probabilmente è un modo, anche qui, per compensare, per andare a coprire un arco ancora maggiore dell’elettorato.
Alla sinistra del Partito Democratico, le forze sono frammentate. Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, nato lo scorso febbraio da una scissione del PD, Sinistra Italiana ugualmente strutturato in partito politico dal 2017, o ancora il Partito della Rifondazione Comunista: nessuna di queste formazioni sembra suscitare un’adesione. Come spiegate l’incapacità delle sinistre italiane di uscire dalla marginalità?
La sinistra italiana appartiene più al novero delle patologie psichiche che alla politica. Se entrassi nel vivo degli avvenimenti ci sarebbero troppe cose da dire e da specificare, anche perché l’arcipelago della sinistra ha vissuto numerose mutazioni in questi ultimi anni. Preferisco fare un discorso di carattere più ampio. Si possono infatti individuare una serie di tare che hanno reso la sinistra progressivamente inefficace, velleitaria, persino dannosa.
Innanzitutto, la sinistra mantiene un approccio platonico, pensa cioè che le masse sbaglino e che per questo vadano illuminate. È il rimasuglio della falsa coscienza, di quella pretesa di avere una lettura privilegiata del sociale, basata sull’attribuzione di interessi stabiliti a monte. Ciò che la sinistra non coglie è che le volontà collettive non pre-esistono alla politica, ma vanno costruite attraverso un lavoro di articolazione. Questo significa sporcarsi le mani nel senso comune, adottare un vocabolario che abbia attinenza con la fase storica in cui si vive. Un’operazione troppo difficile per chi si crogiola nella propria identità, crede di avere la verità in tasca e guarda con disgusto ai settori popolari che votano per M5S e Lega. Ci si limita a insistere sulla necessità di unire la sinistra – litigando su come interpretare questa operazione -, come se ciò fosse apoditticamente un bisogno avvertito dal Paese. In realtà dell’unità della sinistra non frega più a nessuno se non agli addetti ai lavori. Un altro vizio è quello di concepirsi come difensori di mille particolarismi, senza mai costruire un orizzonte che li sappia incanalare attraverso la creazione di un’identità popolare più ampia. La sinistra italiana è una parte incapace di pensarsi come rappresentazione (democratica) del tutto.
Ma la sinistra italiana sbaglia anche sul piano dei contenuti. Pervasa com’è da un cosmopolitismo di maniera che ripudia tutto ciò che possa avere un richiamo allo Stato-nazione, non avanza mezzo discorso critico sull’Unione Europea. Di conseguenza, non c’è una minima analisi sul trattato di Maastricht, sull’Euro, sul ruolo della Germania, sullo smantellamento del tessuto industriale italiano, sulle asimmetrie che l’UE cristallizza. Si continua a ripetere pedissequamente che lo Stato è superato e che il cambiamento deve essere continentale. Certo, sarebbe bello se si potesse cambiare l’Europa con uno schiocco di dita, ma la formazione delle coscienze politiche procede ancora su binari nazionali e l’UE dispone di meccanismi che rendono la sua ingegneria impermeabile al cambiamento. Senza dimenticare che lo Stato-nazione è il luogo della democrazia: oltre, c’è solo la tecnocrazia. I ragionamenti critici che fa Mélenchon, per esempio, non hanno un corrispettivo italiano, fatta forse eccezione per Rifondazione Comunista, la quale però è il più marginale e identitario di questi attori.
Un discorso speciale va fatto per Articolo 1 – MDP. Ecco, loro sono l’incarnazione dell’opportunismo, avendo votato fino all’altro ieri tutti i peggiori provvedimenti di impronta neoliberista. D’Alema è stato uno dei responsabili della deriva dell’ex PCI: ora che è stato scalzato e il vento è cambiato, lui e i suoi ripiegano tatticamente a sinistra. Elettoralmente, hanno a disposizione un piccolo serbatoio derivante perlopiù dalle reti clientelari tessute da chi fa politica da diversi decenni. Ma non potranno mai essere un soggetto espansivo. Insieme a Sinistra Italiana e Possibile, hanno appena dato vita a un cartello elettorale destinato a implodere dopo le elezioni. Come leader, hanno scelto il presidente del Senato Pietro Grasso, eletto nelle file del Partito Democratico e da poco sfilatosi per il disaccordo sulla nuova legge elettorale. Difficile pensare a un personaggio meno carismatico, e meno indicato per sfondare presso i settori che si sono allontanati dalla politica. Alla fine ciò che interessa a D’Alema & co è rubare il voto di qualche moderato dal Partito Democratico. Segno del fatto che il giorno dopo le elezioni saranno lì a bussare nuovamente alla loro porta: d’altronde, l’orizzonte politico in cui si muovono rimane quello del centro-sinistra e delle geometrie elettorali.
Podemos, La France Insoumise, questi due partiti sono riusciti a innalzarsi nel bel mezzo della scena politica rompendo con i codici tradizionali delle sinistre radicali attraverso una strategia chiaramente populista. Il movimento Senso Comune che tu ed altri animate rivendica il proprio populismo democratico, un’espressione che ha utilizzato anche Íñigo Errejón, uno dei principali intellettuali di Podemos. Quale forma deve prendere questo populismo democratico? Esiste uno spazio politico disponibile in Italia per una opzione di questo tipo?
Come Senso Comune ci collochiamo pienamente nel solco aperto da Podemos e La France Insoumise in Europa. Crediamo cioè che un discorso destra/sinistra sia ormai privo di seduzione e che l’antagonismo da rivendicare sia quello oligarchia/popolo. Per questo, la questione è aggregare un nuovo “noi”, creare cioè un’identificazione nazionale attorno a quei settori e quelle rivendicazioni sociali disattese ed esasperate dalla crisi, a partire dall’opposizione alle élite – ma non solo politiche come fa il M5S, bensì politiche e soprattutto economiche. Qui il riferimento alla Patria, al nazionale-popolare gioca un ruolo chiave. Innanzitutto, c’è la necessità di strappare alle altre forze politiche quella bandiera e declinarla in termini inclusivi: se non saranno le forze democratiche a impossessarsi di quel significante, lo faranno le destre con tutto il loro carico di cinismo e di razzismo. Si tratta cioè di stabilire che l’amore ai propri luoghi di provenienza non si concretizza in un ottuso suprematismo, ma nella sicurezza sociale ed economica di chi li abita. In secondo luogo, questa manovra gode di un’attualità ineludibile perché in un momento in cui la sovranità popolare è scippata da istituzioni sovranazionali, il riferimento alla comunità democratica di base si fa centrale. Come ben dice la filosofa Chantal Mouffe: “il nemico principale del neoliberismo è la sovranità del popolo”.
Senso Comune vuole creare un nucleo totalmente alternativo alla sinistra e al M5S, a trazione giovanile, di ispirazione anti-liberista, il meno possibile condizionato da attaccamenti a liturgie e parole d’ordine ormai prive di appello, concentrato sui temi capaci di creare maggioranze sociali nuove e trasversali. Gli eredi del PCI, di tutte le sue diverse ramificazioni, si sono rivelati incapaci di mantenere vivo quel patrimonio che, pur tra diverse ambiguità, aveva fatto dell’Italia un Paese più giusto. La loro responsabilità in termini di errori strategici, ritardi di lettura politica e arretratezza culturale è altissima. Il M5S, dal canto suo, costituisce uno tappo non indifferente. Occupa lo spazio della promessa di redenzione e si è impossessato di una serie di rivendicazioni chiave. Ma si intravvedono già alcune crepe. La loro inconcludenza, l’assenza di un progetto politico ed economico che vada oltre gli sterili attacchi alla casta politica, la selezione di una classe dirigente sì nuova ma improvvisata, stanno venendo alla luce, a partire dalla fallimentare esperienza di Virginia Raggi a Roma. Bisogna incalzarli su questo e sul fatto che senza saldare i conti con le élite e i potentati economici italiani ed europei, in primis le banche, non c’è emancipazione possibile.
La maggior parte dei paesi europei ha recentemente conosciuto un profondo sconvolgimento nel loro sistema partitico. Come si è visto, l’Italia non è un’eccezione a questa regola. Attualmente, nessuno dei grandi partiti sullo scacchiere sembra in grado di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Quali sono gli scenari delle alleanze possibili?
Il M5S sarà quasi sicuramente il primo partito, ma senza i numeri per sostenere autonomamente un esecutivo. Alcuni ventilano la possibilità di un accordo post-elettorale con la Lega, proprio in virtù di un certo scivolamento a destra dei grillini. Lo stesso Salvini ha affermato qualche settimana fa che la prima cosa che farebbe dopo le elezioni, qualora non ci fosse una maggioranza chiara, è chiamare Grillo. Per il M5S ciò vorrebbe però dire sacrificare quell’alterità radicale che finora ha mantenuto con il resto del sistema politico. Ad ogni modo, non è una possibilità da escludere.
Dopo il voto siciliano tuttavia, non è nemmeno da scartare la possibilità che sia il centro-destra a prevalere, ma con lo stesso problema per formare una maggioranza. Per questo, vedo più verosimile la conformazione di un esecutivo di “argine contro i populismi” il cui perno sarebbe chiaramente il PD. Dipendendo dai numeri, potrebbe guardare agli ex di Articolo 1, fornendo contropartite di poltrone piuttosto che politiche. Il problema è che anche lì la somma dei gruppi parlamentari non sarebbe sufficiente a conformare un esecutivo. Più probabilmente quindi, il PD potrebbe rivolgersi a Berlusconi e a quelle tipiche formazioni di transfughi da vari partiti che, quasi per magia, si formano sempre nel post-elezioni. In quel caso, difficilmente ci sarebbe Renzi, ma qualche personaggio meno vistoso. Un Gentiloni-bis è una possibilità, ma in lizza c’è anche il ministro degli interni Minniti, un ex comunista che si è costruito una fama da duro con la crisi dei migranti e che piace anche a destra.
Gli Italiani sono uno dei popoli più euroscettici dell’UE. Come lo spiegate? L’ «Italexit» è oggi nell’agenda? L’euro è identificato come un obbligo che pesa sul paese?
Vanno individuati due piani del discorso. In termini di euroscetticismo, l’Italia non è la Grecia o la Spagna, ma non è nemmeno la Gran Bretagna. Esiste un euroscetticismo latente, ma di bassa intensità. C’è naturalmente un settore più marcatamente anti-europeista – per ora schierato perlopiù a destra – ma rimane minoritario rispetto a una maggioranza che mantiene una posizione di sostanziale neutralità o di leggera ostilità. Questo spiega perché i gruppi espressamente anti-euro e sovranisti di sinistra non abbiano avuto finora alcun seguito. Di fatto, se domani si votasse sulla permanenza dell’Italia nella moneta unica, io credo che vincerebbe a mani basse l’opzione per rimanerci, con un voto ben più ampio rispetto al blocco che trae vantaggio da politiche deflazioniste. Spesso non tanto per convinzione, ma per timore.
In questo senso, bisogna muoversi tenendo a mente la centralità politica, ossia la necessità di intagliare la propria proposta a partire dai temi più sentiti, evitando di adottare posizioni che si collocano in maniera troppo netta al di fuori del senso comune. Altrimenti ricadiamo nell’avanguardismo o in un movimento monotematico.
Questo non vuol dire che l’Euro e l’UE non siano un problema. Uscire dall’Euro e dai dettami europei è una condizione necessaria – ma non sufficiente, ricordiamocelo – per tornare a generare crescita, occupazione e riequilibrio della ricchezza. Le fortune di un progetto di questo tipo sono legate alla capacità di dar vita a un discorso di società complessivo e persuasivo, prospettando un modello di integrazione europeo alternativo alla UE che restituisca sovranità – ovvero sia democrazia -, ma mantenendo una forte cooperazione su aree di interesse continentale ineludibili.
Trovo che questo processo richieda un po’ di tempo, dopotutto si tratta di disarticolare una casamatta – per usare un termine gramsciano – difficile da espugnare. Ecco, a me pare che iniziare a problematizzare progressivamente l’Euro – mettendo in rilievo tutta la dannosità dei trattati che l’hanno preceduto e dei vincoli che in questi anni si sono stabiliti – sia la strada da seguire. Si tratta di un lavoro politico e pedagogico da svolgere in maniera accorta e che va avviato quanto prima, sennò si fa la fine di Tsipras.




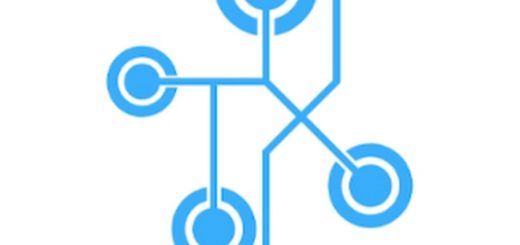



























Commenti recenti