Colin Crouch, “Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo”
di TEMPO FERTLE (Alessandro Visalli)
Leggeremo il recentissimo nuovo libro del famosissimo politologo inglese Colin Crouch, reso letteralmente una star dal suo libro del 2000, “Postdemocrazia” quando era direttore dell’Istituto di Governance e Public Management alla Business School dell’Università di Warwick. Il libro del 2000 ha avuto un indubbio merito, e per questo è inevitabilmente presente in ogni opera successiva: quello di aver sollevato la questione dell’erosione della democrazia ad opera dell’estremismo liberale quando ancora poche voci[1] si erano alzate ad avvertire del rischio. Successivamente sarà una valanga[2], e poi dal 2008 una eruzione[3]. Lo stesso Crouch fa peraltro seguire al suo primo libro di grande successo altri due libri significativi[4].
Ma se nel 2000 Crouch, che in fondo insegnava in scuole di economia, parla di cercare di ‘conservare il dinamismo e lo spirito intraprendente del capitalismo’[5] (scendendo a patti con il capitalismo finanziario), ma vede come “chiedere la luna” l’ipotesi di “porre tale richiesta a livello globale” oggi sembra aver cambiato completamente idea; allora le grandi organizzazioni sovranazionali[6] “sta[va]no andando nella direzione opposta”, per cui intravedeva ed indicava “spazio per contrattaccare a livello nazionale sul piano economico” (p.121), riducendo la confusione di funzioni e competenze tra governo ed imprese, adesso più o meno gli stessi fatti conducono a conclusioni opposte. Nella battaglia, cui ha deciso di partecipare da una parte specifica, tra globalismo e resistenze nazionali (preferirei dire, anche nei termini del libro del 2000 del nostro ‘tra globalismo e democrazia’) oggi Crouch ritiene che “possiamo avere un qualche controllo su un mondo caratterizzato da un’interdipendenza sempre maggiore solo attraverso lo sviluppo di identità e istituzioni democratiche e di governo in grado di spingersi oltre la dimensione dello Stato-nazione” (p.5).
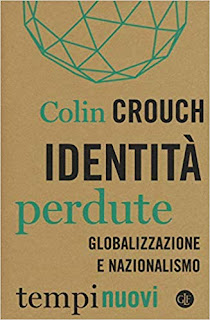
Cosa è cambiato in questi intensissimi diciotto anni? Naturalmente c’è stata quella che chiamerà la “quarta fase” del processo di mondializzazione, seguito agli accordi del Wto e alla espansione imperiale[7] che è conseguenza della ritirata del contropotere del blocco socialista. Abbiamo assistito alla irresistibile ascesa, prima e dopo il crac del 2007-8, di un modello di accumulazione finanziario che è capace di mettere a valore (anche se fragile e “fittizio”[8]) ogni aspettativa di flusso, e che per crescere, pena l’immediato crollo, deve “invadere e usare altri settori” in modo compulsivo, espandendo “il margine sistemico”, il quale, come sostiene Saskia Sassen, è il luogo in cui “si estrinseca la dinamica chiave dell’espulsione”. Dunque anche “il rapporto fra l’odierno capitalismo avanzato e le forme più tradizionali di capitalismo di mercato”, assomiglia sempre più ad una forma di “accumulazione sempre più primitiva”, una “bruta semplicità”[9], di predazione. Nel “margine sistemico” sono stati presi anche i sistemi di welfare per la stessa, semplice, motivazione di “bruta semplicità” per la quale il capitale nazionale (quello non dedito alle esportazioni, non “innovativo e competitivo”, quello concentrato sul servizio di bisogni locali, nazionali) è abbandonato alla contrazione: non è più necessario a chi è passato per la fucina delle innovazioni tecniche, organizzative e finanziarie degli anni ottanta e novanta. Per come la metteva Sassen, in altre parole, se gli elementi costitutivi del sistema, quelli che vengono incorporati come obiettivi naturali delle politiche, non riguardano più produzione e consumo di massa, quel che accade è semplice: lo spazio degli espulsi si espande e diventa anche sempre più differenziato.
Qualche numero per capire quanto si espande lo spazio degli espulsi e quanto si fortifica quello degli inclusi: secondo una recente ricostruzione[10] di Salvatore Biasco l’80% dei profitti nel mondo è prodotto dal 10% delle società, il 2% delle multinazionali (su una base di oltre 40.000) possiede l’80% del controllo delle stesse, un nucleo ancora più piccolo di 147 multinazionali, ne possiede il 40%, di queste 100 sono finanziarie. A grandi linee 100 multinazionali finanziarie controllano qualcosa come il 30% dei profitti nel mondo. Profitti che dipendono in parte molto rilevante dall’appropriazione della proprietà intellettuale. Con la stessa tendenza alla concentrazione bisogna ricordare che il 70% del commercio mondiale dipende dalle multinazionali (e che, dunque, circa 400 multinazionali, per lo più americane, generano più di metà del commercio mondiale).
Lo stesso Colin Crouch, nel 2011, riteneva[11] che fosse necessario “tenere sotto pressione” la grande impresa e che non si potesse giudicare l’incremento globale di efficienza senza aver cura di prestare attenzione alla sua distribuzione[12]. Inoltre richiamava e discuteva le tesi della “Public Choise”[13], secondo la quale tutte le attività statali sono espressione di un egoismo che trova i suoi canali di espressione attraverso l’azione delle lobbies politiche (come Partiti, Sindacati e via dicendo). Certo, già nel 2011, mentre definiva la democrazia come presidio principale dell’agenda pubblica e collettiva, invitava le forze del “centrosinistra” a guardare oltre lo Stato centralizzato e temeva il rischio di scivolare in un “nazionalismo irrazionale” che potrebbe rivolgersi contro migranti e minoranze etniche. All’epoca la sua diagnosi era la seguente: “man mano che in molti paesi la competizione formale tra i partiti si svuota di contenuti – anche perché tutti i partiti fanno sostanzialmente proprio un ordine del giorno stabilito dalle imprese -, i movimenti xenofobi emergono come uniche fonti autentiche di novità e di scelta: essi non fanno altro che estremizzare quell’esaltazione competitiva dell’identità nazionale accettata da quasi tutte le sfumature dell’opinione politica.”[14]
Il dilemma in cui porta il suo pensiero, tra convinzione che la riduzione di scambi e commerci porti necessariamente una riduzione di ricchezza[15] e il fatto che i diritti nazionali di cittadinanza sono “l’unica arma per difenderci dal potere delle Tnc [imprese transnazionali] di stravolgerci la vita”, lo conduce già allora ad appoggiare la sua speranza alla “società civile postnazionale”[16], o, per essere più precisi, sulla tensione nel quadrilatero Stato – mercato – grandi imprese transnazionali – società civile (anche transnazionale).
Dunque Crouch era da tempo su questa strada cui perviene oggi.
“Il dilemma Kuzmanovic-Autain”
Però cosa fa andare ben oltre queste posizioni, come vedremo, Crouch, passati sette anni? Io credo che abbia ormai preso una decisione definitiva lungo quello che vorrei chiamare “il dilemma Kuzmanovic-Autain”[17], ovvero tra l’aspirazione alla riconquista dei ceti popolari, contendendo l’egemonia alla destra sul campo largo, e la difesa delle aree di consenso residue che alla fine possono essere conservate solo su temi morali, data la divergenza degli interessi. Di fatto uno scontro tra ‘nuvole verbali’[18] e scelte difficili.
Crouch, di fronte alla necessità di riconoscere il danno che i processi di globalizzazione, appoggiati e promossi anche dalla sinistra della ‘terza via’[19], producono tuttavia si sofferma su l’impatto positivo per paura delle conseguenze di una posizione coerente.
Leggiamo:
“osservare la questione da questo punto di vista rivela il danno prodotto dalla globalizzazione, ma anche l’impatto positivo dell’innovazione, della ricchezza crescente e della diversità culturale in altre località e settori. Questi sono in genere luoghi cosmopolitici che hanno attratto immigrati da tutto il mondo, che hanno offerto il loro contributo all’innovazione e alla diversità. Cercare di tornare indietro nel tempo significa voler porre fine a questo dinamismo” (p.47).
Qui il conflitto di classe è nominato con precisione. Ci sono aree sociali e settori economici, oltre che distretti territoriali, che hanno subito un danno, non si nega, ma altri si sono arricchiti, sia in termini economici che sociali e culturali. Questi vincenti della globalizzazione sono quelli a cui guarda il “corno-Autain” del dilemma sopra citato, e sono cosmopoliti, dinamici, ottimisti e sicuri di sé. I perdenti della globalizzazione, invece, cui guarda il “corno-Kuzmanovic”, sono all’opposto.
Guardare, anche se in modo parzialmente inconsapevole, all’enormemente complesso intreccio di questioni sollevato dalla tarda globalizzazione in corso, dal solo punto di vista degli integrati e vincenti, porta però ad una lunga serie di accettazioni di costrutti teorici mainstream e neoliberali da parte di Colin Crouch, e, in alcuni casi, ad arretramenti rispetto alle posizioni assunte nei libri precedenti. Già all’avvio nel definire la situazione in corso “scontro epico tra globalizzazione e un risuscitato nazionalismo” attiva lo schema portante avanti/dietro che Charles Taylor individua come costitutivo di una “topografia morale” necessaria al controllo di sé[20]. La questione che pone Crouch, nella sua frase di avvio è quella che definisce il testo: chiamare a raccolta.
In modo non dissimile dalla Autain il politologo inglese cerca di indicare un modo di stare, di avere una posizione e quindi un sé, nello spazio confuso del presente. Come diversamente mostra anche Jonathan Friedman[21] le classi medie che si sentono élite sono confuse e spaventate, sentono di non capire più il mondo e di perdere i riferimenti in esso. Dunque sviluppano un più rigido “spazio di questioni”, che includa e fissi “come si deve essere”, come ci si prospetta davanti al buono, al giusto, al moralmente degno. Uno spazio nel quale ci si possa comprendere come esseri capaci di azione morale e nel quale individuare devianti e non.
La questione centrale, che definisce questo posizionamento morale, è quella del moderno e della tradizione, alla fine il discorso è attratto irresistibilmente da uno schema storico: illuminismo vs tradizionalismo e quindi ragione verso emozione ed oscurantismo[22]. La globalizzazione, pur conoscendo tutte le sue problematiche e lati oscuri, è “in primo luogo -scrive Crouch- lo sviluppo in buona parte del pianeta di relazioni economiche relativamente senza restrizioni”. Ovvero è, alla fine, uno spazio di libertà.
Una volta che si sceglie di credere a questa posizione, evidentemente parziale, se non direttamente falsa[23], ogni “implicazione sociale e politica più ampia” che questa possa comportare, è secondaria, o è pericolosa.
Infatti Crouch nega che la questione sia di classe, che ci siano dei problemi di distribuzione, di spinta alla ineguaglianza, o meglio, li riconosce, ma opera attentamente per porli in angolo, per definirli come eccezioni e questioni relative, comunque come ‘danni collaterali’ necessari. Certo, da ridurre, ma non sufficienti per mettere in questione quello che è il centro del sé del “corno-Autain” che ha scelto, ormai, di sposare.
La minaccia, casomai, è identitaria. Come scrive, “la globalizzazione è, per molti, un attentato alla loro voglia di sentirsi orgogliosi nei vari ambiti di vita: nel loro lavoro, nella loro identità culturale, nella loro comunità, nelle città e nei paesi in cui vivono, quell’ampio fascio di idee che costituiscono la nozione tedesca di heimat” (p.4).
Moderni e non
Non è questione di classe, perché si tratta, piuttosto, di tipo di lavoro. Questa è la soluzione trovata, sul piano analitico, per individuare una differenza antropologica che non implichi una questione di sfruttamento: lavorare in settori favoriti dalla globalizzazione, ovvero da quel set di tecnologie, modi di comunicazione e stili di relazione della modernità, porta secondo le fonti di Crouch ad essere tranquilli ed orgogliosi di sé; lavorare nei settori meno dinamici, “anche se conducono una vita agiata”, al contrario spaventati e bisognosi di protezione, essi vogliono certezze perché sono sconcertati e le cercano nel “mondo del passato”.
I primi progrediscono, i secondi arretrano.
Tutto il libro ripete continuamente questa sorta di favola morale e reiteratamente afferma, senza vere e proprie argomentazioni, che “possiamo ottenere qualche controllo sul mondo che è caratterizzato da un’interdipendenza sempre maggiore solo attraverso uno sviluppo di identità e istituzioni democratiche e di governo in grado di spingersi oltre la dimensione dello Stato-nazione”.
È dunque evidente, passando sul piano politico, che “la sinistra socialdemocratica deve porsi dalla parte della globalizzazione contro i nuovi nazionalismi”[24].
Nel farlo deve mettere in connessione diversi radicamenti identitari, sovrapponendoli l’uno dentro l’altro “come una Matrioska”[25]. Questa immagine, per la quale ognuno può considerarsi, senza alcuna contraddizione e/o conflitto interiore, abitante del mio quartiere a Napoli, ma anche campano, italiano e quindi cittadino parimenti europeo e del mondo intero, sembra tranquilla ed ovvia. Vi si oppone, secondo la visione proposta, una identità che ad un certo punto trova un confine invalicabile e si oppone a chi sia altrove rispetto ad esso. Una identità che pensa di “stare in piedi da sola”, anziché puntare alla cooperazione.
È in questo contesto, ripresa dello schema ragione vs oscurantismo, modernità vs conservazione, che trova spazio l’attacco diretto a quella che nel libro del 2013 chiamava “la socialdemocrazia conservatrice”, e ora identifica più precisamente con la sinistra che si oppone alla globalizzazione. Ma prima ricostruisce gli argomenti che a suo parere il nazionalismo di sinistra propone:
- La globalizzazione ha esteso l’impatto del capitalismo, consentendogli di distruggere i meccanismi di governo democratico e di trascurare i bisogni collettivi,
- Di fatto il livello più alto di governance democratica fin ora raggiunto è nello Stato-nazione,
- Lo Stato-nazione è anche un centro di identificazione e di affidamento,
- Il welfare state è una costruzione nazionale che attinge ad una solidarietà concreta non estendibile all’infinito,
- Le forme più forti di welfare state si sono sviluppate in condizioni di omogeneità etnica e culturale, sembra dunque “esserci una relazione inversa tra un forte Stato sociale e un multiculturalismo liberale”,
- È quindi necessaria una svolta che preveda tutela economica e controlli sui capitali e restrizioni all’immigrazione e, in Europa, un freno all’integrazione.
Questa descrizione, che ripercorre al punto 5 una classica tesi neoliberale[26], non infondata ma certo rudimentale, riceve una confutazione altamente istruttiva: “ogni passaggio nella progressione di questo ragionamento è del tutto logico, ma a partire dal punto 5 il discorso inizia a sfociare, anche se con motivazioni differenti, nelle posizioni della destra xenofoba”.
Uniformati in questo attacco dalla logica profondamente identitaria, quella che Friedman chiama “logica associativa”[27], che si rifiuta all’argomentazione neutralizzando la controparte grazie alla mossa di attribuirgli l’autoevidenza della colpa sono France Insoumise, Corbyn ed il Labour relativo, autori come Wolfgang Streeck e David Goodhart. In questo modo, secondo la tecnica ‘politicamente corretta’, si ha un utilizzo politico della morale per controllare la comunicazione e censurarla ab origine in tempi di incertezza[28].
Il timore è che ragionamenti pur sensati portino ad una sorta di resistenza conservatrice nei confronti del cambiamento, in particolare nei confronti di quelle posizioni che “cercano di spostare la politica democratica e i sentimenti di solidarietà umana al di fuori dello stato nazione”, rischiando di restare “congelata nel tempo”.
Dunque ricapitoliamo a questo punto:
- la sinistra “conservatrice”, che cerca di recuperare le capacità dello Stato nazionale contro gli effetti deleteri della globalizzazione e del processo ad essa subalterno della unificazione guidata dal mercato europea, rischia per Crouch di retrocedere a fasi storiche superate e di essere subalterna della destra,
- la destra radicale è invece determinata a continuare le politiche di classe che fondano il potere della sua base sociale[29], ma al contempo è consapevole degli effetti distruttivi di queste politiche sui marginali[30] che cerca di mobilitare come base di massa[31], e cerca di risolvere l’equazione politica deviando la tensione e il rancore sui più deboli ed i non cittadini, in base ad un classico effetto “capponi di Renzo”[32], il caso ungherese è esemplare in tal senso[33], come quello italiano[34],
- la posizione frontista, cui tende, per espressa ammissione, l’autore, di “alleanza tra le forze moderate di sinistra e destra contro le forze xenofobe per una globalizzazione regolamentata”, che in Italia vede in campo la proposta avanzata da Calenda[35], ha in sé il pericolo del continuismo con l’assetto delle ‘grandi coalizioni’ che ha condotto a questo punto la situazione[36].
La ritirata sulla “terza via”
Come si vede Crouch, malgrado la sua decennale critica della posizione della “terza via” blairiana, di fronte al rischio di una critica radicale della globalizzazione, e del mutamento di posizione che richiede, ripiega espressamente sulle posizioni che criticava. Consapevole che l’alleanza al centro, il “centro radicale” di Schroder e Blair, ha condotto la politica europea all’attuale disastro elettorale[37], purtuttavia vi si rifugia. Aiuta a comprendere questa apparentemente strana mossa il concetto di “estremo centro” di Alain Deneault[38]: l’abolizione della pertinenza dell’asse sinistra-destra avviene a partire da un discorso che è sia esclusivo (ovvero per ‘ceti riflessivi’, colti e razionali) sia escludente (ovvero unico giusto, con la conseguenza che si può essere solo a favore oppure contro). L’estremismo di questo centro non è politico o sociale, ma è morale, e si autorappresenta come discorso centrale, dotato di tutti gli attributi positivi (meditato, pragmatico, vero, normale, giusto, equilibrato, razionale, ragionevole) e quindi è anche l’unico legittimo.
Naturalmente la costruzione di questo discorso equilibrato e razionale passa per una narrazione storica che cerca di allineare i fatti recenti su un percorso di logico sviluppo e progressivo. A tal fine divide, sulla base di una lettura sincretica di testi anche molto diversi gli uni dagli altri[39], la globalizzazione in quattro fasi successive:
- l’imperialismo europeo (o “prima mondializzazione”, tema toccato nel libro di Rodrik in chiave critica) che negli anni tra le due guerre ha un deciso ripiegamento (durante il quale, come non ricorda l’autore, prende forma il New Deal[40]);
- la riduzione tariffaria guidata dagli Usa nel dopoguerra ed il processo di integrazione europea durante il quale cresce il welfare state in quanto il commercio vi viene subordinato e il controllo dei capitali e dei flussi di persone resta forte come nel periodo di interludio;
- la fase di deregolamentazione neoliberale, che segue alla crisi del modello temperato precedente secondo l’autore causata essenzialmente dall’incremento del costo delle materie prime e dall’inflazione, in questa fase si ha un aumento dei tassi di disoccupazione e danni ai settori industriali consolidati, ed ai relativi territori, la deregolamentazione finanziaria assume un ruolo centrale,
- la fase di accelerazione della globalizzazione, nel quale in Europa si costituisce il Mercato Unico e crolla il comunismo ed il suo sistema di potere imperiale, al contempo dal 2000 accelera l’ascesa dell’estremo oriente, attori giudicati centrali sono l’Omc e le Ue.
Il giudizio complessivo di questa evoluzione, in modo non inaspettato date le premesse, è che si è trattato di “un gioco a somma positiva”. Insomma, “la globalizzazione per molti versi ha seguito le classiche aspettative degli economisti sul fatto che ci sarebbero stati vantaggi reciproci derivanti dall’espansione del libero commercio”[41].
Certo, è anche vero che “la globalizzazione provoca un aumento delle migrazioni”, e queste hanno effetti culturali rilevanti, dunque Crouch è costretto a guardarla più da vicino. Lo fa appoggiandosi sull’argomentazione dell’ultimo Milanovic[42]: tra gli utili della fase c’è l’enorme crescita della Cina[43], e tra i danni collaterali l’aumento dell’ineguaglianza nella maggior parte dei paesi. Il paradosso è che l’ineguaglianza tra Stati è calata (con importanti eccezioni in due continenti, Africa e America del Sud) ma quella entro gli Stati è cresciuta. Un paradosso che è naturalmente solo apparente, perché è causato dal vero agente della globalizzazione, i capitali mobili, e dai suoi veicoli, le grandi società transnazionali. Sono infatti essenzialmente le grandi società che mobilitano ed utilizzano immani flussi di capitale libero e irresponsabile (ovvero disponibile a spostarsi improvvisamente, e quindi potentissimo) per ricercare localmente le condizioni di massimo sfruttamento dei fattori locali, in primis il lavoro. Dunque la stessa forza trascina in alto i pochi (in senso relativo) connessi con la meccanica di valorizzazione in posizione dominante (azionisti, manager apicali, lavoratori strategici), e in basso i ‘sostituibili’, ovunque essi siano. L’effetto di riduzione dell’ineguaglianza tra Stati è, alla fine, solo un effetto di rappresentazione, dipende dall’indicatore usato (il Pil aggregato), ma è la somma di pochi, qui e lì, che si arricchiscono e moltissimi, anche essi ovunque, che si impoveriscono. Anche il guadagno di reddito per i lavoratori che si registra nei paesi di destinazione dei flussi di capitale e di provenienza delle merci, è inferiore alla perdita di reddito di quelli che restano nelle aree di provenienza dei capitali e di destinazione delle merci. Se non lo fosse la globalizzazione mancherebbe il suo scopo.
Crouch, invece, in un capitolo particolarmente povero di riferimenti, nel quale non è possibile dunque comprendere con precisione la fonte delle sue convinzioni, a dimostrazione dell’ineluttabilità e utilità della globalizzazione produce una serie di affermazioni del tutto prive di argomentazione, a tutta evidenza per lui autoevidenti:
- anche se la Cina ha una grande produzione di acciaio (otto volte quella giapponese, e sette volte quella europea, oltre dieci volte quella americana) di cui solo un ottavo è rivolta alle esportazioni (tab. 1, p.32) la perdita della globalizzazione provocherebbe un danno decisivo a causa della perdita delle pur modeste importazioni di acciaio (13 mt, ovvero un quindicesimo della produzione europea); questo danno non sarebbe compensato dal recupero dei posti di lavoro, dato che la loro perdita non dipende dal fatto che quasi tutto l’acciaio mondiale è prodotto in Cina e India, ma dalle innovazioni tecnologiche. Un argomento davvero rudimentale per un enorme dibattito[44], con conclusioni che vanno direttamente contro quella che Rodrik chiama “la teoria standard del commercio internazionale” (e per verificare la quale basta prendere in mano un manuale). Si può, ad esempio, leggere una ricerca di Autor, Dorn e Hanson del 2016[45]. Ora, secondo l’argomento proposto da Rodrik, al contrario di quanto presume implicitamente Crouch, anche il commercio incorpora, attraverso il lavoro contenuto nei prodotti, effetti di dumping sociale(come si vede dalla ricerca di Autor, non ancora riassorbiti dopo quindici anni). Oggettivamente, per dinamica propria della situazione, i lavoratori sono stati posti davanti al ricatto di accettare minori condizioni o di perdere il lavoro. La competizione ineguale ha svuotato così le condizioni normative consolidate della distribuzione ammessa nel sistema politico-sociale del paese bersaglio. Non è affatto una circostanza teorica, tutta la perdita di potere contrattuale, salari e condizioni di lavoro che rendono i lavoratori occidentali oggi molto meno tutelati dei loro padri o nonni viene da qui. Detto in altro modo, la circostanza per la quale oggi due persone giovani che lavorano normalmente non guadagnano abbastanza da potersi permettere una casa decente e condizioni dignitose di vita, per non parlare di figli, mentre i loro padri mantenevano la famiglia nella quale sono cresciuti lavorando da soli, dipende in grande misura da questo. In altre parole la “porta sul retro” dei commerci internazionali deregolati erode sostanzialmente gli standard di lavoro nazionali, ed è per questo, precisamente, che sono stati promossi.
- Da questa limitatissima e parziale presentazione, invece, l’autore deriva che “è possibile che senza la globalizzazione l’automazione sarebbe stata più lenta, poiché le piccole imprese concorrenti, non si sarebbero prese la briga di migliorare la produttività, ma avrebbero continuato a utilizzare metodi meno efficienti a scapito dei loro clienti. Con una ridotta automazione ci sarebbe stata una carenza di manodopera, circostanza positiva per i lavoratori salariati nei settori interessati, ma che avrebbe provocato una lievitazione dei prezzi con probabilità di rallentare l’innovazione dei processi produttivi, in quanto vecchi settori he usavano metodi superati si sarebbero aggrappati alle risorse umane e di capitale” (p.34). Una notevole applicazione di modelli neoclassici inconsapevoli; si presume che l’innovazione tecnologica sia guidata dalle grandi imprese in condizioni di monopolio, trascurando il ruolo cruciale della ricerca pubblica e dei relativi incentivi[46], e il nesso tra alti salari ed efficientamento dei cicli produttivi che lavora nella direzione esattamente opposta a quanto qui ipotizzato; inoltre per Crouch se “ci sarebbe stata carenza di manodopera” (ovvero bassa disoccupazione) ne seguirebbe che la domanda interna sarebbe spinta. Ciò è riconosciuto in chiave negativa (“carenza di manodopera” invece che “buona occupazione” e “lievitazione dei prezzi” invece che spinta alla domanda), e ne deriva una curiosa spinta a rallentare l’innovazione. Tutta questa parte sembra ripresa parimente, incluso esempio sovietico, dalla letteratura della “Scuola di Chicago” che qualche anno fa criticava direttamente.
Nel seguito, nella foga di accumulare argomenti, l’autore dimentica di aver scritto che la globalizzazione ha ridotto l’occupazione in occidente e qualifica come “marginale” il fenomeno (in effetti quello maschile è calato in modo molto significativo, ma è stato compensato da quello femminile che è cresciuto), appena mezza pagina dopo dichiara che “i tassi d’occupazione nella maggior parte dei paesi sviluppati sono cresciuti in modo florido”, ma al prezzo di maggiore precarietà. Anche qui la logica economica pencola, perché se i tassi salgono ci sono meno disoccupati, e questo rafforza le condizioni contrattuali dei lavoratori e dovrebbe ostacolare la precarizzazione. Ma se tutto ciò fosse vero non si comprenderebbe il motivo per il quale tanti sono arrabbiati.
Infatti Crouch è costretto, nell’eroico tentativo di negare l’evidenza e disinnescare l’impressione che questa sia una questione di classe e di distribuzione (cosa che porterebbe l’agenda verso la “socialdemocrazia conservatrice”), a cercare motivazioni esclusivamente culturali. Le troverà, come detto, nelle forme di lavoro che determinerebbero specifiche formazioni culturali ed orientamenti psicologici.
Il resto del paragrafo si dilunga sul progresso tecnologico ed il suo impatto (p.39), sugli effetti delle rilocalizzazioni industriali e la competizione dei governi per l’attrazione (p.40), sulla relazione tra globalizzazione e migrazioni. Su questo tema ammette che c’è una relazione diretta, ma nega che questa possa provocare in generale impatto sui salari.
Con una struttura argomentativa che sembra mutuata dalla tecnica di Milton Friedman[47] (allargare i casi particolari, mal descritti, e la confusione fino a poter concludere che sono tutti casi particolari e dunque non si può decidere), conclude che l’impatto dipende dai casi specifici. Qui si trovano due pagine con una serie vertiginosa di no-sense, ad esempio, “un aumento della manodopera disponibile [se fosse occupata allo stesso salario dei presenti e senza sostituzione, ovvero in condizioni di piena occupazione] significa un aumento nel numero di consumatori e quindi un aumento della domanda”. Non specificare la condizione di validità di questa affermazione, la piena occupazione e la sua permanenza, inficia completamente la conclusione. Di seguito postula una perfetta elasticità (classico postulato neoclassico) e quindi un impatto positivo sui salari.
Naturalmente se così fosse la globalizzazione, la cui principale ratio è ridurre i salari per ripristinare i profitti sfidati dalla conflittualità sociale e dalle altre condizioni degli anni settanta, non incentiverebbe affatto l’immigrazione, e le varie associazioni degli imprenditori avrebbero esattamente l’atteggiamento opposto a quello che hanno (ad esempio in Inghilterra, in Germania, in Ungheria ed in Italia).
Subito dopo, in un paragrafo straordinariamente confuso, ammette che in altre condizioni (ovvero in quelle che si danno) “se non ci fosse disponibilità di lavoratori immigrati disponibili i datori di lavoro sarebbero forse costretti ad aumentare i salari per assumere il personale locale”. Ma ora la domanda non dipende più dagli occupati, e dai relativi salari, e quindi “la domanda dei consumatori potrebbe essere insufficiente per sostenere un aumento dei salari”, con danni ai servizi.
Infine, per uscire dalle contraddizioni in cui si è avvolto, Crouch finisce per produrre un argomentum a contrario particolarmente scheletrico e fallace che termina in un dogma: “l’economia di mercato è un gioco a somma positiva”, purtroppo crea anche problemi locali e insicurezze nelle vite delle persone che si possono risolvere con opportune politiche compensative.
Stabilito definitivamente che qui non si sta parlando affatto di lotta di classe, Crouch può rubricare tutta la faccenda sotto il tema “insicurezza”, “shock culturale”, “patriarcato”.
È questo il contesto nel quale è richiamata la frase prima ricordata sul dinamismo della globalizzazione ed i suoi beneficiari.
La sovranità nazionale
Da tutto ciò deriva che “l’idea di sovranità all’interno dell’economia moderna non è più applicabile” (p.52), perché danneggerebbe la prosperità ottenuta e il dinamismo (di alcuni). Ormai “il processo decisionale economico è fondamentalmente sovranazionale”.
Per cui è impossibile invertire la globalizzazione e “tornare” a una visione delle nazioni come entità sovrane. Ma questa, riconosce, “è l’idea più dinamica che nuove gran parte del mondo”.
Per comprenderla si improvvisa storico e, con l’usuale mancanza di riferimenti riconoscibili, si lancia in una ventina di vertiginose pagine di ricostruzione dell’emergenza dello Stato-nazione, nella fase pre-illuminista e poi a seguito della rivoluzione francese, inquadrate in una scheletrica ricostruzione morale della lotta tra bene /male incarnata nella lotta tra secolarizzazione e razionalizzazione, da una parte, ed oscurantismo dall’altra. Il fine è di collegare il razionalismo con la volontà di cambiamento e di innovazione, e queste con la “scienza dell’economia classica”.
Si arriva a queste definizioni strutturanti, ed altamente significative, del conflitto politico moderno:
“se intendiamo per ‘destra’ gli interessi del potere costituito e chi difende la sicurezza che questo offre e utilizziamo ‘sinistra’ per indicare chi è insoddisfatto di come stanno le cose e cerca di sfidare lo status quo notiamo che i conservatori rappresentano sempre la destra, per definizione” (p.69).
Una definizione imbarazzante, ma che presa sul serio porterebbe a definire ‘destra’ proprio la sua posizione; infatti il potere costituito è certamente quello insediato nella globalizzazione (basti pensare alla finanza ed al sistema della grandi imprese transnazionali), e questo offre sicurezza ai ceti che Crouch difende, i quali infatti ne sono più che soddisfatti. Gli insoddisfatti (eufemismo in questo caso) sono tutti dall’altra parte, come la sfida allo status quo.
Ma l’autore si sente dalla parte del coraggioso che sfida il potere, e rigetta la sicurezza, e vede chi cerca di conservare il progresso sociale e la democrazia come ‘destra’. A questo fine ha speso l’intero excursus economico.
A questo punto non suona più strano che, come ricorda in seguito, “i ceti popolari siano andati con la destra e la borghesia con la sinistra”. I primi lo hanno fatto perché sono di destra e vogliono difendere le sicurezze e i secondi perché sono di sinistra e coraggiosi, ottimisti, aperti al futuro ed all’innovazione[48]. Lo schema è antico, se ne possono trovare tracce persino nei dialoghi platonici, e in linea diretta in tutte le posizioni che gli ottimati nella storia hanno preso per respingere la plebe che irragionevolmente voleva una parte[49].
Ma a questo punto gli serve un altro, ultimo ingrediente: la ricerca di Daniel Oesch gli fornisce una spiegazione alternativa alla posizione relativa nella distribuzione delle risorse economiche, per l’opposizione di alcuni, anzi dei più. In realtà chi è occupato in compiti organizzativi, indipendentemente dalla ricchezza e reddito, tende ad essere autoritario, mentre chi è impegnato nei lavori cognitivi e relazionali tende ad essere liberale[50].
Naturalmente ciò significa che le identità di classe sono tramontate (p.84), e residuano forme identitarie difensive tra le quali la nazione. La tesi è, insomma, costruita sulla scorta delle posizioni degli anni novanta di autori come Castells e Bauman (messe in campo quando la risposta alla globalizzazione non era emersa e la crisi non aveva prodotto gli enormi smottamenti di senso attualmente in campo).
Alla fine per queste ragioni “sarebbe disastroso” se il nazionalismo che si diffonde riuscisse ad “invertire la globalizzazione”.
La sinistra sovranista
Dopo questi lunghi preamboli, infine, conduce direttamente l’attacco alle posizioni emergenti nel campo della sinistra contro la globalizzazione:
- alla posizione di Thomas Fazi e Bill Mitchell, che qualifica come “i maggiori esponenti” della tesi dello stato interventista e quindi sovrano, citando il libro “Sovranità o barbarie”, del quale contesta le tesi keynesiane sulla base di semplici falsi[51], ricostruzione storiche mainstream ma non corrette né accurate[52], con repentini cambi di soggetto non esplicitati, e controfattuali arditi[53]. Una delle cose più significative della confutazione è quando si oppone alla spesa pubblica con un argomento pienamente preso dalla cassetta degli attrezzi della “Scuola della Virginia” che aveva in precedenza aspramente criticato. Quindi si impegna nel seguente argomento: se uno stato, comunque, si ritirasse dagli accordi dell’Omc, ne seguirebbe che “i costi per l’importazione delle merci straniere sarebbero molto alti mentre le esportazioni diventerebbero più complesse”, in questo argomento si mettono insieme cose diverse e si abbrevia una complessa catena causale, per la quale sarebbe appropriato rispondere, come lui fa altrove, che “dipende”. Infine nega che se si riacquistasse sovranità democratica, e quindi economica, si potrebbero stringere nuovi accordi con l’argomento che la spinta alla distruzione della globalizzazione è egemonizzata dalla destra (ma la destra perché non dovrebbe volere la cooperazione economica a vantaggio reciproco, ovvero bilaterale, questa è, ad esempio, la politica sbandierata da Trump?). Ne segue, che “Mitchell e Fazi, e chiunque altro sostenga una simile distruzione delle istituzioni internazionali, devono accettare che, almeno per il medio periodo, si ritroverebbero in un mondo contraddistinto da un commercio internazionale limitato e da un antagonismo tra nazioni più intenso” (p.101)[54].
- Il secondo sistema di obiezioni è raggruppato sotto l’etichetta “Welfare State nazionale”, ed è ricondotto alla “scuola di Colonia” di Wolfgang Streeck[55], Martin Hopner, e Fritz Scharpf. La tesi principale è riassunta abbastanza brutalmente con la tesi che la missione della UE conduce al neoliberismo, anche attraverso le decisioni della Corte di giustizia contro gli Stati[56]. A queste tesi che qualifica come “autorevoli”, risponde con una pura petizione di principio: “si tratta di tesi autorevoli, ma resta vero che un mondo in cui la politica democratica rimane intrappolata a livello nazionale è un mondo in cui l’ordine neoliberista al di là della portata della democrazia continuerà a dominare il piano economico sovranazionale”. La parola chiave di questa risposta è “intrappolata”, la politica democratica è qualcosa che esiste in sé e, come fosse un animale, può essere intrappolata o essere libera, non sfiora l’attenzione la natura costruita (da sfere pubbliche, società civili ricettive, culture politiche condivise, istituzioni, regole e prassi) della “politica democratica”. Come comincia ad essere evidente, se si eleva, salendo di un piano, questa non si trasferisce ma si dissolve[57]. Segue un solito e mal costruito argomentum a contrario fondato sulla Brexit e sulla speranza di poter rovesciare l’andamento delle politiche neoliberali (delle quali non è chiaro il carattere di dispositivo di potere, nel contesto competitivo europeo).
Cosa fare
La speranza di Colin Crouch è dunque di risolvere i molti problemi presenti recuperando l’agenda di Delors e riducendo ulteriormente la discrezionalità dei governi nazionali, che si piegano alle esigenze delle lobbies locali. Come scrive “nelle mani dei governi nazionali è stata lasciata troppa e non troppo poca discrezionalità” (p.108).
Per cui alla fine ci sono solo tre scelte possibili:
- rafforzare la Ue,
- accettare la globalizzazione e restringere le scelte nazionali a dimensioni marginali,
- rompere l’economia globale,
Davanti a questa scelta “nessuna persona di sinistra dovrebbe distogliersi dalla prima opinione, dall’opportunità di costruire una solidarietà transnazionale, per saltare sul carrozzone xenofobo e reclamare un’impossibile sovranità economica nazionale”.
Insomma, siamo sempre al Tina[58], unita ad una chiamata identitaria che ricorda molto da vicino il “corno-Autain” del dilemma Kuzmanovic-Autain con il quale siamo partiti. Le “persone di sinistra” alle quali fa riferimento Crouch sono simili a lui: abbienti, colte, cosmopolite, legate a valori liberali, ottimiste.
Poi, come spesso accade nei libri di Colin Crouch, le ultime dieci pagine sono spese per proporre qualche adattamento secondario (il più rilevante è il “fair trade”, che, però se portato alle sue conseguenze, come propone Rodrik[59] indurrebbe proprio di uscire dalla globalizzazione, e una non molto chiara “sussidiarietà verticale”).
L’autore si trova davanti, insomma, ad un problema insolubile, considera esistenzialmente inaccettabile l’unica soluzione razionale, e sulla spinta di un irresistibile richiamo identitario cerca quindi di ridurne la complessità cantando nuovamente, e sempre, ossessivamente, i vecchi e familiari ritornelli.
Alla fine, rassicurato, su concentra su piccoli problemi ai margini.
Che tristezza.
[1] – Tra queste si può ricordare Ralf Dahrendorf, con il suo “Quadrare il cerchio”, del 1995, ma anche il precoce “1989. Riflessioni sulla rivoluzione in Europa”, del 1990; Richard Rorty, nelle conferenze del 1996-7 raccolte in “Una sinistra per il prossimo secolo”, Jurgen Habermas con “La costellazione postnazionale”, del 1999 e “L’occidente diviso”, del 2004; Robert Dahl, ad esempio “Sulla democrazia” del 1998; Bernard Manin, “Principi del governo rappresentativo”, del 1997, Robert Putnam in “Capitale sociale e individualismo”, del 2000, o il seminale “La società del rischio” del 1986 di Ulrich Beck; e i primi tre volumi di Castels, “La nascita della società di rete”, del 1996, “Il potere delle identità”, del 1997, “Volgere di millennio”, del 2000. Nella bibliografia citata si ritrovano, invece, Bagnasco (1999), Castells (1996), Dahl (1989), Dore (2000), Giddens (1998), Putnam (1993, 2000), Pizzorno (1977, 1993, 2000), Reich (1991).
[2] – Solo per fare qualche esempio: dal 2006 al 2008, esce la trilogia di Rosanvallon, il primo “La politica nell’età della sfiducia”, è del 2006, il secondo “la legittimità democratica”, è del 2008, ed il terzo “L’età dell’uguaglianza” del 2011; nel 2002 Joseph Stiglitz inizia la sua conversione con “La globalizzazione e i suoi oppositori”, parzialmente precisato e rettificato nei toni (nel 2002 era appena uscito sbattendo la porta dalla BM), in “La globalizzazione che funziona”, del 2006; nel 2003 Raghuram Rajan e Zingales, pubblicano una moderata critica in “Salvare il capitalismo dai capitalisti”, e nel 2005 Branko Milanovic, ex BM, irrompe nel dibattito sulla ineguaglianza, dopo alcuni paper, con “Mondi divisi”; nel 2006 Amartya Sen pubblica il suo pluricitato “Identità e violenza”, nel 2008 esce anche “Territorio, autorità, diritti”, di Saskia Sassen; vengono pubblicati “Potere e contropotere nell’età globale”, del 2002, e “Conditio Humana”, nel 2007, di Ulrich Beck.
[3] – Restando dalle parti degli stessi autori, Branko Milanovic nel 2011 pubblica “Chi ha e chi non ha”, Dani Rodrik irrompe nel dibattito con “La globalizzazione intelligente” ed il suo famoso ‘trilemma’, Stiglitz completa la conversione (che, però, non lo porta fuori del paradigma neoclassico, ma dalle parti dei suoi confini) con “Il prezzo della disuguaglianza”, del 2012, preceduto da “Bancarotta”, del 2010; Raghuram Rajan, “Terremoti finanziari”, del 2010, Wolfgang Streeck, “Tempo guadagnato”, del 2013, Jan-Werner Muller “L’enigma democrazia”, del 2011; Jurgen Habermas pubblica nel 2011, “Questa Europa è in crisi”, e nel 2013, “Nella spirale tecnocratica”, Peter Mair affonda il coltello della sua critica postuma con “Governare il vuoto”, nel 2013, e Castells completa il suo lavoro con “Comunicazione e potere”, del 2009 e “Reti di indignazione e speranza”, del 2012.
[4] – Sono “Il potere dei giganti”, del 2011, e “Quanto capitalismo può sopportare la società”, del 2013.
[5] – “Controdemocrazia”, cit., p.118.
[6] – Nomina, all’epoca, WTO, il FMI, la UE, e l’Ocse.
[7] – Chiaramente uso questo termine in un’accezione più tradizionale rispetto a quella messa in campo da Negri e Hardt nel loro libro di grande successo “Impero”, del 2000, in cui questo, che sorge “al crepuscolo della sovranità europea”, ma è “il contrario dell’imperialismo”, in quanto non ha “un centro di potere e non poggia su confini e barriere fisse”, ma è “un apparato di potere decentrato e deterritorializzante che progressivamente incorpora l’intero spazio mondiale all’interno delle sue frontiere aperte e in continua espansione”. Un simile “impero”, amministra “identità ibride”, crea “gerarchie flessibili”, determina “scambi plurali”, e modula “reti di comando”. Mescola i singoli colori nazionali in un arcobaleno globale ed imperiale. L’ottimismo dei nostri li porta a far derivare dall’osservazione che si è determinata una trasformazione dei processi produttivi (a danno del lavoro meramente industriale in favore di lavoro cognitivo, ovvero “basato sulla comunicazione, la cooperazione e l’affettività”), generando valore attraverso la produzione della stessa vita sociale, la conclusione che “non ci sarà un leader mondiale”, l’imperialismo è finito. A me pare che abbia molto più ragione Samir Amin, quando più o meno negli stessi anni parla di “triade” (Usa-Giappone-UE) come dominus della nova fase imperiale (in particolare si può leggere “La crisi”, del 2009) e riconosce una intrinseca capacità del capitalismo di schiacciare le periferie, creandole come tali. Creandole, cioè, in quanto periferie, rispetto ai centri dominanti nei quali il capitale si concentra e dalle quali domina, accade che la logica intrinseca della macchina produttiva (di valore) tende quindi continuamente a fare della natura (e degli uomini) risorse e per questo ad estrarle, ad alienarle. Per contrastare questa tendenza, dice Amin, non bisogna aspettare che una qualche contromeccanica automatica intervenga a salvarci, come vorrebbe Negri: bisogna prendere il potere. Occorre, cioè, lottare per il potere. Costringerlo a fare i conti con le forze popolari, schiacciate, ma che vogliono rivendicare il proprio, dunque porre, intanto, la questione della democrazia dove è e dove si può rivendicare. In altro linguaggio
[8] – Si veda, ad esempio Ernst Lohoff, Norbert Trenkle, “Crisi, nella discarica del capitale” e “Terremoto nel mercato mondiale”, Robert Kurz “Le crepe del capitalismo”, o, in una del tutto diversa prospettiva keynesiana Massimo Amato, Luca Fantacci “Fine della finanza”.
[9] – Saskia Sassen, “Espulsioni”, p.232. Quando i più potenti “meccanismi di accumulazione dei profitti si spostano dall’espansione della produzione di massa e dallo sviluppo dell’infrastruttura verso innovazioni finanziarie e il modello di impresa [a rete lunga] post-anni Ottanta, vengono meno le ragioni per chiedere il riconoscimento dei diritti, e il terreno su cui se ne facevano valere le rivendicazioni si disarticola, si tramuta a sua volta in un margine sistemico”.
[10] – Salvatore Biasco “Il futuro dell’ordine mondiale neoliberista tra trasformazione e resilienza”, Sinistrainrete, 2018.
[11] – Si veda, Colin Crouch, “Il potere dei giganti”.
[12] – Ivi, p.65, in questo contesto, criticando le tesi della “Scuola di Chicago”, smontava le tesi che la concorrenza tra ‘imprese giganti’ fosse della stessa natura di quelle tra i droghieri sotto casa, la quale nasconde semplicemente, come abbiamo visto, quella che occorre prevenire l’azione regolativa dello Stato la quale fa sempre peggio, e quella che l’aumento generale della ricchezza di una economia massimizza il benessere dei consumatori, “dato che la sua riduzione non può accrescerlo” (p.73). Infine la tesi che la distribuzione in ultima analisi è questione che non interessa l’economico.
[13] – Ovvero della “Scuola della Virginia”, ed in particolare Ronald Coase.
[14] – Ivi. p. 204
[15] – Una idea classicamente istituita nel pensiero economico e quasi dogma fondativo, almeno dall’epoca in cui la convenienza indusse autorevoli teorici come Ricardo, rinforzati da potenti lobbies industriali, ad individuarla.
[16] – Titolo del libro del 2006 di Debora Spini, “La società civile postnazionale”, di cui ho, peraltro, un bel ricordo come di giovane studiosa entusiasta e intelligente (espatriata alla corte di Amarthya Sen). Nel libro di Debra, tuttavia, il gatekeeper primario resta lo Stato nazionale, ed il Partito Politico quello secondario.
[17] – Kuzmanovic e Autain sono due noti esponenti di France Insoumise, che incarnano una radicale differenza di linea e di prospettiva politica. Da tempo tra la linea popolare, rivolta a tentare di ricostruire un rapporto affettivo e di sostegno reciproco con i ceti popolari da decenni abbandonati dalla sinistra, e la linea intersezionale e multiculturalista, basata sull’insediamento sociale residuale della sinistra, ovvero parte dei ceti “riflessivi” provenienti dalle medie borghesie professional e renditiere urbane, si era aperto un conflitto. All’avvicinarsi delle elezioni europee, e in concomitanza con la ricerca, da parte della direzione del movimento, di un accordo con i residui organizzati dell’area socialista (il movimento di Chenènement e quello di Mauriel), ad inizio di settembre alcuni articoli sull’immigrazione e sulla posizione di svolta della Wagenknecht in Germania, hanno determinato l’avvio della rottura. Come ricostruivo in questo post, Kuzmanovic ha dichiarato che temi, anche importanti, come il femminismo, i migranti ed i diritti LGBT, non hanno a che fare specificamente con la ‘sinistra’, ma sono temi di lotta tipicamente liberali. Il punto è che la sinistra o è popolare o non è, e dunque ha quale suo specifico “la difesa delle classi popolari e la lotta contro il capitale”. Parte di questa lotta è la necessità di ridurre l’esposizione di queste agli effetti negativi collaterali implicati dalle immigrazioni, se eccessive in termini di ritmo e caratteristiche. Clémentine Autain, deputata di Parigi, oppone a questi argomenti un punto di vista identitario che teme di perdere “anima ed immagine”. Kuzmanovic ha finito per doversi dimettere.
[18] – Il riferimento è al giudizio da parte di Karl Marx di parte del programma della sinistra socialista francese di Guesde.
[19] – Verso la quale in passato non sono mancate critiche da parte sua.
[20] – Si veda Charles Taylor “La topografia morale del sé”, 1988.
[21] – Jonathan Friedman, “Politicamente corretto”,
[22] – Si tratta, insomma, di “una nuova fase del conflitto tra ancienne regime e illuminismo. Da un lato la sicurezza dell’autorità conservatrice e della tradizione familiare, e dall’altro la libertà della ragione, dell’innovazione e del cambiamento”.
[23] –
[24] – Ivi, p.6. Già in “Quanto capitalismo può sopportare la società”, del 2013, del resto, aveva posto una distinzione di base tra due “socialdemocrazie”: quella “difensiva” e quella “assertiva”.
[25] – Il riferimento qui è al libro di Amartya Sen “Identità e violenza”.
[26] – Utilizzata come argomento contro il welfare, e/o a favore del multiculturalismo e l’apertura delle frontiere, da autori come Hayek e Milton Friedman, ma anche da Alesina e Glaeser in “Un mondo di differenze”, 2004.
[27] – Se dici una cosa, allora devi essere in quella data identità preclassificata, e che fa prevalere la ‘valenza indessicale’ (cioè il contesto della comunicazione) sul contenuto semantico (il significato)” (cfr. Jonathan Friedman, “Politicamente corretto”).
[28] – Il “politicamente corretto” è coevo all’insorgere di una nuova élite transnazionale (ben vista da autori chiave come Rorty, Lasch e Dahrendorf) che cerca di neutralizzare l’opposizione moralizzando l’universo sociale e dunque mobilitando, a fini di controllo, la vergogna. La simmetria essenziale è con la politica mondiale a taglia unica (il “Washington Consensus”) ed i suoi TINA e passa per la riclassificazione del liberale come progressista e del socialista come reazionario. Ciò che è progressista è l’olistico, il nomade/rizomatico, il diffuso e l’orizzontale. Ciò che è reazionario è il moderno, razionale, astratto, verticale.
La ‘vecchia’ classe lavoratrice diventa, da soggetto storico del progresso, ‘deplorabile’ e nazionalista, egoista e meschina. Mentre il migrante, rifugiato, le minoranze colorate, le identità plurali, diventano i nuovi eroi.
Questa è una cultura fondata sul narcisismo (Lasch) che egemonizza una forma di controllo basata sulla classificazione creando un controllo operativo (“matriarcale”) basato sulla vergogna. Le varie versioni del “politicamente corretto” sono l’ideologia funzionale allo stato della tecnica e ad un modo di produzione che da lungo tempo ha dismesso i ferri vecchi della triade Dio-Stato-Famiglia, inseguendo la forma ‘liquida’ della merce e costruendo un ‘umano non sociale’ abbandonato a tutte quelle forme di autoritarismo nascoste nell’apparenza di pienezza di diritti la cui piena espressione è il mercato autoregolato.
[29] – Si intende per “base sociale” i ceti, o frazione di questi, che forniscono il consenso di base, l’identificazione a due vie, il supporto economico e la base di reclutamento principale, di un movimento politico. Un esempio di analisi che fa uso di questa concettualizzazione in riferimento a politiche della destra italiana sono in questo post.
[30] – Ovvero degli effetti di marginalizzazione ed erosione, sia economica sia identitaria, della globalizzazione sulle classi medie inferiori e i ceti popolari.
[31] – Si intende per “base di massa” l’area di più largo consenso di massa, che si manifesta in occasione del voto o dei momenti di mobilitazione allargata.
[32] – “Agnese, superba d’averlo dato, levò, a una a una, le povere bestie dalla stìa, riunì le loro otto gambe, come se facesse un mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago, e le consegnò in mano a Renzo; il quale, date e ricevute parole di speranza, uscì dalla parte dell’orto, per non esser veduto da’ ragazzi, che gli correrebber dietro, gridando: lo sposo! lo sposo! Così, attraversando i campi o, come dicon colà, i luoghi, se n’andò per viottole, fremendo, ripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzecca-garbugli. Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all’in giù, nella mano d’un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l’alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura”.
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. 3
[33] – In Ungheria il governo Orban in una prima fase, che dura tutt’ora, ha chiuso del tutto le frontiere all’immigrazione per inseguire e mobilitare la base di massa del movimento, ma questo ha portato gradualmente a condizioni di pieno impiego e queste, come dice la teoria economica (a meno non la si mascheri con ipotesi ad hoc), ha indotto ad una tendenza all’aumento dei salari che, però, va contro gli interessi della base sociale del regime (imprenditori dediti all’esportazione ed altri segmenti sociali connessi. Di fronte a questo dilemma per ora il regime ha risposto restringendo drasticamente i diritti dei lavoratori, in modo da contenerne il costo.
[34] – In Italia la componente della Lega del governo in essere, per molteplici ragioni, ha cercato di dirigere la rabbia della base di massa e di parte della base sociale su terzi ancora più deboli, scelti ovviamente negli immigrati. La manovra per ora sta avendo successo, non solo verso il consenso di massa, ma anche verso le opposizioni di sinistra che sono catturate come una falena dalla luce dalla retorica messa in campo e non riescono a far altro che reagire opponendone una uguale e contraria che sconta al massimo grado l’impopolarità.
[35] – Di recente Calenda ha presentato il Manifesto “Siamo europei” che commento qui.
[36] – Lo stesso Crouch descrive questo rischio sotto due profili: tendenza a soffocare il dibattito pubblico, impedire il superamento delle posizioni acritiche degli anni passati.
[37] – Per un efficace riassunto si può vedere il libro di Andrew Spannaus “La rivolta degli elettori” del 2017.
[38] – Si veda Alain Denault, “Mediocrazia”, e “Governance”.
[39] – Viene citato Francois Bourguignon, “The globalization of inequality”, Branko Milanovic, “Ingiustizia globale”, Joseph Stiglitz “La globalizzazione e i suoi oppositori”, Dani Rodrik “La globalizzazione intelligente”.
[40] – Si veda Kiran Patel, “Il New Deal”
[41] – Crouch, 2019, p.26. Qui si evidenzia tra l’altro l’uso parziale delle fonti, perché se avesse letto con attenzione Dani Rodrik un simile giudizio sarebbe impossibile (ma anche leggendo il libro citato di Stiglitz). Il punto è che questo è un dogma centrale nella narrazione imperiale globalista (a partire da quella inglese che fondava la posizione di Ricardo), e quindi non è possibile metterla in questione, altrimenti bisognerebbe concludere che le “sinistre conservatrici” hanno ragione.
[42] – Che abbiamo ripercorso nel post di lettura del suo ultimo libro, e che, in effetti assume, ma con ben maggiore competenza e qualità di argomentazione, una posizione simile: la globalizzazione provoca danni, ma è inevitabile.
[43] – Peccato che sia un esempio esattamente dell’opposto, ovvero di chiusura selettiva e di direzione dall’alto.
[44] – Per restare ad un autore riconosciuto e citato da Crouch, ad esempio, Dani Rodrik contesta direttamente in questo paper, di cui ho fatto una approfondita lettura in questo post, la tesi che la crescita cinese, tra le altre, non abbia prodotto effetti sulla distribuzione interna della ricchezza nell’asse lavoro/capitale in occidente. Per Rodrik, che fa uso di recenti ed autorevoli ricerche, il commercio internazionale ha subito un massivo “shock cinese” che ha intensificato la disuguaglianza economica. L’importazione di prodotti ad alta intensità di lavoro (cioè prodotti a bassa sofisticazione), quindi, “ha colpito gli addetti alla produzione nelle economie ricche in modo particolarmente duro”, proprio come la teoria standard del commercio internazionale prevedeva (immaginando compensazioni che ovviamente non sono mai arrivate, anzi, sono state ridotte). Ma la teoria standard immagina anche che i mercati del lavoro e gli equilibri macroeconomici, disturbati dallo shock commerciale, siano flessibili e in un tempo ragionevolmente corto possano riassorbire i lavoratori (in altre parole, che un impiegato tessile si riconverta in una industria metalmeccanica che fa treni venduti in Cina). Non è successo, “e [dunque] lo shock cinese ha prodotto grandi deficit commerciali e innalzato la disoccupazione nei mercati del lavoro locali. La creazione di lavoro in altri settori orientati alle esportazioni sembra essere stata disattivata”.
[45] – Il paper sostiene che “L’emergere della Cina come grande potenza economica ha indotto un cambiamento epocale nei modelli del commercio mondiale. Nello stesso momento, ha messo in discussione gran parte della saggezza empirica accumulata sul modo in cui il mercato del lavoro reagisce agli shock commerciali. Accanto ai vantaggi annunciati dell’espansione del commercio per i consumatori ci sono notevoli costi di aggiustamento e conseguenze distributive. Tali impatti sono stati più visibili nei mercati locali del lavoro in cui si concentrano le industrie esposte alla concorrenza estera. La regolazione dei mercati locali del lavoro è stata notevolmente lenta, con i salari e i tassi di partecipazione alla forza lavoro che sono rimasti depressi e i tassi di disoccupazione elevati per almeno un decennio dopo che ha avuto inizio lo shock commerciale della Cina. I lavoratori esposti hanno sperimentato un reddito vitale ridotto e una maggiore turbolenza del lavoro. A livello nazionale, l’occupazione è diminuita nelle industrie degli Stati Uniti più esposte alla concorrenza delle importazioni, come previsto, ma l’aumento in compensazione dell’occupazione in altri settori si deve ancora materializzare. Una migliore comprensione circa quando e dove il commercio è costoso, e come e perché può essere utile, è un elemento chiave dell’agenda di ricerca per gli economisti del commercio e del lavoro”.
[46] – Su questo tema le classiche ricerca di Marianna Mazzucato, Michael Jacobs, “Ripensare il capitalismo”.
[47] – Crf Milton e Rose Friedman, “Liberi di scegliere”, Milton Friedman “Capitalismo e libertà”.
[48] – Li descrive in questo modo: “una popolazione generalmente più giovane, più sicura di sé, più incline a vedere gli orizzonti aperti e il multiculturalismo come un’opportunità più che una minaccia” (p.95).
[49] – Si veda ad esempio questa lettura del libro “Il mondo di Atene” di Luciano Canfora.
[50] – D. Oesch, “Redrawing the class map”, e Kirschelt, Rehm, “Occupation as a site of political preference formation”, in “Comparative Political Studies”, 2014
[51] – L’affermazione che “le politiche keynesiane non erano indirizzate a governi con debiti cronici”, quando il debito pubblico inglese all’epoca era molto più alto di quello italiano di adesso e lo è restato a lungo.
[52] – Quella che il debito dei paesi del sud, Italia in primis, derivino da gestioni allegre, mentre derivano dalla fine della repressione finanziaria post Bretton Woods.
[53] – Quello che la speculazione avrebbe piegato le monete nazionali in assenza del vincolo esterno, ovviamente è possibile, ma non necessario (dato che abbondano controesempi).
[54] – Due osservazioni in merito: queste sono le condizioni nelle quali si trovarono la maggior parte delle nazioni nella fase di smontaggio della globalizzazione imperiale inglese e del laissez-faire finanziarizzato che l’accompagnò nel periodo terminale, ma questa fase vide sia le soluzioni autoritarie italiana e tedesca, e giapponese, sia la soluzione del New Deal (questo il punto raccontato da Rodrik, e questo da Patel); lo schema ‘commercio vs guerra’ è tra i più antichi ma anche tra i più consumati. In effetti non si confligge quando si commercia, ma lo si fa normalmente un attimo dopo, se i commerci sono particolarmente squilibrati e quindi sono essi stessi una politica di potenza invasiva.
[55] – Del quale si può leggere “L’ascesa dello stato di consolidamento europeo”, “Perché l’euro divide l’Europa”, “Che dire del capitalismo?”, “Come finirà il capitalismo”
[56] – Si veda Fritz Scharpf “La doppia asimmetria dell’integrazione europea”.
[57] – Un esempio di questa sensibilità, in un politologo che inizialmente era su posizioni simili a quelle di Crouch, è in questo libro postumo di Peter Mair, “Governare il vuoto”.
[58] – Ovvero alla posizione presa e propagandata dalla Thatcher, e poi rilanciata da Blair che è il porto sicuro di ogni spaventato vascello.
[59] – Si veda “Dani Rodrik “E’ tempo di pensare in proprio al libero scambio”.
Fonte: http://tempofertile.blogspot.com/2019/01/colin-crouch-identita-perdute.html
































Commenti recenti