Banca d’Italia e debito pubblico
di CONIARE RIVOLTA

La Banca d’Italia ha recentemente comunicato che trasferirà al Tesoro circa 6 miliardi di euro derivanti dai suoi utili maturati nel 2018. In un periodo caratterizzato da una cronica scarsità di fondi pubblici, con i governi in perenne affanno nel trovare le risorse e far quadrare i conti, è davvero curioso che questa notizia sia passata in sordina: per una volta che i soldi cadono dal cielo – perché non c’è alcun italiano che abbia dovuto sborsarli, quei 6 miliardi, che provengono freschi freschi dal conio della banca centrale – nessuno sembra volersene occupare. Nemmeno un Cottarelli di turno che si prenda la briga di spiegarci bene da dove arrivino queste risorse aggiuntive disponibili per la realizzazione di scuole, ospedali, infrastrutture. Eppure, benché relativamente banale dal punto di vista tecnico, la questione, come vedremo, è carica di conseguenze politiche.
Indebitarsi costa. Lo Stato si indebita emettendo titoli del debito pubblico (principalmente Buoni del Tesoro Poliennali, BTP) che fruttano ai sottoscrittori (ossia i detentori di quei titoli) un certo tasso di interesse: quel tasso è il costo del debito. Se ci indebitiamo per 300 miliardi di euro ad un tasso del 2%, dovremo pagare ai nostri creditori 6 miliardi di euro ogni anno per il servizio del debito. Considerato che l’Italia ha un debito pubblico di circa 2.300 miliardi di euro, possiamo capire subito per quale ragione ogni anno lo Stato è costretto a pagare circa 65 miliardi di euro di interessi su quel debito. Per cogliere appieno l’ordine di grandezza, è sufficiente riflettere sul fatto che provvedimenti quali il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 – le due principali misure economiche varate da questo governo che tanto hanno scandalizzato i puristi del pareggio del bilancio – hanno avuto un costo complessivo per il 2019 di circa 15 miliardi di euro, meno di un quarto delle risorse pagate dallo Stato ai suoi creditori.
E’ vero, allora, che indebitarsi costa. Sappiamo anche, però, che il debito pubblico è una leva fondamentale della crescita economica – strumento indispensabile per stimolare la domanda di beni e servizi, la produzione e dunque l’occupazione. Occorre dunque capire come sfruttare al meglio la leva del debito pubblico contenendone i costi, cioè riducendo al minimo la spesa per interessi. E veniamo al punto: cosa determina la spesa per interessi sul debito pubblico?
Per semplicità, possiamo immaginare che ci siano solo due modi per finanziare il debito pubblico, ovvero che esistano due soli possibili creditori disposti a prestare soldi allo Stato: le banche private, da un lato, e la banca centrale dall’altro. Prestare denaro è il mestiere delle banche private, che sono sempre disponibili a finanziare il debito pubblico, ossia acquistare i titoli emessi dallo Stato, dietro al pagamento di un tasso di interesse. Nelle economie avanzate, infatti, le banche private ottengono in prestito dalla banca centrale, dietro pagamento di un tasso di interesse, la moneta che a loro volta esse stesse prestano al settore privato (imprese e famiglie) e allo Stato. Al fine di ottenere profitti, dunque, le banche private richiedono a loro volta il pagamento di un interesse per concedere in prestito quella moneta allo Stato e al settore privato. La banca centrale, invece, è l’autorità che detiene il potere esclusivo, conferitole dallo Stato, di creare moneta, e può dunque finanziare il debito pubblico praticamente senza costi (stampare banconote in serie richiede costi, in termini di materie prime e lavoro, di fatto quasi nulli): non sostenendo alcun costo rilevante per la creazione di nuova moneta la banca centrale ha il potere di finanziare il debito pubblico senza dover chiedere in cambio, sostanzialmente, alcun interesse. Storicamente questo è proprio ciò che è avvenuto in tutte le principali economie avanzate, dove le banche centrali hanno garantito costi bassissimi al finanziamento del debito pubblico proprio in virtù del loro potere di creare moneta, di fatto, dal nulla, con costi praticamente irrisori. In Europa ciò è avvenuto fino a che non si è affermato il progetto di integrazione economica e monetaria europea, un progetto che ha tra i suoi pilastri l’indipendenza della banca centrale.
L’espressione ‘indipendenza’ della banca centrale può far pensare a termini quali ‘autonomia’, ‘neutralità’, ‘obiettività’ che, in astratto, possono anche suscitare immagini tutto sommato positive. Tuttavia, parlare di indipendenza in un’accezione positiva è, in questo contesto, quanto meno fuorviante se non addirittura mistificatorio. In realtà l’indipendenza della banca centrale ha significato esclusivamente un’indipendenza dell’autorità monetaria dal Governo e dal potere centrale. In Italia, infatti, almeno fino al 1981, la Banca d’Italia operava alle strette dipendenze del Governo. Tale dipendenza si sostanziava nell’impegno, da parte della stessa Banca d’Italia, a sottoscrivere i titoli del debito pubblico emessi dallo Stato italiano non acquistati dal settore privato (le banche private). Ciò consentiva allo Stato di conseguire notevoli risparmi in termini di minori interessi da corrispondere sull’ammontare totale di titoli emessi rispetto, viceversa, allo scenario in cui tutti i titoli del debito pubblico fossero stati acquistati esclusivamente dalle banche private. E, aspetto ancora più importante, permetteva al Governo di esercitare un maggiore controllo sulla gestione del debito pubblico. Sul finire degli anni settanta, tuttavia, in pieno conflitto sociale e distributivo, prese piede il processo di progressiva autonomia della banca centrale italiana, culminato nel famoso ‘divorzio’ tra Tesoro e Banca d’Italia del 1981. A partire da quella data la Banca d’Italia poteva considerarsi sciolta dall’impegno di acquistare i titoli del debito pubblico emessi direttamente dallo Stato. Il ‘divorzio’ fu un evento storico, che presentava al suo interno precisi connotati e evidenti finalità politiche. Dietro al pretesto di una spesa pubblica fuori controllo, di un livello del debito pubblico troppo elevato generato dal pericoloso legame tra Governo e Banca d’Italia e di un crescente aumento nel livello dei prezzi provocato da un’eccessiva quantità di moneta in circolazione vi era, da un lato, la precisa volontà di slegare la gestione del debito pubblico dal potere di creare moneta proprio della banca centrale, lasciando che lo Stato si finanziasse esclusivamente presso le banche private. Dall’altro, tramite la riduzione del livello del debito pubblico e, dunque, della spesa pubblica, si puntava in modo spietato alla riduzione dei salari e del potere contrattuale della classe lavoratrice. Nelle parole, a nostro parere piuttosto esplicite, dell’allora governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi:
“La convinzione è che il ritorno a una moneta stabile richieda una costituzione monetaria fondata sui tre pilastri della i) indipendenza del potere di creare moneta da chi determina la spesa pubblica, di ii) procedure di spesa rispettose del vincolo di bilancio, di iii) una dinamica salariale coerente con la stabilità dei prezzi”.
Come si può notare, si tratta esattamente dei tre pilastri che sorreggono l’attuale assetto istituzionale dell’architettura dell’Unione Europea
A conti fatti, dunque, avendo imposto alle banche centrali il divieto di finanziamento del debito pubblico, l’Unione Europea spezza il nesso tra il potere di creare moneta proprio delle banche centrali e quel fondamentale strumento di crescita economica che è il debito pubblico. Tornando al nostro esempio, venuto meno il creditore pubblico – cioè la banca centrale – gli Stati sono costretti a finanziare interamente il proprio debito presso le banche private, che prestano per profitto: ogni euro di debito pubblico richiede oggi all’Italia il pagamento di circa 2 centesimi di interessi.
Nel bel mezzo della crisi economica e finanziaria, però, le istituzioni europee sono state costrette a derogare dalla rigida applicazione del principio dell’indipendenza delle banche centrali: per puntellare il sistema finanziario che iniziava a scricchiolare sotto i colpi della crisi dell’economia reale, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un programma di acquisti di titoli del debito pubblico, il famoso Quantitative Easing (QE). Attraverso le sue ramificazioni nazionali, ossia le singole banche centrali nazionali che svolgono un ruolo di esecuzione effettiva della politica monetaria, la BCE ha acquistato titoli del debito pubblico detenuti dalle banche private, tornando così a svolgere il compito di creditore dello Stato. La Banca d’Italia – la ‘filiale’ italiana della BCE – ha così acquistato circa 300 miliardi di euro di titoli del debito pubblico italiano tra il 2015 ed il dicembre 2018. Quei titoli fruttano interessi che vengono corrisposti ai detentori: per questo, ad un tasso medio del 2%, la Banca d’Italia ha percepito circa 6 miliardi di euro di interessi da parte dello Stato italiano; ma la banca centrale è un’istituzione pubblica, parte integrante dello Stato, e dunque è chiamata ogni anno a ‘retrocedere’ gli utili al Tesoro, al netto di una piccola parte girata alle banche private proprietarie del capitale della Banca d’Italia. Ecco la partita di giro: lo Stato paga gli interessi sul debito pubblico, ma nella misura in cui quel debito è detenuto dalla banca centrale, gli interessi vengono infine restituiti al debitore, e si può affermare che quella parte del debito è stata contratta a costo zero, senza imporre alcun pagamento di interessi. Ecco spiegato da dove provengono i 6 miliardi trasferiti dalla Banca d’Italia al Tesoro.
Perché, dunque, se ne è parlato così poco? Forse perché quei 6 miliardi – più o meno le risorse necessarie e finanziare il reddito di cittadinanza – sono la plastica rappresentazione dei vantaggi derivanti dalla cosiddetta monetizzazione del debito pubblico, ossia dal finanziamento del debito attraverso l’intervento della banca centrale. Ristrutturare una scuola o costruire un nuovo ospedale in pareggio di bilancio significa imporre ai cittadini un equivalente ammontare di tasse che gravano principalmente sui redditi da lavoro; le stesse spese finanziate tramite la banca centrale non hanno alcun costo, non impongono alcun peso sull’economia lasciando dispiegare al massimo l’effetto espansivo dell’intervento pubblico. Il denaro creato dalla banca centrale è dunque una risorsa strategica fondamentale per governare l’economia, e gli effetti del Quantitative Easing della BCE – ben sapendo, tuttavia, che il QE ha avuto una funzione ben determinata – stanno lì a dimostrarcelo limpidamente, con 6 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico che tornano in cassa, come se non fossero mai stati spesi, di nuovo a disposizione per finanziare la spesa sociale.
Discutere di questo significa togliere all’economia il velo dei tecnicismi e far emergere la natura politica delle scelte fondamentali. L’indipendenza della banca centrale, chiave di volta del progetto di integrazione europea, sottrae alla collettività gli strumenti indispensabili della crescita, lasciando il finanziamento del debito pubblico in balia dei mercati finanziari, delle banche private, ed imponendo così un vincolo di mercato alla capacità degli Stati di sostenere l’economia. Torniamo a far parlare i numeri: i 6 miliardi di euro appena retrocessi dalla Banca d’Italia al Tesoro corrispondono grosso modo agli interessi sui 300 miliardi di euro di titoli di Stato che la banca centrale ha acquistato all’interno del programma di Quantitative Easing. Ma la Banca d’Italia, nel rispetto del divieto di finanziamento del debito pubblico, ha limitato i suoi acquisti a poco più del 10% del debito pubblico italiano. Provate a pensare per un attimo a cosa accadrebbe se, invece di questa quota marginale, la Banca d’Italia sottoscrivesse il 40% del debito pubblico italiano: ipotizzando un tasso di interesse medio del 2%, lo Stato italiano risparmierebbe circa 20 miliardi di euro di spesa per interessi da spendere per scuole, ospedali, infrastrutture e spese sociali. Pura fantascienza? Non si direbbe, dal momento che la Banca Centrale del Giappone detiene più del 40% del debito pubblico giapponese. Sembra pura fantascienza solo all’interno della gabbia europea, costruita proprio per paralizzare la crescita economica e sfruttare la disoccupazione di massa come strumento di disciplina dei lavoratori, in difesa dei profitti di pochi. La rottura di questi vincoli è dunque un passaggio obbligato per qualsiasi programma di emancipazione sociale in Europa.



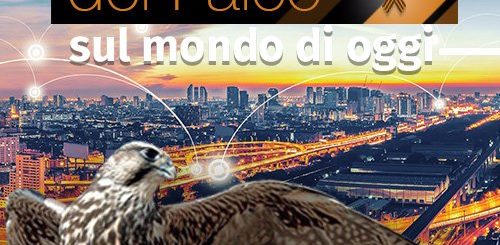


























Commenti recenti