Federico Caffè e la ri-politicizzazione dell’economico
di La Fionda (recensione di un libro di Thomas Fazi a cura di Emanuele dell’Atti)
È oggi ampiamente diffusa un’immagine stereotipata dell’economia presentata come una “scienza naturale”: un sapere a-storico, a-valutativo e indipendente dalle intenzioni umane. Ma l’economia, anche quando si traveste con gli abiti della neutralità tecnica, è sempre “economiapolitica”: esito, cioè, di precise intenzionalità e di specifiche progettazioni umane.
Lo sapeva bene Federico Caffè, tra i più importanti economisti italiani della seconda metà del Novecento, che si è sempre battuto, attraverso pubblicazioni scientifiche, interventi giornalistici e dibattiti pubblici, per costruire una civiltà più giusta di quella prodotta dall’economia capitalistica: Una civiltà possibile. La lezione dimenticata di Federico Caffè (Meltemi, Milano 2022, pp. 215) è infatti il titolo dell’inedito lavoro sul pensiero dell’economista pescarese scritto dal giornalista e saggista economico Thomas Fazi.
Il volume, a detta dello stesso autore, nasce “per caso”: l’intenzione originaria era quella di scrivere un libro sulla figura di Mario Draghi, utilizzando gli scritti di Caffè – suo maestro – come contrappunto al percorso professionale dell’ex presidente della BCE. Infatti, al netto dei “ridicoli parallelismi” (p. 19) tra Caffè e Draghi messi in risalto dalla stampa dopo l’incarico di governo ricevuto da quest’ultimo a inizio 2021, “del pensiero e della ‘filosofia’ di Caffè non vi era traccia nell’operato decennale di Mario Draghi” (ivi: 20), il quale aveva da tempo abbandonato l’originaria adesione al keynesismo per abbracciare le dottrine monetariste e il dogma del “vincolo esterno”.
Il pensiero di Caffè, pertanto, al di là dell’immagine ingessata della narrazione ufficiale, risulta essere di grande attualità per mettere a tema, con rinnovato spirito critico, i limiti dell’economia di mercato, la retorica neoliberale e l’uso politico dell’allarmismo economico. Con la consapevolezza che nella dimensione economica non esistono leggi di natura e che “un’alternativa è sempre possibile” (p. 23).
- Tra Keynes e la Costituzione
Federico Caffè (1914-1987) è stato professore ordinario di Politica economica e finanziaria alla Sapienza di Roma dal 1959 al 1984. L’impianto keynesiano che traspare dai suoi scritti è ravvisabile nelle sue frequenti denunce sull’intrinseca instabilità del capitalismo e nell’idea che debba essere lo Stato ad intervenire nell’economia, utilizzando la spesa pubblica in modo strutturale e non meramente emergenziale, per compensare le inevitabili esternalità negative generate dal mercato, prima tra tutte la disoccupazione. Caffè, infatti, da profondo studioso di Keynes, fu uno strenuo sostenitore della forte presenza pubblica nelle politiche industriali e nella edificazione di un welfare state su solide fondamenta di “economia mista”: il mercato, per Caffè, è solo una dimensione dell’economico, e – così come enunciato nell’art. 41 della Costituzione italiana – deve in ogni caso essere subordinato all’utilità sociale. Un “sistema misto”, cioè una via di mezzo tra i due estremi del collettivismo e del libero mercato, in cui lo Stato tiene saldamente in mano i “controlli centrali”, programmando e pianificando l’economia, senza però escludere la libera iniziativa.
In realtà, l’obiettivo di Keynes era ancora più ambizioso: il suo auspicio, infatti, non era semplicemente “riformare” il sistema capitalistico, ma promuovere la transizione a un modello economico alternativo. Gli elementi più rivoluzionari della Teoria generale di Keynes, tuttavia, già a partire dal secondo dopoguerra, vennero “normalizzati” in favore di una sorta di compromesso con il vecchio paradigma liberista: la cosiddetta “sintesi neoclassica” – che prese il nome di “neokeynesismo” – rappresenta infatti una “grossolana semplificazione della teoria originaria di Keynes” (p. 41). Anzi, in molti casi, specie quando afferma la naturale bontà dei meccanismi di mercato (in ossequio, più che a Keynes, al vecchio Smith) appare un vero e proprio “ribaltamento” rispetto alla posizione dell’economista britannico.
Solo una minoranza di economisti rifiutò questo depotenziamento della teoria di Keynes: tra questi Federico Caffè, che si batté costantemente contro l’illusione liberista della “mano invisibile”, che riteneva fossero i capitali a dover inseguire i lavoratori e non viceversa, che credeva nella possibilità di abolire le speculazioni di quelli che chiamava “gli incappucciati della finanza”, a vantaggio di forme di programmazione e “pianificazione democratica” – come recita il titolo di un suo importante libro – dell’economia.
Caffè è convinto che la piena occupazione, obiettivo che il capitalismo è strutturalmente incapace di assicurare, rappresenti un imperativo etico: lo Stato non deve limitarsi a sostenerla reagendo solo in chiave anticiclica alle fluttuazioni del settore privato, ma deve agire attivamente. D’altra parte sono gli stessi principi sanciti nella Costituzione repubblicana, a cui Caffè diede il suo contributo come membro della Commissione economica del Ministero per la Costituente (1945-46). La Costituzione repubblicana, infatti, non finalizza l’intervento statale alla tutela degli interessi privati, bensì al benessere sociale diffuso. Il problema – scrive Fazi – è che “la Costituzione prescrive i fini […] che avrebbe dovuto perseguire la nuova Repubblica”, ma non “i mezzi di politica economica, e soprattutto di politica monetaria e di bilancio, con cui conseguirli”, così che “le idee liberiste, cacciate dalla porta in sede di dibattito costituente, sono potute rientrare così facilmente dalla finestra” (p. 71).
Di tutto ciò ne era ben consapevole Federico Caffè, incontrando però forti resistenze non solo nel campo accademico e giornalistico, ma anche negli ambienti politici della sinistra socialcomunista, che “si dimostrarono scettici, se non apertamente ostili, alle teorie di Keynes, un po’ per tatticismo […] un po’ perché le sinistre già allora subivano le suggestioni dell’appello al mercato” (p. 72).
- Il caso italiano e il PCI
La prima metà degli anni Settanta è una stagione di grandi riforme progressive per l’Italia: l’accordo sull’indicizzazione dei salari all’inflazione (Scala mobile), la riforma del sistema pensionistico, lo Statuto dei lavoratori sono i passaggi che meglio rappresentano gli esiti di quel forte afflato democratico promosso dalle organizzazioni dei lavoratori.
Presto, tuttavia, questo “ciclo riformista” viene bruscamente interrotto “sotto la spinta di una controffensiva padronale senza precedenti” (p. 114): misure restrittive/deflazionistiche come il blocco per due anni della scala mobile, unite all’aumento delle tariffe energetiche, portarono il paese in una direzione antitetica alla faticosa democratizzazione reale che si era avviata.
Quale fu la posizione del Partito comunista italiano? Emblematico a questo proposito è il convegno organizzato dal Centro studi di politica economica (CESPE) del partito nel 1976 dedicato al tema della crisi economica. La discussione vide confrontarsi due economisti: Franco Modigliani e Federico Caffè.
La tesi di Modigliani, sostanzialmente, consisteva nel legittimare le scelte di politica economica del governo per riequilibrare i conti con l’estero: “qualche sacrificio ai lavoratori” – sosteneva l’economista del PCI – in cambio della difesa dell’occupazione.
Federico Caffè, per parte sua, dichiarò il suo “smarrimento intellettuale” di fronte a queste posizioni che definiva “prekeynesiane” e annotava con fermezza che la riduzione dei salari non migliorasse di per sé le condizioni dell’occupazione. Ciò non era verificato né analiticamente né empiricamente: si trattava solo di un “atto di fede”.
Insomma, Caffè era preoccupato che all’interno del PCI si stesse offuscando la concezione dello Stato come garante del benessere sociale ed era sconcertato di come, a fronte di una grave involuzione economica, anche a sinistra, non si trovasse nulla di meglio da proporre che la “riscoperta del mercato”. Inoltre, l’economista pescarese avvertiva sull’uso strumentale dell’inflazione, di cui – sosteneva – se ne sfrutta lo spauracchio per raggiungere obiettivi politici. Caffè la definiva “strategia dell’allarmismo economico” e consisteva – scrive Fazi – nel “dipingere un paese sempre sull’orlo di una imminente catastrofe economica: il tutto allo scopo di […] far accettare all’opinione pubblica ‘riforme’ (di stampo regressivo e neoliberale) presentate come risolutive” (p. 131). L’obiettivo reale delle politiche anti-inflazionistiche, infatti, era la compressione salariale e l’inibizione del processo di democratizzazione dell’economia.
Caffè si prodigò per cercare di convincere la sinistra e i sindacati a “non fare propria la narrazione dell’avversario” (p. 134), in quanto temeva che così facendo si sarebbero riportate le lancette della storia all’epoca del capitalismo aggressivo dell’era prekeynesiana. Ma gli appelli e i moniti di Caffè non furono sufficienti: il PCI sposò integralmente le tesi monetariste/neoliberiste di Modigliani, “interiorizzando l’idea secondo cui […] l’Italia non avrebbe potuto affrontare la crisi economica in corso che attraverso il contenimento dei salari e politiche monetarie e di bilancio restrittive” (p. 141).
Questa “svolta economica” del PCI sarebbe stato il primo passo verso quella più ampia “svolta politica” che circa quindici anni dopo, nel 1991, avrebbe portato alla dissoluzione del partito.
- L’integrazione europea e il disegno neoliberale
Lo scontro teorico tra Caffè e Modigliani riguardò anche un altro decisivo tema: l’introduzione, a livello europeo, di un sistema di cambi (semi)fissi, il cosiddetto Sistema monetario europeo (SME) Anche in questo caso i due economisti si trovarono sui lati opposti della barricata: da una parte Modigliani, sostenitore dello SME, dall’altra Caffè, nettamente contrario.
Caffè vedeva nello SME uno strumento per “legare le mani” alle autorità politiche e monetarie nazionali e, soprattutto, denunciava i costi che ne avrebbero pagato i paesi e le classi più deboli. Per Caffè, infatti, “i regimi di cambio fisso tra paesi economicamente eterogenei sono sempre deleteri” (p. 153). A suo avviso, al contrario, occorreva “dotare il paese di maggiori strumenti di intervento economico, invece che privarsene tramite l’approfondimento del processo di integrazione economica e monetaria a livello comunitario, il quale – come riporta Fazi – non avrebbe fatto che “aumentare la nostra vulnerabilità e dipendenza” (p. 157).
Il PCI, in questo caso, al momento della votazione in aula (dicembre 1978), si schierò contro lo SME. Fu Giorgio Napolitano a mettere in guardia sulle conseguenze nefaste per l’Italia – ma soprattutto per i lavoratori italiani – che avrebbe comportato l’adesione al Sistema monetario europeo, in cui, peraltro, “vedeva profilarsi il rischio di un dominio dell’economia tedesca a danno di quella italiana” (p. 164). L’adozione del nuovo meccanismo di cambio europeo, progenitore della moneta unica, infatti, significava “disinnescare il conflitto distributivo e addossare alle richieste sindacali la responsabilità della perdita di competitività del paese, facilitando una maggiore flessibilità verso il basso dei salari” (p. 165). Significava, in definitiva, creare un potente vincolo esterno che – come ebbe a dire sempre Napolitano – avrebbe spianato la strada a misure drastiche di restaurazione sociale.
Ciò che ne seguì è noto. Nonostante il voto contrario del PCI e l’astensione del PSI, infatti, il parlamento approvò l’adesione dell’Italia allo SME, con conseguenze poco felici per il nostro paese, considerati soprattutto “la comparsa di un deficit estero strutturale e un significativo rallentamento della crescita” (p. 167). Una scelta economica fortemente connotata politicamente (così come le successive tappe del processo di integrazione europea) “finalizzata a un obiettivo ben preciso: disciplinare i lavoratori” (p. 168). Lo SME, infatti, scrive Fazi, “rappresenta un esempio da manuale di quel processo di depoliticizzazione” (ibid.) messo in campo dalle classi dominanti occidentali come argine al conflitto distributivo emerso nel corso degli anni Settanta.
L’adesione allo SME ebbe come “inevitabile conseguenza” – così come si espresse l’allora ministro Beniamino Andreatta – il celebre divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia del 1981. Una decisione, mai ratificata dal parlamento, che “mise progressivamente fine alla parziale monetizzazione del deficit pubblico e al calmieramento dei tassi di interesse da parte della Banca d’Italia” (p.170). Prima di allora, infatti, spiega Fazi, “il debito accumulato dal Tesoro nei confronti della banca centrale non costituiva assolutamente un debito reale verso essa” (p. 171). Ma dal 1981 in avanti, stabilendo che la banca centrale non fosse più tenuta ad acquistare le obbligazioni che il governo non riusciva a piazzare sul mercato, si rendeva lo Stato sempre più dipendente dai mercati finanziari.
Federico Caffè giudicò un “errore gravissimo” la scelta di separare Tesoro e Banca d’Italia, errore che avrebbe vincolato tutte le successive scelte di politica economica. A partire dal 1981, infatti, comincia la graduale esplosione del rapporto debito/PIL: una manna dal cielo per i ceti dominanti che, a partire dagli anni Novanta, potranno giustificare tutte le più drastiche politiche di restrizione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, apportando ragioni tecniche di mera contabilità che nascondevano, però, precise scelte politiche.
- Una voce isolata, una voce attuale
Gli anni Ottanta sono il decennio della grande controrivoluzione neoliberista. In tutto l’Occidente si procede allo smantellamento degli strumenti “keynesiani” di cui si erano dotate le democrazie nel secondo dopoguerra, si va sempre più speditamente verso la deregolamentazione dei mercati e della finanza, si attaccano senza particolari scrupoli i sindacati e il mondo del lavoro e si assiste all’ascesa di un “nuovo spirito del capitalismo” fondato sull’elogio dell’individuo, del consumismo, della competitività. Una vera e propria rivoluzione antropologica con dei precisi contraltari politici: Margaret Thacher in Gran Bretagna, Ronald Regan negli U.S.A.
In Italia, intanto, prende sempre più quota – a partire dall’Atto unico europeo firmato nel 1986 dal governo Craxi – quel processo che si sarebbe concluso con il Trattato di Maastricht (1992), a partire da cui verranno fissati i criteri per l’adesione alla futura Unione europea: indipendenza assoluta della BCE dagli Stati nazionali, flessibilizzazione del lavoro, limiti al deficit e al debito pubblici. L’obiettivo era creare un mercato unico europeo che, sebbene nella retorica dei proponenti avrebbe costituito uno “spazio sacro” di libertà economica, nei fatti condusse l’Italia in una situazione che la esponeva strutturalmente al giudizio dei mercati finanziari internazionali.
Caffè polemizzò con toni aspri contro le “accresciute ingerenze della CEE” (p. 186) negli affari economici italiani. Ma la sua voce era ormai sempre più isolata, dal momento che anche la sinistra comunista, dopo forti perplessità, ora cominciava a manifestare il suo aperto sostegno al progetto di integrazione europea e assumeva su di sé le parole d’ordine dell’austerità e della lotta all’inflazione. Molto probabilmente per ragioni di consenso, come amaramente constatava lo stesso Caffè, convinto invece della natura “classista” del progetto di integrazione europea e della natura ideologica e strumentale dell’allarmismo economico.
Non è un caso che, al processo di integrazione, corra parallela la stagione delle privatizzazioni, quasi fosse un indicatore perverso della riuscita di un disegno anti-popolare: dalla ristrutturazione dell’IRI durante la presidenza Prodi (1982-89) che determinò la cessione di numerose aziende pubbliche, alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, passando per la vendita di quote di aziende come Alitalia. Le motivazioni della “svendita” facevano perno su di un mito a cui era difficile contrapporsi: l’inefficienza congenita del pubblico. Caffè, tuttavia, faceva notare come quest’idea fosse del tutto infondata: se di inefficienza si deve parlare, questa non è ascrivibile al carattere intrinsecamente deficitario del pubblico, ma alla gestione malaccorta o interessata delle classi dirigenti.
Ma la sua voce era sempre più isolata, i suoi moniti inascoltati. Aveva già lasciato l’insegnamento universitario quando, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1987, abbandonerà la sua abitazione romana senza lasciare traccia. Non sono ancora stati chiariti i motivi di questa scomparsa, ma la sua voce oggi risuona tra chi non si rassegna allo stato di cose presenti, tra chi sa che “qualunque regime socioeconomico è innanzitutto un costrutto politico-ideologico” (p. 214), tra chi auspica una piena ri-politicizzazione della dimensione economica.
Merito di Thomas Fazi è averci restituito con chiarezza e precisione tutta la vivacità e la scottante attualità del suo pensiero, ricostruito attraverso una attenta disamina dei sui scritti, utili quanto mai per leggere e comprendere il presente.
Fonte: https://www.lafionda.org/2022/11/25/federico-caffe-e-la-ri-politicizzazione-delleconomico/



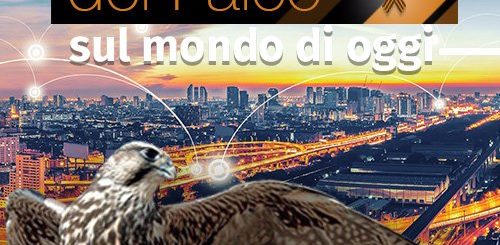




























Commenti recenti