La procreazione assistita è un diritto? Sì, no, forse
di SCIENZA IN RETE (Eva Benelli, Maurizio Bonati)

Dal primo di aprile la procreazione medicalmente assistita entra a far parte dei Livelli essenziali di assistenza, così procedure e tecniche che a lungo hanno dovuto fare i conti con un certo ostruzionismo diventeranno un diritto riconosciuto dell’offerta di salute del Servizio sanitario nazionale. Ma è proprio così? I Lea più che garantire lo stesso diritto per tutti, fanno emergere piuttosto una realtà di diseguaglianze. Anche culturali, come testimoniano le opposte visioni che tuttora esistono sulla legge 40, che il 19 febbraio compie 20 anni.
Forse la cosa più utile è cominciare dai numeri: nel 2021, anno a cui si riferisce l’ultima Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 40, pubblicata a novembre 2023, il 4,2% dei bambini e delle bambine che hanno visto la luce in Italia lo hanno fatto grazie a una tecnica di procreazione medicalmente assistita (Pma) cui si sono sottoposti i loro genitori.
Il che vuol dire che circa 16.000 sull’esiguo numero di poco più di 400.000 nuovi nati sono figli della Pma.
Nel complesso, nei 20 anni dall’entrata in vigore della legge 40 che ne regola l’attività, la Pma è aumentata di quasi due volte: dai 63.585 trattamenti del 2005 ai 109.755 del 2022, sottolinea un aggiornamento che l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato il 9 febbraio.
L’età media delle donne che si sottopongono a cicli di Pma è passata dai 34 anni del 2005 ai 37 del 2022, mentre le donne sopra i 40 anni sono salite dal 20,7 nel 2005 al 33,9% nel 2022. Un crescente successo, quindi, sancito anche dall’inserimento delle tecniche di Pma nei Lea, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve (dovrebbe?) garantire a tutte le persone che si trovano nel nostro Paese.
Un cambiamento importante, a far data dal primo gennaio 2024, anche se poi, nei fatti, al 31 dicembre 2023 si è decisa una proroga di tre mesi all’entrata in vigore delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale, che riguardano naturalmente anche le tecniche di procreazione assistita, con relativo slittamento al 1° aprile.
Il difficile percorso della PMA pubblica
«Con i Lea abbiamo ottenuto la legittimazione delle cure, che diventano un diritto per tutte le coppie che ne hanno la necessità», commentava Antonino Guglielmino, fondatore della Società italiana della riproduzione umana (Siru) nel corso di un convegno che già a fine novembre ’23 delineava luci e ombre che le pratiche procreative, nella loro nuova condizione, si troveranno a dover affrontare.
L’entrata nei Lea, infatti, significa l’inclusione della Pma nell’offerta del Servizio sanitario nazionale, ed è certamente un risultato importante per una pratica medica che in Italia ha dovuto combattere per essere riconosciuta e accettata. Vuol dire, anche, aprire alla speranza di potersi fare una famiglia per tutte quelle coppie che finora hanno dovuto rinunciare perché non disponevano delle migliaia di euro necessari per affrontare un percorso nelle strutture private (dai 3.500 ai 10.000 euro per ogni ciclo, a seconda che fosse omologo o eterologo).
Ma il raggiungimento di questo traguardo avviene in un momento di crisi complessiva del sistema sanitario e di quelle specifiche diseguaglianze nell’offerta di cura che si riscontrano (come sempre avviene nel nostro Paese) tra Nord, Centro e Sud e tra qualità ed efficacia dei servizi offerti. Senza contare che da subito è noto che le risorse stanziate non sono adeguate e il numero delle strutture, mettendo insieme pubblico e privato convenzionato, è insufficiente. Su un totale di circa 340 centri iscritti al Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita, quelli pubblici sono un terzo di quelli privati. Mentre se si considerano solo i centri di secondo e terzo livello, cioè quelli che eseguono gli interventi più complessi, come la fecondazione in vitro o il prelievo chirurgico degli spermatozoi, allora quelli pubblici sono 72 a fronte di 17 privati convenzionati e 113 privati.
«La domanda che fino a oggi non poteva essere soddisfatta perché le coppie non trovavano sul territorio un centro pubblico a cui rivolgersi o perché non avevano le risorse per affrontare un percorso nel privato potrebbe raddoppiare e il timore è che il sistema pubblico non sia in grado di assorbirla», pronostica Guglielmino.
Difficile comunque avere idea di che cosa copra l’offerta rispetto alla domanda, perché quest’ultima non la si conosce. Possiamo sapere quante coppie intraprendono il percorso, ma quante lo chiedono o lo vorrebbero chiedere, no. E sarebbe, invece, il denominatore vero, quello che anche la ricerca indipendente, non solo quella legata alle tecniche e alla loro ottimizzazione, dovrebbe definire.
Insieme alle difficoltà di un sistema che si deve adeguare, dopo vent’anni di percorso per lo più a carico delle coppie che cercavano di procreare, ci sono anche i limiti oggettivi delle risorse da mettere in campo e le procedure previste proprio da quei tariffari per cui è stata decisa la proroga.
«Il dibattito sulle coperture dei costi è aperto – commenta per esempio Adolfo Allegra, che presiede la società scientifica Cecos Italia – le valorizzazioni sono spesso inferiori ai costi. Quindi probabilmente sarà necessaria un’integrazione che o verrà sostenuta dalle Regioni o, purtroppo, graverà sui pazienti». Come dire: là dove le Regioni non saranno in grado di integrare le risorse, non si esclude la possibilità di dover far pagare un ticket.
I 20 anni di una legge poco lungimirante
Comunque, anche se le difficoltà non mancano, l’approdo della procreazione medicalmente assistita nei Livelli essenziali di assistenza ha del miracoloso (è proprio il caso di dirlo) perché la resistenza soprattutto da parte del mondo cattolico verso le tecniche procreative è stata lunga e accanita.
Alla fine, il 19 febbraio 2004, quando è entrata in vigore la legge 40, conosciuta come legge Sirchia dal nome del suo estensore l’allora ministro della salute Girolamo Sirchia, le coppie che speravano di vedere riconosciuto e semplificato il proprio desiderio di diventare genitori, si accorsero invece che erano tanti e non sempre ragionevoli i vincoli e gli ostacoli che la legge aveva previsto sulla strada della Pma. Tanto che quest’anno non ricorrono solo i 20 anni dalla promulgazione della legge, ma anche i 10 dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa che faceva parte dell’impianto originale e che ha dovuto essere smontato.
Così come sono stati smontati altri vincoli, il cui intento sembrava deliberatamente restrittivo, se non punitivo: dal divieto di effettuare diagnosi pre-impianto, avviando comunque una gravidanza che poteva avere un esito incerto; all’obbligo di non produrre più di tre embrioni per ogni ciclo di fecondazione da impiantare tutti e tre contemporaneamente, aumentando il rischio di gravidanze e parti gemellari. Non per niente il numero medio di embrioni trasferiti in utero è passato da 2,3 nel 2005 (prima della modifica della legge) a 1,3 nel 2022 e la percentuale di parti multipli è scesa dal 23,2% del 2005 al 5,9% del 2022 (il percorso delle modifiche si può consultare qui).
Suona inoltre quasi beffardo che tra la fecondazione omologa, cioè quella che impegna i gameti della coppia e quella eterologa (inizialmente vietata) che fa ricorso a gameti provenienti da donatori e donatrici, è questa seconda a dimostrare i migliori risultati: 31 figli nati vivi a fronte di 17, quasi il doppio.
«La fecondazione omologa non riesce a schiodarsi da un tasso medio di 17 nati vivi ogni 100 coppie, valore che, se si considerano i parti gemellari, significa che non più di una donna su sei di quante ricorrono alla Pma […] riesce a ottenere quel figlio al quale tanto anela. Un tasso di successo, com’è facile concludere, che proprio di successo non è […] a maggior ragione in quanto passano gli anni, ma questa pratica non mostra di migliorare sotto il profilo dell’efficacia», sottolinea lo statistico Roberto Volpi in un articolo pubblicato su La lettura il 28 gennaio scorso (e quanto possa essere totalizzante per una coppia il percorso di procreazione medicalmente assistita, costellato di difficoltà e fallimenti, ce lo mostra bene il film Private Life della regista americana Tamara Jenkins, da poco su Netflix).
I buoni risultati costano
Non stupisce quindi che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, il numero delle coppie che ricorrono all’eterologa sia in continuo aumento e i dati Iss ci confermano che se nel 2014 i cicli realizzati con gameti donati erano 246, un misero 0,3%, nel 2022 sono saliti a 15.131, pari al 13,8%.
Purtroppo qui si genera un altro fattore di spesa perché la quasi totalità dei trattamenti viene effettuata con gameti importati dall’estero, che sono costosi. La normativa europea prevede che la donazione dei gameti sia volontaria e gratuita ma lascia aperta la possibilità di un indennizzo per recuperare, per esempio, le ore di lavoro perso o il costo della stimolazione ormonale. L’Italia finora non ha recepito queste indicazioni e il risultato è che sono davvero poche le donne italiane che hanno donato i propri ovociti. Una limitazione importante, che rischia di rendere inutilmente laborioso e costoso per le persone proprio il trattamento che dimostra i migliori successi. «I nuovi Lea non prevedono l’acquisizione dei gameti dall’estero, quando invece in Italia è quello che si è obbligati a fare per almeno il 97% dei casi», conferma Allegra. Ed ecco profilarsi di nuovo il rischio di una disparità tra le Regioni perché alcune hanno attivato una banca regionale centralizzata per acquisire e distribuire i gameti, mentre là dove la banca non c’è procurarseli continuerà a gravare sulle coppie. Neanche le indagini diagnostiche sull’embrione, che ora non sono più vietate, sono state inserite nei Lea e quindi il loro costo rimane a carico degli aspiranti genitori. E c’è da augurarsi che ci si limiti a questo. Il rischio di disuguaglianza nell’accesso ai trattamenti, infatti, non sembra peregrino e se il processo di autonomia differenziata dovesse arrivare a termine, è difficile che non si mantengano comunque quei “viaggi della speranza” o, per dirla con linguaggio sanitario quella “mobilità passiva” che anche nel campo della procreazione medicalmente assistita hanno contraddistinto le regioni del Sud da quelle del Nord.
A ben vedere, il problema è sempre lo stesso e proprio i Lea lo mettono in evidenza: tra stabilire delle regole e realizzare quanto stabilito ce ne corre, specialmente quando possono esistere diverse interpretazioni di una legge, come avviene per la legge 40. Nel mondo reale i Lea finiscono con essere indicatori di disuguaglianza e non risolutori. Lo si è visto con la migrazione sanitaria e i percorsi assistenziali per l’autismo, ma anche per i tempi, modalità e qualità delle liste d’attesa, o dei farmaci dichiarati carenti perché non reperibili, anche per le terapie croniche.
Gli esclusi
Nonostante gli interventi correttivi apportati dieci anni fa in direzione di un’apertura delle sue modalità di applicazione, la legge 40 continua a escludere dall’accesso alla Pma le donne single e le coppie omosessuali, con il paradosso che contemporaneamente la legge sulle unioni civili ha riconosciuto alle persone dello stesso sesso il diritto di formare una famiglia. Tuttavia se si rivolgono all’estero per praticare la fecondazione eterologa o la gestazione per altre persone, ricadono nella difficoltà di ottenere poi per entrambi i genitori il riconoscimento della filiazione. Ne abbiamo parlato qui e qui. E i fatti di cronaca uguali e contrari degli ultimi giorni confermano il caos esistente: il 6 febbraio la Corte d’appello di Milano accoglie il ricorso della Procura ed esclude dal certificato di nascita la madre intenzionale di una coppia di lesbiche, mentre due giorni dopo la Corte d’appello civile di Brescia respinge un analogo reclamo.
«Le persone singole o Lgbt sono escluse dei metodi di riproduzione assistita perché persiste l’idea razzista e antiscientifica che possiamo propagandare il nostro comportamento Lgbt, o peggio che possiamo compiere atti pericolosi per i figli, in assenza di qualsivoglia dato razionale», denuncia in una lettera a Quotidiano Sanità, Manlio Converti, psichiatra e presidente di Amigay, un’associazione che riunisce il personale sanitario nella difesa dei diritti delle persone Lgbt.
Di fatto, nella lettura e nell’interpretazione dello spirito della legge si contrappongono tuttora, anzi oggi più che mai, due visioni opposte e inconciliabili, quella cattolica e quella laica e aggiornata ai tempi attuali. Un esempio del dibattito tuttora aperto ci arriva dalla lettura contrapposta che fanno Assuntina Morresi su Avvenire e Maurizio Mori su Quotidiano Sanità. Secondo Morresi la legge 40, a dispetto degli interventi della Corte costituzionale, è riuscita comunque a mantenere la sostanza e la forza del suo impianto nell’inserire le nuove tecniche riproduttive nel «modello antropologico che prevede la procreazione naturale e i legami parentali che ne derivano». In vista di questo superiore obiettivo la legge 40 avrebbe rinunciato a essere “una legge cattolica” contraria a ogni tecnica riproduttiva, aprendosi in favore delle sole coppie eterosessuali sposate o persino conviventi che non riescono ad avere i figli desiderati per vie naturali. «In Italia – scrive Morresi – la fecondazione assistita non è una scelta procreativa per tutti, ma una opportunità offerta dallo sviluppo tecnologico alle coppie infertili, per cercare di metterle nelle stesse condizioni di quelle fertili». Insomma, i cosiddetti nuovi diritti, secondo Morresi, non sono una necessità ineludibile.
Mori risponde che all’entrare nel laboratorio riproduttivo è ben noto che l’obiettivo del concepimento, non è il risultato di una terapia, ma della scissione della sessualità dalla riproduzione. E che, se si accetta come buono che una coppia (perché non una persona?) entri in laboratorio, così come concede la legge 40, allora tutte le conseguenze sono necessariamente buone. «Oggi nulla è più come prima, perché se si affida il concepimento al laboratorio, si riconosce che è bene che la tecnica sostituisca parti della natura per allargare, scomporre o potenziare le capacità riproduttive. Non si può poi più dire che tutto il resto rimanga come prima, perché il laboratorio apre orizzonti nuovi che sollecitano esigenze nuove». Per assurdo, i Lea potrebbero essere diversi per la comunità cattolica rispetto a quella agnostica, e quindi convivere laboratori cattolici con tecniche e percorsi diversi da quelli adottati nei laboratori laici. Un po’ come avviene, nei fatti e malamente, per l’obiezione all’aborto.
Certo è che se non si parte dal riconoscimento dei diritti della coppia, dei singoli e del nascituro, le diseguaglianze potranno essere solo ridotte, ma il diritto non garantito a tutti.


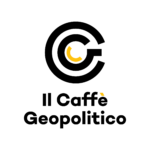




























Commenti recenti