Il politico e la guerra (seconda parte)
di RADICI E FUTURO (Eduardo Zarelli)
(continua)
Ecco quindi il secondo autore al centro della nostra riflessione, per il quale l’analisi del conflitto nella storia ha il medesimo peso, ma porta a esiti ben diversi. Fabio Falchi è un intellettuale non accademico, il quale ha realizzato un’opera che, indipendentemente dal giudizio di valore di cui argomenteremo, ha una dignità storiografica unita a una sostanza argomentativa che ben si affianca al lavoro di Filippo Andreatta, ma che più in generale non si rintraccia nell’usuale produzione scolastica o universitaria in tema polemologico. Il suo saggio Il politico e la guerra (Anteo Edizioni), si sviluppa per centinaia di pagine in una ricostruzione dettagliatissima del fenomeno bellico come condizione antropologica del conflitto. Rifuggendo dall’individualismo metodologico dominante, se è vero che aristotelicamente il destino degli uomini è di “Essere-insieme”, vale a dire che l’uomo è, in primo luogo, un “animale politico”, il conflitto è consustanziale alla condizione culturale dell’essere umano che, per dirla con Arnold Gehlen, è un individuo non specializzato. L’uomo è proiettato heideggerianamente, per mezzo della tecnica, in un progetto di vita composto da un “intreccio” tra il politico, l’economico e il conflitto stesso. Si potrebbe quindi affermare, con Alain de Benoist, che «la guerra rimarrà sempre una possibilità, perché non si potrà mai fare scomparire ciò che la provoca, ovvero la diversità virtualmente antagonistica delle aspirazioni e dei valori, degli interessi e dei progetti», tanto che anche in una distopica mondializzazione realizzata, il conflitto si sottrae in soggetti pubblici riconoscibili, per moltiplicarsi in guerra civile virale generalizzata. L’opera è suddivisa in due parti distinte: “Terra e Mare” (primo volume), che tratta dei conflitti fino alle guerre napoleoniche, e “Maschera e Volto dell’Occidente” (secondo volume), in cui l’accento cade sulla stretta connessione tra la funzione politico-strategica dell’economico e la “pre-potenza” della grande talassocrazia d’oltreoceano, come esito non scritto del processo di civilizzazione della “forma capitale”: una connessione così stretta che “pax americana” e barbarie occidentale appaiono ormai come due facce della medesima medaglia; in questo secondo volume, infatti, si prendono in esame i conflitti dall’Ottocento fino ai nostri giorni, contestualizzandoli però in quelle profonde trasformazioni politiche e sociali che in poco più di due secoli hanno cambiato radicalmente il destino planetario, ove la “occidentalizzazione del mondo” si fa prometeico mondialismo di uno sviluppo illimitato in presenza di risorse date, cioè limitate. Ciò nonostante, la potenza statunitense, dopo la scomparsa dell’Unione Sovietica, tenta di sottoporre l’intero Pianeta alla propria egemonia, ma la stessa crisi economica che attanaglia il mondo occidentale è, in primo luogo, crisi degli equilibri geopolitici mondiali fondati sull’unilateralismo occidentale: «Vale a dire che non è il capitale finanziario in quanto tale ad articolare i rapporti di dominio caratteristici del sistema capitalistico mondiale, bensì le strategie politiche che il gruppo di potere, “definito” dall’alleanza tra una classe capitalistica e uno Stato egemone, adotta per contrastare potenziali centri di potere antiegemonici». Quindi non solo bisogna intendere, con Karl von Clausewitz, la natura politica della guerra, ma anche, con Niccolò Machiavelli, che la politica è la prosecuzione della guerra con qualsiasi mezzo, compreso il denaro, metro di misura dell’economicismo dominante. Fabio Falchi, padroneggiando le categorie metapolitiche schmittiane – Terra, Mare, “grande spazio” – riesce a sottrarsi a una lettura deterministica dello strutturalismo materiale dei rapporti di forza sociali e internazionali. Pur confrontandosi con gli strumenti analitici marxiani di Gianfranco La Grassa del cosiddetto “conflitto strategico” per cui l’attenzione va posta con positivistica metodologia sulle strategie tra agenti sociali in reciproco scontro per raggiungere la supremazia nello scenario geopolitico contemporaneo, in uno squilibrio incessante di fasi capitalistiche policentriche e monocentriche, Falchi ha una lettura indipendente dell’autonomia del “politico”, la quale rimanda al nostro “Essere-nel-Mondo” non limitatamente alla dimensione storico-geopolitica, che potremmo definire filosofica, ontologica, ma anche geofilosofica e – ci permettiamo di dire – spirituale dell’esperienza umana. Debitore della sua formazione a Giorgio Colli, per cui la complessità teoretica di categorie e deduzione si risolve in una interpretazione della totalità della manifestazione come “espressione” di qualcosa (l’immediatezza) che sfugge alla presa della conoscenza, rimanda alla phronesis (φρόνησις) “saggezza” o anche “intelligenza” come archetipo sapienziale del pensiero. Falchi si muove cioè a suo agio con categorie culturali non riduzionistiche, scientiste, per esprimersi diagnosticamente con realismo nell’oggi, ma traguardando nella prognosi oltre il moderno. In ciò risulta emancipato dalle appartenenze delle tarde famiglie ideologiche novecentesche e del discrimine destra/sinistra, intellettualmente partecipe di un’elaborazione metapolitica delle cosiddette “nuove sintesi”. Questo è definito in modo ulteriormente chiaro nel suo ultimo recentissimo titolo pubblicato, Comunità e conflitto. La terra e l’ombra (Anteo Edizioni), ove si chiude la riflessione sviluppata nei due volumi sopra indicati; è cioè ormai evidente, per l’autore, che l’emergere di nuove potenze antiegemoniche e la questione di nuovi soggetti politici realmente “antagonistici” nei confronti della “società del capitale” non sono che due facce della medesima medaglia. In quest’ottica, è logico che anche la questione della sovranità dello Stato, della tutela dei legami comunitari e della stessa “cittadella interiore” dell’uomo debba essere compresa alla luce dei conflitti del Novecento e del declino relativo dell’attuale Stato egemone capitalistico. Fabio Falchi cioè pone la questione non solo di una contrapposizione politica all’affermazione della dismisura dell’homo oeconomicus, ma anche quella fondativa di un paradigma ulteriore a quello della modernità. La ricostruzione del legame comunitario passa per una junghiana “simbolica dello spirito”, che pone l’esigenza di una ricomposizione dello iato tra cultura e natura. Quest’ultima non può essere schiacciata dalla dialettica tra il determinismo meccanicistico o la fuga nella suggestione irrazionale: «La natura, difatti, è in primo luogo un “campo di forze elementari”, aperto all’agire dell’uomo e al tempo stesso una lingua cifrata che ci rivela lo “spazio interiore del mondo”». Questo punto è fondamentale, in quanto il conflitto pone la questione del relativismo culturale unito alla volontà di potenza. Carl Schmitt aveva visto, con lucidità profetica nell’epilogo dei conflitti novecenteschi, come «l’universalismo dell’egemonia anglo-americana» fosse destinato a cancellare ogni distinzione e pluralità spaziale in un “mondo unitario” totalmente amministrato dalla tecnica e dalle strategie economiche transnazionali, soggetto a una mistificazione legale e morale per mezzo di una supposta ‘polizia internazionale’. Un mondo spazialmente neutro, senza partizioni e senza contrasti, dunque senza politica. Il peggiore dei mondi possibili, sradicato dai suoi fondamenti tellurici. Fedele alla justissima tellus, Schmitt alimenta invece l’idea che non possa esservi ‘Ordnung’ (ordinamento) mondiale senza ‘Ortung’ (localizzazione), cioè senza un’adeguata, differenziata suddivisione dello spazio terrestre. Una suddivisione che superi però l’inerzia storica dei vecchi Stati nazionali, per approdare al principio dei “grandi spazi”: l’unico in grado di creare un nuovo jus gentium, al cui centro ideale dovrebbe porsi l’antica terra d’Europa, autentico katechon di fronte all’Anticristo dell’uniformazione planetaria nel segno di un unico “signore del mondo”. Spiega Jean-François Kervégan nel recentissimo Che fare di Carl Schmitt? (Laterza) che le analisi del giurista tedesco sono estremamente attuali, perché non esiste un diritto puro, autonomo o neutrale. Il diritto trova il suo fondamento in un atto politico, e la politica presuppone sempre il perseguimento del proprio interesse contro quello degli altri: implica dunque una pluralità di agenti e il rischio del conflitto. Per questo la guerra ci sarà sempre e non ha senso stigmatizzarla: è parte della lotta politica. Il problema è piuttosto come contenerla e regolarla, lasciando cadere le distinzioni morali tra buoni e cattivi: non ci sono guerre giuste, ma ci deve essere un «giusto», vale a dire delle regole rispettate, nella guerra. Così successe nell’età moderna ed è questo ciò a cui bisogna aspirare oggi per evitare di finire in una «guerra civile mondiale» senza limiti, in cui ciascuno si ritiene portatore di verità universalistiche assolute.
Falchi parla conseguentemente di lotta tra diverse “immagini del mondo”, di cui i gruppi umani sono sempre portatori, consapevolmente o meno. Se questa Weltanschauung si declina come dominio di sé (imperium), prospetta la possibilità di mutare lo scenario del moderno, vocando l’auctoritas nell’accettazione della diversità. Di contro, nel bellum omnium contra omnes di giusnaturalistica accezione, una potenza subornerà un’altra, nell’incedere unilaterale del belluino scontro di supremazia sull’altro da sé. Il mutamento di prospettiva richiesto esige cioè un confronto con l’essenza della tecnica, l’Essere e il nulla. Solo “oltre la linea” – per dirla con Ernst Jünger – si può superare il nichilismo, indurre al reincantamento della Terra, ridare frutto nella landa desolata del Mondo. Dato questo presupposto metapolitico, il conflitto può essere messo in “forma” dall’autonomia del politico, sottratto alla “neutralizzazione” dalla giuridicizzazione del primato economico liberalcapitalistico. La praticabilità della pace passa per l’accettazione del multilateralismo internazionale. Il titanismo dell’illimitato che accompagna l’unilateralismo egemonico occidentale si determina – al contrario – in una “strategia del caos”, che sollecita i rapporti di forza fino al rischio concreto di una deflagrazione globale, di cui siamo già testimoni, per quanto “a pezzi”, per esprimersi con l’approssimazione emotiva dell’attuale pontefice Jorge Mario Bergoglio. La deriva oligarchica delle democrazie procedurali, la disintegrazione dello stato sociale, la perdita di ogni dovere civico e della consapevolezza comunitaria del bene comune, sono la condizione interna della patologia esterna sopra indicata. In tal senso, pensiamo che l’autore converrebbe con quel magnifico Elogio delle frontiere (ADD Editore), scritto da Régis Debray solo alcuni anni fa; l’ex guevarista individua nella frontiera un bisogno naturale dell’uomo e dei popoli, come custodia del Sacro (termine che, come la parola “santuario”, deriva appunto dal latino sancire) e della propria identità individuale e culturale. Detto legame, che riconduce la frontiera al mito (o, meglio, svela nel mito il carattere fondante della frontiera), nell’analisi di Debray chiama in causa direttamente l’unità europea, questa creatura che, nata come comunità economica invece che politica, mostra al giorno d’oggi tutti i suoi limiti e le sue storture. Se difatti «nessun insieme può chiudersi all’aiuto dei singoli elementi del suo stesso insieme» (quello che Debray chiama «assioma d’incompiutezza») e se un insieme che si chiude è “un invito all’ascesa”, si capisce come, in questa comunanza tra immanente e trascendente, la chiusura si congiunge con una salita (l’obelisco, il campanile, la guglia) e la popolazione si fa popolo, tra sussidiarietà e decisione partecipata. L’Europa, dunque, nel suo rifiuto a darsi una forma e nella sua conseguente impossibilità di darsi un mito fondativo effettivo, non può incarnarsi in nulla e tantomeno riconoscersi in un Popolo. Oggi si tratta proprio di porre dei confini che declinino l’universale come riconoscimento del particolare, legittimando nella diversità un’identità comune, che possa fondare una mitologia d’appartenenza e possa permettere così di rivendicare una sovranità in tutte le sue forme. Non resti inascoltato il monito di Simone Weil ne La prima radice (SE): «Il radicamento è forse il bisogno più importante e misconosciuto dell’anima umana… L’essere umano ha una radice… Chi è sradicato sradica… Lo sradicamento è la più pericolosa delle malattie delle società umane». Osserva all’oggi Régis Debray, con analoga intenzione, che l’innalzarsi di muri, piuttosto che una degenerazione della frontiera, è una conseguenza del rifiuto di una demarcazione. Il muro diventa infatti la conseguenza della rimozione di un confine chiaro e concordato politicamente dalla pluralità delle parti. La frontiera è dunque un limite, indispensabile al ripristino di una sovranità (economica, politica, militare) sradicata dalla deriva nichilistica della mercificazione dell’esistente. Sulla sovranità come identità, partecipazione e giustizia sociale della collettività si gioca il rapporto amico/nemico del “politico”, nell’avversione concreta alla deriva oligarchica della globalizzazione.
Disse Aristotele: «Chi non conosce il suo limite tema il destino», il che è come affermare che nel limite, si manifesta una comunità di destino, anche di contro allo spirito dei propri tempi, perché la dignità della libertà di Essere non è contrattabile, pone in Forma sovrana il vivente.
Fonte: http://www.radiciefuturo.com/blog/2017/03/13/il-politico-e-la-guerra/



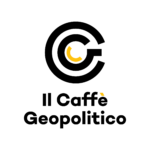




























Commenti recenti