Riletture, la crisi politica: Crouch, Rosanvallon, Urbinati
di SINISTRA RETE (Alessandro Visalli)
“La società dell’uguaglianza” è un testo del 2011 e corona magnificamente la trilogia sulla democrazia del politologo francese, che ora cerca più esplicitamente uno “spazio politico social-democratico” che lasci ferma la centralità dell’individualismo, e quindi il superamento della soluzione collettivista, tuttavia senza cadere nella disgregazione liberale. La dimensione “assicurativa” va quindi salvaguardata (o meglio recuperata) ma sotto forma di una capacitazione. Da una società dell’indennizzo ad una dell’inserimento.
Il tema diventa, in questo libro che si determina entro lo spettacolo della crisi, l’ineguaglianza e la disgregazione della società che comporta. La democrazia non è, infatti, solo una forma di governo o una tecnologia di controllo, ma è una ‘forma di società’.
Ma cosa ha significato “uguaglianza” nella storia della democrazia? Ci sono tre fasi per Rosanvallon:
– il XVIII secolo vedeva come tema la lotta ai “privilegi”, l’eguaglianza è morale e giuridica, non materiale,
– il XIX secolo la rivoluzione industriale porta al centro della scena la lotta alla povertà, l’eguaglianza che conta è quella delle dotazioni economiche,
– dal 1980 si ha un rovesciamento, ed emerge una “società della singolarità” che in sostanza disconosce il tema dell’eguaglianza per enfatizzare la competizione.
Negli anni settanta ed ottanta del settecento l’ideale che viene articolato, in contrasto con l’autopercezione della nobiltà di essere “distinta”, è una “società di individui indipendenti”, che non siano “vincolati” a specifici ruoli o poteri. Eguaglianza in qualche modo si confonde con libertà. Nella percezione dei contemporanei non c’è alcuna contraddizione tra “eguaglianza, libertà, fraternità”.
Bisogna fare attenzione, in una società che non ha ancora subito gli effetti destrutturanti e ristrutturanti della rivoluzione industriale, la “uguaglianza di mercato” è un’istituzione plausibile di lotta al privilegio. L’economia politica classica, quella di Adam Smith, è quindi inseparabile da una sorta di sociologia storica dell’emancipazione e dell’indipendenza, funzionale a tale emancipazione dai privilegi non giustificabili. Si tratta, in altre parole, di un liberalismo emancipatore ed egualitario nel contesto storico settecentesco. Il segno politico è esattamente opposto a quello nel quale è oggi per lo più usato.
Gli illuministi scozzesi (Rosanvallon si sofferma su John Millar) sviluppano un’accesa polemica con lo <<stato di dipendenza>> nel quale i contadini del loro tempo restavano vincolati. Alla terra ed ai padroni. In questa condizione l’espansione di attività <<proprie>>, da parte di negozianti ed artigiani, è “favorevole alla libertà e tende a stabilire una forma di governo popolare”. Se uguaglianza e libertà sono concetti connessi, “l’idea di reciproca utilità era pronta a rimpiazzare quella di autorità gerarchica, nel pensare la giusta direzione del mondo” (R., p. 43). L’enfasi su una società in cui “ognuno era padrone del suo destino, in quanto responsabile della sua sussistenza”, si comprende se si fa mente al quadro sociale dell’epoca. Altrimenti si leggono parole del tutto fuori del quadro di senso nel quale furono spese.
L’uguaglianza, insomma, non significa essere tutti eguali, ma che nessuno possa dominare totalmente un altro. In una prima fase (quella della rimessa in questione delle gerarchie aristocratiche) il denaro è letto come “grande livellatore” sociale. In ogni caso l’uguaglianza che è articolata dal secolo è principalmente di natura morale, e riesce a far retrocedere in secondo piano la percezione della disuguaglianza materiale.
È solo a partire dal secondo trentennio dell’ottocento che muove la distinzione tra ricchi e poveri come centrale. E alla metà che il discorso diventa non trattenibile.
È in questa fase che la contraddizione tra libertà ed eguaglianza viene tematizzata, e da parte degli scrittori liberal-conservatrici che ritornano sulle posizioni dei reazionari di una generazione prima: Villermé, Buret, Gilardin tornano su Burke e Necker. La miseria è il castigo della pigrizia e del vizio e la disuguaglianza è legge morale del mondo. Ma ci sono anche altre linee di attacco: la distinzione e il talento.
Su questa linea Guizot tenta una distinzione tra disuguaglianze “artificiali” e “naturali” e si recupera Darwin.
L’altro fronte mette sotto accusa l’anomia e la concorrenza, Rosanvallon ricorda Owen e Fourier, o Lammennais che dice “con la concorrenza non c’è libertà, poiché blocca i più deboli nello sviluppo delle loro facoltà e li lascia in balia dei più forti. Con la concorrenza, non c’è fratellanza, poiché è una lotta”. La soluzione è l’associazione e quindi il comunismo. Lavorando sulle radici dell’idea formalizzata da Marx, Rosanvallon ricorda le pubblicazioni di Cabet e la ristampa del Codice della Natura di Morelly, nel 1840; quindi l’opera Code de la communauté di Théodore Dézamy. Si tratta sempre di valorizzare i concetti di unità e fratellanza, radicalizzando l’idea giacobina di Unità e indivisibilità.
Scrive Dézamy: “la fratellanza è quel sentimento sublime che porta gli uomini a vivere come membri di una stessa famiglia, a mescolare in un unico interesse tutti i diversi desideri, tutta la loro potenza individuale […] l’unità consiste nell’identificazione indissolubile di tutti gli interessi e di tutte le volontà”. Si tratta di una qualità strutturale dell’ordine sociale, una sorta d’inclusione degli individui in un unico mondo. Rosanvallon la chiama “uguaglianza di corpo”. Non c’è concorrenza perché “per l’esattezza in questo quadro non c’è individuo autonomo … era dunque a partire da una semplificazione dell’organizzazione del genere umano che, in fin dei conti, ci si aspettava di abolire il regno della concorrenza. ‘Unità’ voleva dire soppressione degli antagonismi, impertinenza della differenziazione, indistinzione.” (R. p. 125)
In questa lettura, lo slogan che si ritrova nella Critica al Programma di Gotha, “Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni!” non è un principio fondante di diritti individuali. Si trattava di edificare un mondo deindividualizzato, di bisogni oggettivi, socialmente determinati. Proviamo a leggere il testo: “in una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto tra lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l’angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!” (Karl Marx, Critica al Programma di Gotha, Editori Riuniti, 1978, p. 32). E’ la società, non gli individui che scrive sulle bandiere.
Si tratta per Rosanvallon di un progetto antipolitico, e indubbiamente autoritario, nel quale non c’è spazio per voci discordanti o comportamenti devianti: “nella comunità antipolitica, l’uguaglianza è il frutto di una dipendenza e di una sottomissione comune. Gli uomini e le donne sono simili in quanto soggetti dell’organizzazione razionale e non in quanto individui autonomi che si fronteggiano” (R., p. 129).
In autori come Babeuf si trattava anche di spegnere la molla dell’invidia tramite l’educazione, una vera riconfigurazione antropologica e la soppressione della proprietà. Di più: dell’idea stessa di possesso personale. Una idea simile si nutriva dell’idea di una società dell’abbondanza, dove una ristretta quantità di beni necessari viene prodotta in grande quantità.
L’idea strutturale, che si ritrova ben formulata in Owen è di un nesso tra:
– abbondanza (di beni di base, per bisogni “naturali”),
– frugalità (mancanza di desiderio in beni innaturali o distintivi)
– produttività.
In modo che ognuno produca più di quel che è in grado di consumare, e nessuno desideri di più. Si tratta anche dell’estinzione dell’economia (scienza della penuria). In un mondo deindividualizzato viene soppressa radicalmente la concorrenza. Un mondo dell’identico, dove nessuna mediazione è più necessaria perché tutti si identificano in un unico e medesimo corpo (Rosanvallon cita il Marx de Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica e anche le Observations morales di Dom Deschamps del 1770, come antecedente).
La concorrenza viene sradicata in questa vasta ed articolata visione su più piani: sul piano giuridico (eliminazione della proprietà), sociologico ed economico (ordine comunitario), morale ed antropologico (sradicamento di egoismo ed invidia), ontologico (eguaglianza assoluta).
Ci sono altre posizioni, tra queste il nazional-protezionismo che si afferma già nella metà dell’ottocento.
Ma è dalle lotte, furiose, per l’imposta progressiva (nel 1914 in Francia) che si apre “il secolo della redistribuzione” che riduce in modo spettacolare l’ineguaglianza ottocentesca. È l’effetto di tre direzioni di riforma:
– l’imposta progressiva,
– la società assicurativa,
– la regolazione collettiva del lavoro.
Esattamente le tre direzioni rimesse in questione nella svolta neoliberale.
Il rovesciamento, si ha infatti con la svolta degli anni ottanta, e la seconda grande mondializzazione (o terza). Le disuguaglianze sono quasi tornate al livello della metà dell’ottocento, sono risorte le figure patologiche della fine del secolo (nazionalismo e xenofobia), anche l’idea di nazione è in forte ripresa; “ma, come al tempo di Barrès, non viene rivendicata per dare un corpo socialmente più consistente al popolo introvabile della democrazia elettorale, al contrario, viene esaltata per esorcizzare le difficoltà della costruzione pratica di una società di simili. Ancora una volta serve per pensare alla comunità in modo semplificato, come unità negativa, come un’omogeneità che si presuppone ovvia. Tutto questo ha un furioso gusto di una déja-vu” (R., p. 211).
Nello stesso anno, con diverso approccio e maggiore verve polemica, Colin Crouch scrive “Il potere dei giganti”, in cui si chiede come mai la crisi non ha affatto sconfitto il neoliberalismo. La risposta è che il neoliberalismo è l’ideologia di un attore economico e sociale dominante. Non è affatto una teoria favorevole al mercato e da qualsiasi fallimento del mercato non può essere confutata.
Il neoliberismo è l’ideologia delle imprese giganti.
Dunque è l’ideologia conforme ad uno degli attori predominanti: allo Stato ed al mercato va aggiunto il sistema delle imprese giganti, che Crouch vede distinto e contrapposto ad entrambi.
L’autore sottolinea un punto che in genere si dimentica: c’è una tensione tra le posizioni liberali, anche radicali, che restringono il ruolo dello Stato alla protezione della concorrenza (ad esempio quelle “ordoliberali”) e il liberalismo della Scuola di Chicago che è progressivamente e quasi inavvertitamente slittata verso la tesi che i prezzi devono essere lasciati liberi nelle condizioni di fatto presenti. Questa tesi implica, e non è un caso, anche l’abbandono della lotta ai monopoli. Salvo che siano pubblici.
Le multinazionali sono garanzia di un “incremento globale di efficienza” e comunque ripristinano la concorrenza tra di loro, anche se ognuna ha aree di monopolio (o monopsonio) che protegge gelosamente.
In sostanza il neoliberismo ha come vettore centrale la classe dei capitalisti finanziari e centro le principali piazze, dalle quali si è espanso in tutto il mondo (C. p. 131); per questo resiste.
Da ultimo nel 2013 Colin Crouch termina la sua trilogia con “Quanto capitalismo può sopportare la società”. Se nel primo aveva denunciato il degrado della democrazia e nel secondo indicato l’attore centrale per il quale le ideologie di sostegno postdemocratiche lavorano, nel terzo prova ad individuare le linee essenziali di una nuova missione della socialdemocrazia.
Mentre Rosanvallon, certamente più legato ai temi ed alla pratica della cosiddetta “terza via” di cui invece Crouch è aspro critico, enfatizzava la capacitazione e il riscatto individuale, il politologo inglese tenta di definire le linee guida di una “socialdemocrazia assertiva”.
La strada per una socialdemocrazia forte è in sostanza di “mettersi al centro di una famiglia di campagne e movimenti” (p.198), ponendo le giuste questioni (disuguaglianza e potere), e cercando di avere un approccio dinamico e offensivo. La socialdemocrazia, per Crouch, ha infatti senso solo se cambia le cose e fa la differenza, se è amica dell’innovazione e dell’originalità, se sostiene diritti e libertà.
Bisogna lasciare alla spalle la mossa della socialdemocrazia dell’avvio del millennio, la cosiddetta “terza via”, che invece di contribuire a riconfigurare il capitalismo per renderlo idoneo alla società ha lasciato che sia questa ad essere piegata e resa compatibile con l’accumulazione capitalista, cioè essere determinata dal “potere politico della ricchezza accumulata”. Il “potere politico della ricchezza” è però storicamente il nemico di tutto il pensiero e la prassi democratica che si definisce progressista (da Jefferson in America a Voltaire e Rousseau, o ai rivoluzionari in Francia, fino ai giorni nostri). Dunque la socialdemocrazia che si piega a questo potere, ritenendolo invincibile, tradisce la propria stessa ragione di esistenza.
Ma neppure è sufficiente limitarsi alle battaglie di conservazione, o per stabilizzare il lavoro che c’è. La soluzione dovrebbe essere forme energiche di flessicurezza (p 90).
Tra il compromesso sociale del nord Europa e quello del sud Europa, dove il primo vede sindacati forti e trasferimenti dallo Stato, con un welfare mediamente forte, ma più flessibilità ed il secondo forti protezioni per i lavoratori e basse per chi non è incluso, Crouch propende per il primo. Si tratterebbe di fare leva sulla politica sociale per rafforzare la competitività, calibrando aiuti e stimoli.
A questo quadro Giuseppe Berta, nel 2014, aggiunge un breve libretto “Oligarchie” che mette a confronto in modo sistematico diversi assetti oligarchici: il parlamento inglese in due epoche (1761 e 1860), le democrazie autoritarie orientali e la Cina con una oligarchia non democratica, ed infine l’Unione Europea.
Il confronto tra la globalizzazione “inglese” tra il 1870 ed il 1914 e quella “americana”, tra il 1990 ed oggi, mostra come in tutti i casi si sia trattato di un progetto di élite per restringere il campo delle decisioni a favore di limitati circuiti finanziari. Questa volta, in particolare, si tratta di riportare le lancette della storia a prima del Compromesso di Bretton Woods, e produrre una “democrazia oligarchica” rivolta a rimuovere, insieme alla democrazia popolare, la storia e il carattere dei popoli. È questa rimozione che non manca di provocare reazioni sempre più forti e giustificate per Berta.
Nel libro viene ricordata la posizione di Guido Carli, che rappresentò l’Italia al negoziato di Maastricht. Carli conduce la trattativa nella convinzione, maturata da lungo tempo, che l’Italia non potrà “riformarsi” da se stessa, secondo le auspicate linee liberali, senza essere costretta a ciò da vincoli istituzionali indisponibili alle pressioni sociali. Per questa ragione è per lui assolutamente necessario creare “un vincolo giuridico internazionale” per ripristinare una “sana finanza pubblica”. Secondo la sua visione, ancora oggi fortemente condivisa, lo stato dei conti e la stessa nazione ha bisogno di assoggettarsi ad un’autorità sovranazionale, “per sottoporre a disciplina i comportamenti di partiti e società” (come scrive Berti). La società italiana gli appare, infatti, in quegli anni “frammentata, lacerata, disorganica”, con una vita politica bloccata e indifferente.
Partendo da questa analisi, tutt’altro che priva di fondamento, Carli vede nel Trattato di Maastricht lo strumento per dare il necessario “scossone violento” che altrimenti solo un regime autoritario, come quello fascista, potrebbe dare (risposta dello stesso a chi lo invitava a maggiore azione nel suo ruolo di Ministro, p.100). Lucidamente Carli vede quindi che la <posta in gioco> del Trattato è <la riforma del potere>; cioè “la drastica riduzione del potere dei governi nazionali” alla quale, in una delle più incredibili e illuminanti affermazioni riportate nell’utile libro di Berta, Carli fa corrispondere nella sua valutazione “un accrescimento del potere decisionale dei singoli cittadini”.
Qui c’è il nodo ideologico, ed operativo, della costruzione della nuova Europa. Carli intende esattamente che l’indebolimento del potere dei Governi Nazionali (e dunque dei Partiti e dei Parlamenti democratici, ma anche delle organizzazioni sociali che influenzano la sfera pubblica nazionale) sia bilanciato da un maggiore <potere> dei <singoli> cittadini abilitati a <decidere>. Cosa? Cosa possono <decidere> i “singoli” che restano tali, cioè che non si organizzano o associano, che non partecipano a processi politici?
Lo dice lui stesso, con impareggiabile chiarezza di pensiero e franchezza, il potere residuale è nel diritto di investire i propri soldi nel debito pubblico o altrove. In altre parole la democrazia che resta è quella “dei mercati” e l’azionabilità è per censo. Con le sue parole: la “sintesi politica” è data dal “permanere del debito pubblico nei portafogli delle famiglie italiane, per una libera scelta, senza costrizioni, [cosa che] rappresenta la garanzia per la continuazione della democrazia” (p. 100, da G.Carli, Cinquant’anni di vita italiana, Laterza 1993, p. 386-7).
Questo i-n-c-r-e-d-i-b-i-l-e rovesciamento di due secoli di pensiero politico democratico, di ogni prassi democratica, di ogni lotta condotta in Europa dalla rivoluzione francese ad oggi, questo vero e proprio pensiero eversivo, è la ragione che il Ministro della Repubblica (che ha giurato sulla Costituzione Italiana), perfettamente cosciente di attuare una “rivoluzione del potere”, promuove nel negoziato. Cerca, insomma, l’implementazione di una “federazione europea basata sul principio dello <Stato minimo>, tenuta unita da una politica monetaria, da una politica estera e da una Difesa unitaria”. Questa Federazione è l’unica, a suo parere, che può resistere agli “urti che provengono da un mondo esterno che cade in frantumi”. Il mondo che cade in frantumi è, nel 1991, quello di Yalta.
Ridurre la partecipazione al fine di consolidare il potere di élite ed oligarchie convinte di poter guidare la navicella europea nei mari tempestosi del futuro in modo più consapevole e saggio rispetto ai cittadini stessi. L’unico punto in cui, secondo la visione dell’ex banchiere Carli, la voce degli uomini e le donne, che subiscono le conseguenze delle scelte fatte dagli esperti, può esprimersi è nelle individuali scelte di investimento. L’unica democrazia che può restare attiva è quella “dei mercati”. Detto in modo diverso, l’attuale condizione in cui il “potere” cui rispondono le azioni della BCE e della Commissione è determinato dai “mercati”, e dal sistema finanziario attraverso il quale si esprime, è assolutamente compresa, prevista, intenzionale. Si tratta di un rovesciamento della base stessa del potere democratico che si stenta a comprendere nella sua portata ancora oggi.
Da ultimo Nadia Urbinati, nel 2013, pubblica “Democrazia in diretta” nel quale vede agire fondamentalmente un meccanismo di disintermediazione agito da individui reciprocamente connessi attraverso l’ambiente tecnologico contemporaneo. Sono in corso processi poderosi di deprofessionalizzazione rivolti al mondo dell’informazione, ma anche alla stessa cultura ‘alta’. Tutti i vecchi ordini che proteggevano i discorsi stanno venendo meno.
Ma si deprofessionalizza anche la politica, anche internet e i social, o la blogosfera, afferma il politologo italiano trapiantato in USA, fanno ormai accedere la parola “nuda”, alla quale occorre rispondere, e ne fanno “strumento politico vero e proprio” (p. 186). In questa dinamica della parola tutti hanno la possibilità di essere indagatore e controllore. Una moltitudine di controllori intransigenti, difficili da mandare sulla ghigliottina (come accade a Desmoulins). Quel che accade è quindi che si accorciano le distanze e si crea direttezza.
Ci sono rischi, ma la democrazia, in effetti (e qui viene ampiamente citato Rosanvallon) non è sempre stata risiedente nella sfiducia e nella insoddisfazione? Cioè nella costante, opportuna e necessaria, insoddisfazione per promesse non mantenute (ed a ben vedere non mantenibili) e nella costante incompletezza.
Questa insoddisfazione, insieme ad un certo grado di fiducia, sono entrambe (nella loro reciproca opposizione non escludente) componente costitutiva della legittimità, perché “contribuisce a tenere sveglia la nostra capacità di sorveglianza, che costringe le istituzioni a sottostare all’ispezione ed al controllo, e infine innesca mutamenti istituzionali e funzionali” (p.31).
Ma il problema urgente è come difendere l’uguaglianza dei cittadini dalla espansione del potere. Sia esso di natura economica, o sia l’affermazione di una voce che si fa mandato attraverso la “direttezza”. Forzando il passo.


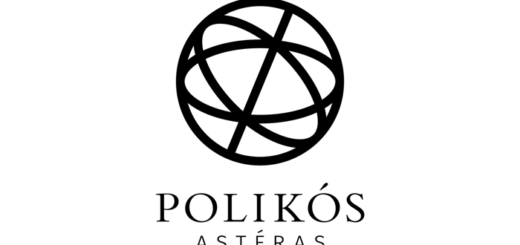





























Commenti recenti