Moriremo di scienza
di L’ INTELLETTUALE DISSIDENTE (Claudio Chianese)

La scienza moderna, nata come reazione dal basso alle indubitabili verità delle Scritture, viene oggi sottratta ai dubbi che provengono proprio dal basso; innalzata a rango di fede intoccabile da un instancabile esercito di sacerdoti televisivi. Per questo oggi è necessario difendere la scienza da se stessa, dalla tendenza a trasformarsi in una congrega di teologi, estranea alla società e insofferente al controllo democratico
mar Bradley è stato uno dei grandi generali americani del secolo scorso, e forse il più longevo: si è spento, quasi novantenne, nell’aprile del 1981. In un discorso tenuto nel 1948, Bradley dice:
Abbiamo molti uomini di scienza, ma pochi uomini di Dio. Abbiamo compreso il mistero dell’atomo e rifiutato il Discorso della Montagna. Il mondo ha sviluppato il genio senza la coscienza.
È semplice vedere in parole del genere lo spettro di quel massacro tecnologico che è stato la seconda guerra mondiale, la luce atomica che ha scosso nel profondo persino Oppenheimer – “sono diventato la morte, il distruttore dei mondi”, afferma il fisico di fronte al test nucleare Trinity, il primo della storia. Ma c’è, nel discorso di Bradley, qualcosa che va oltre il pacifismo, e che rende il concetto improponibile, quasi eretico oggi: un’accusa diretta alla scienza come istituzione. Non generico oscurantismo, ma l’avvertimento che la scienza non basta a se stessa – senza una fede, un’etica, una struttura sociale a cui rendere conto, rappresenta un pericolo per l’umanità.
Altri tempi: è impensabile che, oggi, un’autorità nazionale affermi in pubblico che ci sono troppi scienziati. Dei fondi per la ricerca si può dire soltanto che siano insufficienti, anche se chi lo dice è un governante che avrebbe la possibilità, ma non l’intenzione, di intervenire in merito: un pedaggio da pagare al politicamente corretto, insignificante senza un’analisi della spesa pubblica tout court. La sete di tecnocrazia della nostra tarda modernità – tipica, in particolare, di chi ha perso le elezioni – raggiunge, quando si tratta di scienza, vette parossistiche, al punto che solo due categorie sono rimaste a problematizzare la questione: una, quella sempre più marginale dei filosofi raggomitolati fra le rovine della Scuola di Francoforte, fra i brandelli della riflessione novecentesca sulla tecnica e la biopolitica; la seconda, quella carnevalesca dei complottisti, no-vax e abitanti della Terra Piatta. Per tutti gli altri, la brava gente, “i borghesi ciechi di onestà”, la scienza è un mysterium fidei che non si discute fuori dal laboratorio.

Fungo atomico del Trinity test
Ma proprio nel mezzo della grande epidemia, l’evento che segnerà, culturalmente più ancora che biologicamente, le nostre vite, dobbiamo sforzarci di dissacrare la scienza, per salvarla dal delirio di onnipotenza verso cui una popolazione disperata e una politica senza risposte rischiano di spingerla – proprio come i cattolici liberali volevano liberare la Chiesa ultramontanista dalle lusinghe del potere temporale. Partiamo, a titolo d’esempio, dai meschini duelli mediatici fra virologi a cui abbiamo assistito – Burioni contro Gismondo, Burioni contro Tarro – e dal più significativo scontro internazionale fra il premio Nobel Luc Montagnier e buona parte della comunità scientifica. Montagnier sostiene che il virus Sars-CoV-2 sia stato creato artificialmente: un’ipotesi molto debole, fondata com’è su ricerche personali non divulgate e su uno studio pubblicato da un gruppo di ricercatori indiani, poi ritirato. Al di là del fatto che Montagnier abbia ragione o torto, però, la colossale mobilitazione di associazioni scientifiche e stampa generalista contro il medico francese fa emergere un particolare atteggiamento del giornalismo, e della società nel suo complesso, di fronte alla scienza, già stigmatizzato sette anni fa dal paleontologo – nonché editor di Nature – Henry Gee sul Guardian:
I programmi scientifici in televisione adottano una linea fastidiosamente reverenziale. […] Il dibattito e il dissenso non sono soltanto proibiti, ma inconcepibili. […] Noi possiamo solo restare seduti e guardare senza capire. […] Gli scienziati, o quelli che si spacciano per scienziati, rivendicano un’autorità quasi religiosa. E, come chiunque si sia occupato di religione sa, in questo ambito non c’è critica, c’è solo blasfemia.
“Per punirmi del mio disprezzo verso l’autorità” – dice Einstein – “hanno fatto di me un’autorità”: è ironico che la scienza moderna, nata come reazione dal basso alle indubitabili verità delle Scritture, venga adesso sottratta ai dubbi che provengono proprio dal basso. Per capire dove sta l’errore, è necessaria una guida alla buona su come funziona la scienza, quindi il lettore perdonerà un po’ di pedanteria.

Una ricerca sperimentale, su qualsivoglia ipotesi e in qualsiasi disciplina, produce un valore statistico, tradizionalmente indicato con la lettera P; il numero indica, semplicemente, la probabilità che il risultato sia capitato per caso – ad esempio, che una patologia sia regredita da sola e non per merito del farmaco: più ampio è l’esperimento, e più volte viene replicato, più diventa improbabile che si tratti di una coincidenza. Il valore P non potrà mai azzerarsi, dunque sul piano teorico l’intera nostra conoscenza da Galileo ad oggi potrebbe essere sbagliata: è immensamente improbabile, ma basta per rendere assurda la locuzione “verità scientifica”, così tante volte invocata per spegnere il dibattito. Sottigliezze da azzeccagarbugli, direte, e sarebbe così se non avessimo tutte le ragioni per credere che il processo di peer review, alla base delle pubblicazioni scientifiche, si inceppi spesso e volentieri.
Nel 2005, il medico John Ioannidis pubblica uno studio ormai classico, con un titolo dirompente: “Perché la maggior parte delle ricerche pubblicate è falsa”. L’analisi di Ioannidis esplicita un problema di cui tutti gli scienziati sono a conoscenza – e che, invece, i nostri opinionisti-groupie della scienza tendono a non raccontare: la cosiddetta crisi di riproducibilità. Se una percentuale così ampia degli studi in circolazione non è replicabile – dunque si pone al di fuori del metodo scientifico – le ragioni sono sistemiche: soprattutto, il catastrofico paradigma del publish or perish, per cui i ricercatori si mantengono in corsa producendo risultati a nastro, con pessime conseguenze sulla qualità; la scarsa credibilità di molte riviste scientifiche; in alcuni casi truffe belle e buone, scienziati al servizio di interessi economici o politici, com’è stato il caso per l’industria del tabacco.
C’è, però, un altro elemento, più evanescente, del quale il giornalismo e la divulgazione scientifica sono diretti responsabili: la tendenza a confermare acriticamente l’attuale consenso accademico. Montagnier, Wakefield, chiunque proponga idee eterodosse viene – comprensibilmente – incalzato con piglio pressoché inquisitorio, sottoposto al massimo grado del sospetto; se applichiamo una frazione di questo rigore a ricerche meno controverse, però, ci rendiamo conto che fanno ugualmente acqua. Il professore di psicologia, e debunker di professione, Richard Wiseman si è trovato ad affermare, una decina di anni fa, che la ricerca parapsicologica ha raggiunto gli standard qualitativi di tutte le altre aree della scienza ma, visto il potenziale rivoluzionario dell’argomento, i risultati rimangono insufficienti. Una posizione di buon senso, sulla scorta di Carl Sagan – “ipotesi straordinarie richiedono prove straordinarie” – ma che può essere ribaltata in maniera inquietante: davvero studi che hanno la stessa solidità tecnica di quelli sulla telepatia e sull’oroscopo vengono raccontati al pubblico come verità rivelate, solo perché più vicini al mainstream?
Per quanto possa sembrare ridicolo, l’allarme lanciato da Ioannidis suggerisce che le cose stiano proprio così. E le cose stanno così perché, con buona pace del nostro bellicoso Burioni, la scienza non soltanto è democratica, ma condivide con la democrazia la caratteristica peggiore: tende a misurare il valore di un’idea col volume degli applausi, come dice Nicolás Gómez Dávila. La platea è ristretta, ma il meccanismo è identico: lo testimonia una pletora di esempi storici, dall’opposizione universale dell’accademia all’idea di deriva dei continenti proposta da Alfred Wegener, all’editoriale con cui John Maddox, su Nature, dichiarava la teoria del Big Bang filosoficamente inaccettabile perché troppo simile alla creazione biblica. Ed è ovvio che sia così: la scienza progredisce, come rileva Thomas Kuhn, quando il volume di prove accumulate è sufficiente a scacciare dalla trincea la vecchia generazione di scienziati, con i loro preconcetti e le loro carriere fondate su una specifica visione del mondo – “di funerale in funerale”, parafrasando Max Planck. Nel momento in cui giornalisti, divulgatori e scienziati inebriati di prestigio rivendicano per la scienza un’autorità indiscutibile, le stanno negando il suo grande vantaggio gnoseologico: la capacità di percepirsi come provvisoria e autocorreggersi.

Roberto Burioni
Il vero dramma, soprattutto in un paese che scivola sovente nel manicheismo come il nostro, è che il discorso scientifico rivolto al pubblico sia diventato una lotta nel fango a cui partecipano personaggi mediatici completamente digiuni di epistemologia. Valga come emblema il solito Burioni, che va spacciando un rozzo positivismo ottocentesco quando già nel 1975 Paul Feyerabend scrive queste righe:
Senza caos non c’è conoscenza. Senza una frequente rinuncia alla ragione non c’è progresso. […] Dobbiamo dunque concludere che, all’interno della scienza, la ragione non può e non dovrebbe dominare tutto e che spesso dev’essere sconfitta, o eliminata, a favore di altre istanze. Non esiste neppure una regola che rimanga valida in tutte le circostanze e non c’è nulla a cui si possa far sempre appello.
C’è una complessità, nella conoscenza, che si perde puntualmente nella pratica odiosa del blastaggio, in un disprezzo rivolto non solo all’altro come interlocutore, ma all’idea stessa che esista un Altro rispetto alla norma. Così si scade nell’accidioso culto degli esperti, che assolve dal dovere del pensiero e dunque diventa disabilitante, nei termini di Ivan Illich; alla fede cieca corrisponde, dall’altra parte, il rifiuto incancrenito, e il pubblico a cui vengono negati ascolto e dialogo finisce in balia di qualsiasi ciarlatano abiti ai margini della comunità scientifica. Più che dai no-vax, però, oggi è necessario difendere la scienza da se stessa, dalla tendenza a trasformarsi in una congrega di teologi, estranea alla società e insofferente al controllo democratico. Possiamo farlo rivendicando la potenza generatrice dell’errore, che è il grembo di ciò che sapremo domani, senza temere l’eresia del Konstantin Levin di Tolstoj:
il mio peccato principale è il dubbio. Io dubito di tutto e mi trovo sempre nel dubbio.




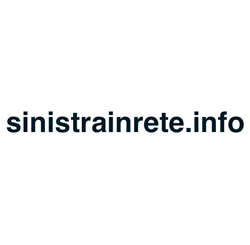


























Commenti recenti