«Robot»: cento anni allo specchio, da Kapec a McEwan
di SCIENZA IN RETE (Cristian Fuschetto)

Compie cento anni la parola «robot», formulata per la prima volta dal drammaturgo ceco Karl Capek. Nel dramma di Kapec il dottor Rossum per fabbricare il robot dovette eliminare l’uomo, oggi i robot ci invitano invece a ripensarlo: l’ingegneria è la continuazione dell’antropologia con altri mezzi.
Immagine: Pixabay License.
«Rossum inventò l’operaio con il minor numero di bisogni. Dovette semplificarlo. Eliminò tutto quello che non serviva direttamente al lavoro. Insomma, eliminò l’uomo e fabbricò il Robot». Nell’intenzione del suo creatore il robot non è altro che il lavoratore perfetto, un operaio senz’anima. Sono passati esattamente 100 anni dalle parole di Karel Capek, giornalista e drammaturgo ceco, autore di R.U.R., Rossumovi Univerzální Roboti, l’opera presentata al pubblico di Praga il 25 gennaio del 1921, in cui compare per la prima volta la parola «robot» (dal ceco «robota», «lavoro forzato»).
Per decenni sono rimasti fedeli all’idea del dottor Rossum, ritiratosi in un’isola per produrre con un misterioso «protoplasma» esseri semiumani da impiegare nei lavori pesanti e liberare l’umanità dalla fatica, per decenni sono rimasti umili operai, solidissime instancabili infallibili ma pur sempre mere braccia per l’industria pesante, poi qualcosa è cambiato. Equipaggiati di software, sensori e potenza di calcolo senza precedenti, i robot sono passati dalla fabbrica al più leggero mondo dei servizi, li abbiamo utilizzati come receptionist, badanti e terapeuti. Paro, per esempio, è un cucciolo di foca artificiale utilizzato con successo per assistenza psicologica nella pet therapy, dotato di sensori sottocutanei reagisce in modo appropriato quando viene accarezzato, risponde se chiamato, può produrre comportamenti emergenti potenzialmente infiniti, riuscendo a innescare una relazione di empatia anche individuale con gli umani che entrano in contatto con lui. Così come Kaspar, che a differenza di Paro ha sembianze antropomorfe (ma non troppo per non generare inquietudine) e che da anni viene utilizzato con successo come «facilitatore» delle interazioni tra bimbi autistici e i loro interlocutori (genitori, insegnanti, terapisti).
Questi robot interagiscono, comprendono esigenze e soddisfano bisogni, intercettano stati d’animo e possono generane di nuovi nei loro interlocutori. Da forza bruta per l’industria, i robot sono diventati compagni. In gergo li chiamano «Cobot», robot cooperativi progettati per interagire con l’uomo non più solo nelle fabbriche ma anche nelle case. «I robot diventeranno presto domestici» spiega Bruno Siciliano evocando quello che un tempo diceva Bill Gates a proposito dei computer. «Nel futuro – disse il fondatore di Microsoft – vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa». Era il 1975 e pochissimi lo presero sul serio. «E invece avrebbero dovuto, così come adesso dobbiamo guardare molto seriamente alla robotizzazione della società», continua Siciliano, Ordinario di Controlli e Robotica all’Università di Napoli Federico II, past President della Ieee Robotics & Automation Society, la società internazionale di Robotica nonché autore insieme a Oussama Khatib, docente della Stanford University, dello Springer Handbook of Robotics, bibbia del settore su cui continuano a formarsi generazioni di ingegneri in tutto il mondo. «La scommessa sarà vinta quando anche i robot più complessi saranno interamente plug&play». Questo è un settore in cui si sta lavorando moltissimo, Google per esempio ha aperto una divisione a Monaco di Baviera dedicata allo sviluppo di questo tipo di macchine. E lo stesso sta facendo anche Amazon. Il fatto che colossi del genere investano sulla robotica è lo specchio del fatto che la pervasività dei robot è vicina. «Così come oggi si spendono 1000 euro per un telefonino, presto si spenderanno 1000 euro per un robot. Se qualcosa dotato di autonomia crescente si inserisce nei nostri spazi di lavoro, di divertimento, negli ambiti domestici, in quelli sanitari e assistenziali, quel qualcosa cambia il nostro di concepire l’interazione tra noi e il mondo, cambia il nostro modo di vivere» conclude lo scienziato, che alla voce «Robotica» curata per la Treccani la descrive come la «connessione intelligente tra percezione e azione».
Non più solo schiavi ma compagni, non più solo oggetti ma attori in intelligente interazione con il mondo e gli umani, viene il dubbio che ogni volta che parliamo di robot si parli inevitabilmente anche di noi stessi. In «Macchine come me», Ian McEwan immagina l’esordio della prima generazione di robot neoumani. Ambientata in un passato shakerato con assaggi di futuro, una «retrotopia», lo scrittore racconta la storia di un giovane londinese, Charlie Friend, che nei primi anni ’80 spende l’intera fortuna lasciatagli in eredità dalla madre per comprare uno dei primi 25 androidi messi in commercio, 13 Eve e 12 Adam. Sono l’avanguardia dell’intelligenza artificiale, lo zenith di una ricerca che grazie agli sviluppi della computer science guidata da un Alan Turing ancora in vita, è riuscita a porre le basi per la fabbricazione di macchine intelligenti, sensibili e imprescrutabilmente coscienti. Adam compone haiku, si appassiona di Shakespeare e Montaigne, diventa persino rivale in amore di Charlie. «Mentre lo guardavo negli occhi – si chiede Charlie – cominciai a sentirmi scombussolato, insicuro. Nonostante il netto spartiacque tra esseri viventi e inanimati, restava innegabile che io e Adam eravamo vincolati alle stesse leggi fisiche. Chissà, forse la biologia non mi garantiva nessuno status speciale, forse significava ben poco ripetersi che la figura in piedi davanti a me non era viva a tutti gli effetti». Stranito e circondato da una città in conflitto, stretta tra piazze impaurite dalla robotizzazione del lavoro e nascenti leader desiderosi di governarla, Charlie riesce a incontrare Turing nel suo laboratorio di King’s Cross. «Centinaia di eccellenti studiosi – gli ricorda Turing – si unirono a noi per sostenere lo sviluppo di una forma di intelligenza artificiale generale in grado di evolvere in un sistema aperto». Aperto come lo è il linguaggio e come può esserlo quel caos di incertezze ed equivoci che è la vita. «È questo che fa funzionare il suo Adam», spiega Turing. Ma a proiettare lo sguardo sulle conseguenze della convivenza tra umani e robot è lo stesso Adam. «Le conseguenze delle macchine intelligenti sono di tale immensa portata che non possiamo prevedere che cosa voi abbiate inaugurato. Una delle apprensioni è che si riveli uno shock e un affronto vivere in compagnia di soggetti più intelligenti di voi stessi».
Al di là dei problemi di autostima per una specie che da Copernico, Darwin e Freud è alla ricerca consapevolmente disperata di un centro di gravità permanente, è utile notare che le macchine intelligenti già interrogano lo status della nostra soggettività. Il robot è lo specchio dell’uomo, una strada che conduce a noi stessi proprio perché incarna la figura dell’Altro, come accade per l’Animale. In «Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale», Paul Dumouchel e Luisa Damiano ci offrono uno spunto molto utile in tal senso mettendo in evidenza come la domanda che alla fin fine tutti noi ci facciamo quando vediamo macchine che fanno cose molto umane finiamo per chiederci se siano o no come noi. Dumouchel e Damiano dicono che, messo così, l’interrogativo non ha senso. Al cospetto della varietà di artefatti che pian piano stanno entrando nelle nostre vite, i due ricercatori ci invitano a ripensare il rapporto tra sistemi cognitivi naturali e artificiali, tra la nostra mente e quelle di oggetti che pur non essendo come noi non esistiamo a definire smart. Prima di inquietarci per la mente degli Altri è il caso di capire cosa sia la nostra, di mente. Dopo decenni di dominio indiscusso di rigido funzionalismo cognitivo, l’idea per cui la mente è assimilabile a un software libero di girare su un qualsivoglia supporto materiale, oggi prevale il cosiddetto embodiment, l’idea per cu la mente è inseparabile dal corpo da cui emerge.
«Ogni atto di conoscenza ci porta un mondo fra le mani» scrivevano Maturana e Varela. Se è vero che non pensiamo solo con la nostra testa, che la mente è incarnata in un corpo legato a sua volta a un ambiente, se è vero che la mente è tutt’altro che un fenomeno esclusivamente interno, una specie di elaboratore incastrato nel cranio, ma un fenomeno emergente da una rete complessa in cui il dentro e il fuori (neuroni, organismo, ambiente) sono intrecciati, allora viene meno l’idea di una mente pura e di una cognizione disincarnata. Si squarcia lo scenario dell’esclusività del pensiero e si apre l’orizzonte del «pluralismo cognitivo». «Riconoscere l’eterogeneità del dominio cognitivo esige di non negare la differenza [tra noi e le macchine] e al tempo stesso di non trasformare in abisso ontologico la distinzione tra mente umana, intelligenza degli animali o delle macchine. È sufficiente rinunciare alla dicotomia in favore del pluralismo», scrivono i due ricercatori.
Al pari della crescita di una pianta o di un animale, la mente non è una cosa, ma una dinamica. È una serie di eventi che ha luogo nel mondo. La mente è una relazione tra sistemi cognitivi. Tra questi sistemi ci siamo noi, ci sono gli animali e cominciano a esserci in modo sempre più diffuso anche i robot. Più che operai senz’anima, pare allora utile cominciare a considerarli come altrettante domande sull’anima. Siamo nel bel mezzo di quello che Bruno Latour preannunciava più di 40 anni fa come l’epoca della distribuzione della soggettività. Nel dramma di Kapec il dottor Rossum per fabbricare il robot dovette eliminare l’uomo, oggi i robot ci invitano a ripensarlo. L’ingegneria è la continuazione dell’antropologia con altri mezzi.
Fonte: https://www.scienzainrete.it/articolo/«robot»-cento-anni-allo-specchio-da-kapec-mcewan/cristian-fuschetto/2021-01-25



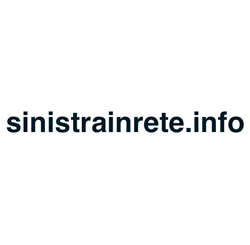




























Commenti recenti