I dannati del clic. Lavoro digitale e nuove forme di sfruttamento
di SINISTRAINRETE (Carlo Formenti)
 Il ruolo delle tecnologie digitali nella progettazione di nuove forme di sfruttamento delle classi lavoratrici, è al centro di un incontro organizzato dalla CGIL per martedì 2 febbraio https://www.centroriformastato.it/non-solo-rider-le-antiche-nuove-forme-di-sfruttamento-di-chi-lavora-per-e-con-le-piattaforme-digitali-5/. Negli ultimi anni, il tema è stato affrontato da diverse ricerche: dal libro di Riccardo Staglianò, Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri (Einaudi 2018) al più recente Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo (Feltrinelli 2020), di Antonio Casilli, il quale parteciperà all’incontro di cui sopra. Quel “tutti” che accomuna i due sottotitoli (“ci rende tutti più poveri”, “perché lavoriamo tutti”), sembra suggerire che gli autori credano di riconoscere, in queste nuove forme di sfruttamento, un tratto generalizzabile, universale dell’attuale fase di sviluppo capitalistico. Nel testo che segue mi propongo di problematizzare questa tesi. Ma prima è opportuno sintetizzare il contributo dei due libri alla comprensione di una serie di fenomeni che stanno mettendo in discussione alcuni concetti di base della sociologia del lavoro, dalla relazione fra tecnologia e occupazione all’idea stessa di lavoro.
Il ruolo delle tecnologie digitali nella progettazione di nuove forme di sfruttamento delle classi lavoratrici, è al centro di un incontro organizzato dalla CGIL per martedì 2 febbraio https://www.centroriformastato.it/non-solo-rider-le-antiche-nuove-forme-di-sfruttamento-di-chi-lavora-per-e-con-le-piattaforme-digitali-5/. Negli ultimi anni, il tema è stato affrontato da diverse ricerche: dal libro di Riccardo Staglianò, Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri (Einaudi 2018) al più recente Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo (Feltrinelli 2020), di Antonio Casilli, il quale parteciperà all’incontro di cui sopra. Quel “tutti” che accomuna i due sottotitoli (“ci rende tutti più poveri”, “perché lavoriamo tutti”), sembra suggerire che gli autori credano di riconoscere, in queste nuove forme di sfruttamento, un tratto generalizzabile, universale dell’attuale fase di sviluppo capitalistico. Nel testo che segue mi propongo di problematizzare questa tesi. Ma prima è opportuno sintetizzare il contributo dei due libri alla comprensione di una serie di fenomeni che stanno mettendo in discussione alcuni concetti di base della sociologia del lavoro, dalla relazione fra tecnologia e occupazione all’idea stessa di lavoro.
Sulla questione della disoccupazione tecnologica Staglianò (cfr. la recensione che Alessandro Visalli gli ha dedicato http://tempofertile.blogspot.com/2018/10/riccardo-stagliano-lavoretti.html?q=gig+economy) resta nel solco della tradizione marxista: l’odierna tecnologia “ruba” il lavoro, come ha fatto fin dalla prima rivoluzione industriale, e lo fa non tanto e non solo per ragioni “oggettive” – cioè come effetto collaterale di un inevitabile quanto irreversibile “progresso” tecnico-scientifico – ma anche e soprattutto perché è lo strumento principale grazie al quale il capitale contiene il costo del lavoro quando questo accumula rapporti di forza tali da sfidare il profitto.
La tecnologia serve cioè a creare un “esercito di riserva”. Uber è citato come esempio paradigmatico di tale logica: il colosso che ha “liberalizzato” il servizio dei taxi, distruggendo un settore caratterizzato da un elevato tasso di regolazione del lavoro (paragonabile a quello di certe corporazioni medievali) ha creato un mercato della forza lavoro in cui, a fronte di un milione e mezzo di autisti nominalmente autonomi, troviamo solo 12.000 dipendenti diretti.
La posizione di Casilli è più eretica, nel senso che questo autore contesta la retorica della “fine del lavoro” generata dal processo di sostituzione tecnologica, in base alla quale basterebbe rimpiazzare alcune mansioni perché scompaiono interi mestieri. Per valutare realisticamente l’impatto delle intelligenze artificiali, scrive, occorrerebbe prendere seriamente in considerazione gli indicatori economici e statistici (giusto, ma visto che ciò non viene fatto nemmeno nel suo lavoro, permane il rischio che certe valutazioni siano basate sul partito preso, più che sull’analisi empirica; per esempio: dopo essersi chiesto quante siano nel mondo “le piccole api onerose della IA”, Casilli risponde: “non si sa, sicuramente milioni”. Quanti? Uno, dieci, cento, di più?). Ma il suo argomento forte è il seguente: “anche gli impieghi a più alto rischio di automazione contengono spesso una quantità di mansioni che non possono essere automatizzate”. L’automazione totale è e resterà un mito perché, per il capitale (e qui il suo punto di vista converge con quello di Staglianò), l’automazione è innanzi tutto uno strumento per disciplinare il lavoro, ed è per questo motivo che quella piena e definitiva viene costantemente rinviata a un futuro imprecisato.
Sia Staglianò che Casilli concentrano poi l’attenzione sulla massa di lavoro sottopagato, altamente usurante, che viene compiuto “dietro le quinte” di un processo produttivo che utenti e consumatori immaginano interamente automatizzato. La verità è invece che gran parte del lavoro non viene effettuato da software e Bot dotati di mirabolanti quote di “intelligenza artificiale”, bensì da normali intelligenze umane. Né le intelligenze artificiali coinvolte nel processo hanno alcunché da spartire con le mitiche intelligenze artificiali “forti”, di cui personaggi come Kurzweil predicano l’imminente avvento: si tratta piuttosto di intelligenze artificiali “deboli”, composte da applicazioni che aiutano a gestire l’informazione, ottimizzare contenuti, prendere decisioni e che non sarebbero in grado di funzionare senza il supporto del lavoro umano.
Veniamo ora alla descrizione di questo cosiddetto “capitalismo delle piattaforme”, e agli argomenti con cui si sostiene che la controparte di questa nuova incarnazione del rapporto di capitale non è un insieme eterogeneo di figure sociali bensì una inedita e ben precisa tipologia di forza lavoro, accomunata da molte caratteristiche se non del tutto omogenea, che Casilli definisce digital labor. Il punto da cui partire è il fatto che le piattaforme non operano come le industrie che sostituiscono e distruggono, non comprano cioè forza lavoro né mezzi di produzione, bensì erogano un servizio, di cui formalmente non dispongono, agendo come se potessero disporne, per cui accettano prenotazioni di determinati prodotti e servizi che poi “mettono all’asta” su Internet. Attraverso la messa in contatto e la generalizzazione del modello dell’asta viene “estratto” (tornerò più avanti su questo termine) tutto il valore che in precedenza veniva catturato dallo strato intermedio di quei saperi esperti e di quelle pratiche organizzate che hanno guidato la differenziazione progressiva della modernità a partire dal milleseicento ad oggi (questa la definizione di Staglianò). Ma vediamo come si articola questo modello.
Uno. Piattaforme on demand. L’abbinamento fra clienti e lavoratori si opera attraverso la app ma le prestazioni sono dal vivo. Il caso di scuola è Uber: questa azienda è un network digitale in cui si incontrano passeggeri e conducenti nei confronti dei quali Uber agisce da intermediario. Tuttavia la percentuale che trattiene sulle prestazioni degli autisti come compenso per tale funzione non è il core business, il quale si annida piuttosto nel meccanismo reputazionale fondato sui punteggi che conducenti e passeggeri si attribuiscono reciprocamente. L’algoritmo di Uber opera come strumento per incentivare gli uni e gli altri a svolgere quel lavoro di produzione d’informazione che è la vera base del business (per inciso, Casilli riprende qui il discorso contro il mito dell’automazione: le “macchine senza conducente”, di cui si favoleggia per un prossimo futuro, saranno in realtà veicoli in cui toccherà al passeggero svolgere il ruolo del “vero” conducente, nella misura in cui dovrà risolvere tutti i problemi che il veicolo non sarà in grado di gestire autonomamente).
Due. Microlavoro, ovvero human based computation. Si tratta di pratiche che consistono nel delegare agli esseri umani operazioni che le macchine non sono in grado di eseguire da sole . Il caso di scuola qui è la piattaforma Mechanical Turk di Amazon che “appalta” queste operazioni a una miriade di persone sparse in tutto il mondo (riferendosi a queste moltitudini – ovviamente non solo a quelle gestite da Amazon – Casilli sostiene che si tratterebbe di almeno quaranta, ma forse addirittura centinaia di milioni di lavoratori, giustificando questa approssimazione – che fa il paio con quel “sicuramente milioni” di cui sopra – con la difficoltà di reperire dati attendibili). Amazon sfuma il suo ruolo di intermediario presentandosi come un “ecosistema” dove clienti e lavoratori entrano in contatto in maniera per così dire spontanea. Casilli sottolinea inoltre che le interfacce delle app sono ludiche, per evitare che gli utenti abbiano l’impressione di svolgere missioni impegnative o faticose, e aggiunge che simili meccanismi ludici assumono sovente forma agonistica per stimolare la produttività.
Tre. Lavoro sociale in rete. Il caso di scuola è in questo caso Facebook. Si potrebbe dire che questo modello rappresenta una evoluzione avanzata del marxiano “lavoro del consumatore”: la partecipazione degli utenti dei social come Facebook (costruzione di comunità, creazione, produzione e condivisione di contenuti, generazione massiva di big data traducibili in profilazioni di mercato, comunicazione pubblicitaria, ecc.) consiste in una serie di mansioni assimilate al tempo libero, alla creatività e alla socialità. Ma la logica del capitalismo delle piattaforme digitali, argomenta Casilli, fa sì che il contributo del consumatore-utente non sia più solo complementare rispetto al lavoro formale, ma si trasformi nella pietra angolare di un intero edificio produttivo. A chi obietta che se si svolgono attività in ci si diverte non le si possono definire lavoro (1), Casilli replica che gli utenti dei social si trovano sullo stesso piano degli “operai del clic” (quelli delle piattaforme on demand e del microlavoro) nella misura in cui, al pari di loro, contribuiscono alla costruzione dei sistemi intelligenti, sono cioè integrati in un processo nel quale non sono le macchine a fare il lavoro degli esseri umani, bensì sono gli esseri umani che vengono indotti a svolgere il “digital labor” per conto della macchine, accompagnandole, imitandole, addestrandole.
È sufficiente il fatto di svolgere un’attività spezzettata e “datificata” che serve ad addestrare i sistemi automatici, per inquadrare in una categoria unitaria un coacervo di esperienze in cui si mescolano lavoro atipico, lavoro indipendente, lavoro a cottimo microremunerato, hobby professionalizzati, passatempi monetizzati, un continuum, scrive Casilli, fatto di attività non remunerate, attività sottopagate e attività remunerate in modo flessibile? L’operazione a me pare azzardata, nella misura in cui è fondata su un’astrazione logica che difficilmente può essere identificata con il concetto marxiano di “astrazione concreta”. Ma se Casilli se la può permettere è perché il suo approccio si colloca esplicitamente nella cornice della cosiddetta italian theory (fuor di lessico accademico: delle teorie post operaiste). Il che significa che tutti i “buchi” e le contraddizioni del suo discorso possono essere sanati ricorrendo al concetto di tendenza.
Prima di discutere l’infondatezza di tale concetto, ritengo tuttavia doveroso riconoscere che Casilli, pur ispirandosi al paradigma post operaista, ne critica alcuni aspetti indifendibili. A partire dall’idiozia del cosiddetto “lavoro immateriale”, che ci è stata propinata in tutte le salse negli ultimi decenni: il digital labor, scrive Casilli, non è più immateriale del lavoro di un avvocato o di un operaio, nel senso che questi lavoratori si confrontano con questioni concrete e con mansioni che richiedono la partecipazione del corpo, dei sensi, delle dita (qui il digitale va inteso nel senso letterale delle dita che manovrano il mouse). Del resto, aggiunge, senza riferirsi alla dimensione materiale che si cela dietro un’economia che si spaccia per “immateriale”, diventa impossibile cogliere la dimensione dello sfruttamento (2) ad essa strettamente associata (giustamente Casilli estende la critica alle profezie postoperaiste che, mistificando la categoria marxiana del general intellect, si sono associate “da sinistra” alle profezie degli imbonitori tecnoentusiasti della “fine del lavoro”).
Ma torniamo al concetto di tendenza, che ha avuto la sua prima formulazione nelle teorie del primo operaismo (quello dei “Quaderni Rossi” per intenderci) il quale accusava i marxisti dogmatici di essere ancorati a una visione anacronistica del processo produttivo (e di conseguenza alla valorizzazione politica di una composizione di classe basata sull’operaio professionale). La transizione al modo di produzione fordista configurava una composizione di classe inedita, in cui il potenziale antagonista transitava dall’operaio professionale all’operaio massa, cioè agli addetti alle mansioni ripetitive e dequalificate della catena di montaggio. Esauritosi il ciclo fordista il paradigma si è perpetuato proponendo una lunga serie di poli oppositivi: economia postfordista/operaio sociale (poi moltitudine); economia della conoscenza/knowledge workers, ecc. Questi slittamenti progressivi seguono appunto il filo rosso della tendenza, intesa come la forma “più avanzata” che la contraddizione fra capitale e lavoro viene via via assumendo. La tendenza è concepita come un processo monodirezionale e irreversibile, mosso da una necessità immanente che è quasi esclusivamente identificata con l’evoluzione delle tecnologie produttive, non solo macchine ma anche modelli organizzativi – evoluzione che è a sua volta il prodotto della lotta fra forza lavoro e capitale.
Questo schema non prevede eccezioni né contro tendenze, così come ne restano escluse o quasi le variabili politiche, culturali e sociali in senso più ampio (antropologiche). L’idea di fondo è che la tendenza agisca come un fattore soverchiante che sovradetermina tutti gli altri. Ecco perché Casilli può giocare con i numeri attribuendo importanza relativa al fatto se i suoi operai del clic rappresentino una quota più o meno ampia della forza lavoro totale: è sufficiente, per esempio, estendere la filiera agli operai della Foxconn (oggetto di un selvaggio sfruttamento neofordista) per considerali parte integrante del modello. In poche parole: il conflitto fra capitalismo delle piattaforme (considerato la punta più avanzata dello sviluppo capitalistico anche se i dati ci dicono che il peso economico reale di questa industria è assai più limitato di quanto non lasci intendere il suo prestigio virtuale) e digital labor (anche se la percentuale di questi lavoratori sul totale della forza lavoro è relativamente bassa) diventa la tendenza principale in grado di sovradeterminare l’insieme degli altri conflitti economici, politici e sociali (3).
In questo modo Casilli – al pari di tutti quelli che adottano un punto di vista analogo – non è più in grado di relativizzare il suo contributo, inquadrandolo in un contesto analitico più ampio. Non avendo intenzione di allargare troppo il discorso, mi limito a fare qui di seguito alcuni esempi di ciò che intendo: 1) tende a sposare la tesi di Manuel Castells, secondo cui la logica dei flussi sarebbe inevitabilmente destinata a prevalere sulla logica dei luoghi, e questo proprio nel momento storico che vede una crisi radicale della globalizzazione e un prepotente ritorno del conflitto interimperialistico fra grandi Stati; 2) il fatto che la maggioranza degli operai del clic siano disperati che sgobbano per pochi centesimi a operazione in Asia e Africa, lo induce ad ammettere che la geografia globale è oggi persino più ineguale che nella seconda metà del Novecento ma, al tempo stesso, la necessità di descrivere un mondo omologato sotto un unico paradigma (4), fa sì che neghi l’evidenza della natura neocoloniale del rapporto fra Nord e Sud del mondo (ampiamente dimostrata da autori come Samir Amin); 3) gli sfugge il fatto che quello che chiama capitalismo delle piattaforme non è altro che un epifenomeno del più ampio processo di finanziarizzazione dell’economia, cui queste tecnologie certamente contribuiscono, ma rispetto al quale rappresentano un effetto collaterale; 4) incontra serie difficoltà a conciliare il fatto che i lavoratori del clic faticano a concepirsi come lavoratori con la loro collocazione in una posizione “oggettivamente” avanzata nel contesto delle contraddizioni sistemiche (5).
Mi tocca infine fare – come anticipato in precedenza – un breve inciso sul concetto di “estrazione” di valore. Le analisi di Marx ed Engels sul processo di accumulazione primitiva; la teoria leninista dell’imperialismo; quelle di Baran e Sweezy sul capitale monopolistico; quelle della “banda dei quattro” (Wallerstein, Arrighi, Samir Amin e Gunder Frank) sullo sviluppo del sottosviluppo, per tacere del concetto di accumulazione per espropriazione di David Harvey, sono tutti contributi che dimostrano come l’estrazione di valore sia un elemento consustanziale alla storia del capitalismo, alla cui comprensione il fenomeno del cosiddetto capitalismo delle piattaforme aggiunge relativamente poco, se non per il fatto che rappresenta una delle tattiche dilatorie – quelle che Wolfgang Streeck riunisce sotto lo slogan “guadagnare tempo” – (6) del capitalismo finanziarizzato per far fronte alla caduta del saggio di profitto.
Concludo con un breve accenno alla pars costruens dei libri di Staglianò e Casilli. Staglianò, che come sopra ricordato resta ancorato allo scenario della disoccupazione tecnologica, ripropone il rimedio del reddito di base, rispetto al quale mi limito qui a riproporre le perplessità che Alessandro Visalli avanza nella recensione citata in apertura: <<E’ vero che il capitalismo (…) non riesce a garantire un adeguato reddito da lavoro a tutti, e quindi dissemina scarti e “inutili”. Ma il solo reddito garantito, in particolare quando soggetto a pensati condizionalità, rischia di portare con sé una ineliminabile dimensione disciplinare>>. Viceversa Casilli ha il merito di mettere in luce l’oggettiva difficoltà di costruire una cornice politico-sindacale unitaria in cui far confluire gli interessi di questi soggetti, oltre a dimostrare l’insensatezza di alcune delle soluzioni proposte. In particolare, critica l’idea secondo cui, dal momento che siamo di fronte a un tipo di potere che si basa su una sottomissione convenzionale, quest’ultima si ridurrebbe a una sorta di “superstizione” destinata a svanire nel momento in cui si cessa di credervi. Non so se si riferisca qui a certe idiozie post operaiste, ma è certo che la critica vi si adatta alla perfezione: avete presente la tesi secondo cui i knowledge workers, dato che sono ormai in grado di gestire autonomamente un processo produttivo compiutamente socializzato, basta “si sveglino” dall’illusione della necessità del comando capitalistico per rendere possibile la transizione diretta al comunismo? In realtà, scrive Casilli, la produzione di informazione non si basa su incentivi alla “sottomissione volontaria” bensì sull’induzione di “una scelta volontaria obbligatoria”: si adottano comportamenti che producono informazioni come se questa fosse una nostra scelta.
Su altre utopie, come ripensare il rapporto fra utente lavoratore e infrastrutture di raccolta e trattamento dati inquadrandolo nella logica dei beni comuni, sviluppare nuove modalità di condivisione delle risorse, dare vita a un cooperativismo delle piattaforme in grado di <<usare la piattaformizzazione contro se stessa>>(!?) Casilli non si pronuncia con altrettanta chiarezza critica. Personalmente resto dell’idea che non esistano alternative a un faticoso sforzo di sindacalizzazione di questi soggetti che, dato il loro alto livello di stratificazione e dispersione, dovrebbe assumere – come ho argomentato nel post precedente, dedicato alla nascita della sezione italiana della Tech Workers Coalition, la forma di una sorta di sindacalismo sociale capace di aggregare trasversalmente figure diverse.
NOTE
(1) La stessa obiezione che mi fu rivolta dopo la pubblicazione di Felici e sfruttati (Egea 2011), libro in cui definivo lavoro gratuito l’attività degli utenti dei social.
(2) Un altro aspetto che consente di parlare di sfruttamento in relazione a questo tipo di attività è l’esistenza di pratiche che già anni fa (cfr. nota precedente) definivo “taylorismo digitale”, riferendomi all’uso delle informazioni raccolte attraverso i vari tipi di piattaforme per ottimizzare non solo il tempo di lavoro ma anche il tempo di vita degli utenti. Casilli approfondisce il concetto scrivendo che, mentre gli operai del taylorismo classico subivano la macchina come mezzo di produzione, gli operai del clic costituiscono essi stessi gli ingranaggi della macchina che mira a sostituirli (ingranaggi che possono a loro volta sfruttare le condizioni generate da decenni di esternalizzazione e parcellizzazione del lavoro).
(3) Non si tratta di negare che le pratiche di sfruttamento sperimentate in questo settore possano essere “esportate” in altri settori di maggior peso strategico. Ma ciò non implica che il capitalismo delle piattaforme rappresenti ormai il capitalismo tout court.
(4) In un post precedente ho parlato di “terrapiattismo”, a proposito della tendenza a cancellare le differenze radicali fra sistemi. Casilli, per esempio, sembra dare per scontato che la Cina non faccia eccezione rispetto alla “tendenza” globale (in merito cita il funzionamento delle grandi piattaforme digitali “made in China”), per cui gli sfugge come il conflitto fra Stati Uniti e Cina incarni il persistere di quella dialettica fra potere dei flussi e potere dei luoghi che lui ritiene ormai risolto a favore del primo. Ma le cose, come dimostra la liquidazione del boss del commercio online Jack Ma, il quale usava la sua impresa come cavallo di Troia delle logiche di finanziarizzazione, sono assai più complicate.
(5) Mi pare di poter aggiungere che nel libro di Casilli manca un’analisi convincente della stratificazione interna di questa forza lavoro: quali strati – e in base a quali criteri – possono essere definiti come proletari digitali e quali come alleati del capitale?
(6) Cfr. W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Feltrinelli, Milano 2013.
FONTE: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/19662-carlo-formenti-i-dannati-del-clic.html



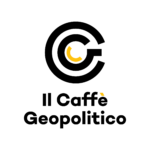




























Commenti recenti