L’aggressione ai diritti dei lavoratori e la questione sindacale un confronto Italia-Francia
da MARX XXI
(ottobre.info)
Dopo il crollo del campo socialista e la fine della guerra fredda che aveva, in una pur minima misura, tenuto a bada gli appetiti più voraci dei capitalisti nei confronti dei diritti lavoratori, dall’inizio degli anni ’90 in poi è ricominciato a spron battutto l’attacco sistematico alle condizioni di vita della classe lavoratrice. Da quel torno di tempo in avanti misure di compressione salariale, privatizzazioni, sconti alle imprese, delocalizzazioni e precarizzazione del mercato del lavoro costituirono le armi principali con le quali la borghesia italiana tentò di frenare la caduta dei profitti. Sarebbe superfluo elencare le menzogne manifeste e smentire le banalità con le quali la classe dominante ha tentato di imbellettare e giustificare tutti questi processi (dalla ricerca della produttività perduta, ai fantastici vantaggi dell’ultra flessibilità lavorativa), pertanto ci focalizzeremo su uno degli aspetti più gravi dell’aggressione generale a danno dei lavoratori compiuta negli ultimi decenni: l’istituzione crescente di forme di lavoro precario. In aggiunta proveremo a delineare alcuni temi importanti come la questione sindacale confrontondo la situazione del nostro paese con le esperienze di paesi vicini come la Francia.
Le legislazioni sul precariato in Italia e i loro numeri
Per quanto il precariato in certi settori sia stato una costante nella storia del nostro paese, con la fine della seconda guerra mondiale e soprattutto con la stagione del cosiddetto boom economico e delle lotte operaie, le condizioni dei lavoratori conobbero un effettivo miglioramento in termini di diritti e stabilità culminato con la conquista dello Statuto dei Lavoratori e altre garanzie di ordine sociale e civile. Tolti i primi attacchi che già dal ‘92, anche in ossequio a Maastricht, i governi italiani intraprendevano contro le masse popolari, con i blocchi delle indicizzazioni dei salari e delle pensioni, i primi interventi significativi innesco dell’esplosione del precariato furono attuati con la L. 196/1997 meglio conosciuta come “Pacchetto Treu”. Con questa vera e propria controriforma vennero introdotte nuove modalità di lavoro part-time, l’apprendistato (un contratto dai 18 mesi ai 4 anni per gli under 26), i cosiddetti stage di massimo un anno, tirocini, e soprattutto il lavoro interinale, vale a dire un’esternalizzazione del lavoro che avrebbe consentito ad un’azienda (agenzia interinale o cooperative), “fornitrice di manodopera”, di appaltare in maniera ultra-flessibile la forza lavoro dei propri “addetti” a terzi. Così facendo, per la gran parte, venne sottratto allo Stato il regime di sistema di collocamento pubblico appaltandolo ai privati.
L’ulteriore spinta propulsiva alla precarizzazione del lavoro venne introdotta con la Legge Biagi del 2003, la quale frammentò ulteriormente il mosaico del mercato del lavoro introducendo tutta una serie di tipologie contrattuali. Fra queste troviamo il contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro), una tipologia di lavoro sciolta da qualsivoglia vincolo di contrattazione, che non sia la durata del “progetto”, e che lascia il lavoratore alla quasi totale mercé del padrone, naturalmente privo di tutti i diritti e garanzie tipiche di un qualsiasi altro lavoro dipendente (tredicesima, TFR, etc.). Altre forme introdotte furono: il contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, forma particolarmente odiosa e parzialmente mitigata da successive “riforme”; il contratto di lavoro accessorio, come per esempio per gli stagionali; e la somministrazione del lavoro, che andava a sostituire il lavoro interinale senza sostanzialmente cambiarne di molto l’impostazione, quella fondamentalmente, di un vero e proprio caporalato legalizzato. I risultati di questa virata all’indietro della ruota della storia da parte degli apprendisti stregoni della borghesia non tardarono ad arrivare. La riduzione del potere contrattuale dei lavoratori, ricattabili e pronti ad accettare condizioni peggiori e salari più bassi, non incise soltanto sui contratti a tempo determinato e in generale sui precari, ma anche su tutti quei lavori stabili, e maggiormente qualificati, che videro un decremento salariale, a parità di condizioni, con chi era entrato nella stessa posizione prima del periodo delle controriforme[1].
In un rapporto presentato nel 2016 al Senato dall’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, che analizzava dei dati sull’impatto delle riforme del mercato del lavoro dal 2000 al 2015, viene riportato che in questo lasso di tempo in diversi paesi europei, fra i quali l’Italia, la crescita del lavoro precario ha investito una percentuale sempre maggiore di lavoratori, attestandosi in media attorno al 10% e talvolta anche di più. Inoltre, nel nostro paese la diffusione del lavoro precario è generalmente più diffuso fra le donne, colpendo il 30% delle lavoratrici, contro il 10% degli uomini: tra il 2000 e il 2015 le lavoratrici precarie sono aumentate del 50%, così come quelle costrette, per scelta o per forza, al part-time sono addirittura aumentate del 69%. Viene poi constatato, come ovvio che sia, che i giovani under 30 siano la fetta di lavoratori dove il precariato si è diffuso maggiormente[2]. Nel 2015, sul totale dei contratti stipulati che coinvolgevano 6 milioni di lavoratori (a fronte di cessazioni per 5,7 milioni), ben il 65,5% erano precari, una cifra che si dimostrava in linea con gli anni precedenti[3].
In questo contesto, con la scusa di “abolire il precariato” e la retorica del togliere il “privelgio ai garantiti” (cioè i lavoratori stabili), l’ultimo ritrovato della borghesia fu quello del Jobs Act. Quest’ultimo, contemplando l’abolizione dei diritti per i lavoratori a tempo indeterminato e favorendo la possibilità di licenziamento per le aziende (abolizione art. 18 dello Statuto dei lavoratori), provava, col gioco delle tre carte delle “tutele crescenti”, a manipolare la statistica per poter continuare ad aggredire la classe lavoratrice imponendo un precariato mascherato. Inoltre, sempre la riforma renziana, andava ad aggravare un’altra forma di precariato odiosa: quella dell’impiego dei voucher (o buono lavoro). Questa forma contrattuale pensata ad inizio anni ’00 per gli stagionali e i lavoratori di alcuni settori (es. agricoltura) venne, da Monti in poi, sdoganato per moltissimi altri tipi di lavori, e col governo Renzi ulteriormente favorito: si è passati dai 15 milioni di voucher utilizzati nel 2011 ai 115 del 2015 e i 145 (massimo storico) del 2016, e interessando, per esempio nel 2015, quasi un milione e mezzo di lavoratori[4]. I voucher, per dovere di cronaca, sono stati aboliti nel 2017 dal governo Gentiloni per evitare un referendum portato avanti dalla CGIL, a dimostrazione che pure dei timidi contrasti da parte degli ultra proni sindacati confederali possono portare qualche risultato, piccolo, sì, ma importante.
Dopo l’ingloriosa fine del governo Renzi e l’avvicendamento del cosiddetto governo gialloverde (Lega e Movimento 5 Stelle), la precarizzazione ha visto una lievissima controtendenza rispetto all’iter controriformista. Il cosiddetto “Decreto dignità” ha posto una serie di misure volte a frenare la tendenza preoccupante alla precarizzazione del lavoro, come ad esempio abbassare le proroghe del contratto precario da 5 a 4 e il limite massimo a 12 mesi, o aumentare le indennità da corrispondere in caso di licenziamento illegittimo (comunque non ripristinando l’art. 18, cioè la reintagrazione in caso di illeggittimità nel liceziamento). Tuttavia nemmeno questi blandi palliativi hanno inciso particolarmente sulla precarizzazione, infatti nel 2018 degli 11,4 milioni di rapporti di lavoro attivati (afferenti a 6,4 milioni di lavoratori) ben il 69,5% riguardava contratti precari, ai quali si aggiungono 1,9 milioni di contratti in somministrazione. D’altro canto però, rispetto agli anni precedenti, le trasformazioni contrattuali da precari a stabili sono aumentate dell’86% nel 2018, a fronte di un -34% del 2016 figlio della deregulation selvaggia del Jobs Act[5].
Ad oggi, secondo i dati per il 2020[6] e al netto della crisi Covid – che ha già mostrato i primi segni sull’occupazione (da febbraio 2020 ad oggi si sono persi 426.000 posti di lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti; numeri che riguardano soprattutto giovani, donne e precari) ma che dopo lo sblocco previsto per 31 marzo mostrerà le reali tragicità[7] – i contratti precari continuano a rimanere lo strumento privilegiato: il 68% di tutti i nuovi contratti stipulati, con, questa volta, un aumento non molto esaltante di quelli trasformati in stabili.
Per sintetizzare e districarsi tra numeri e statistiche storiche possiamo dire che, per quanto un leggerissimo freno sia stato posto alla precarizzazione dal 2018, essa rimane lo strumento di ricatto prediletto che i capitalisti, grazie ai loro lacché nei governi susseguitisi, hanno imposto e continuano ad imporre alla classe lavoratrice e alle nuove generazioni. Il che ci porta, quindi, a considerare che su 19 milioni di salariati in italia ben 3,2 milioni rappresentato la parte più sfruttata e debole della società: i precari[8]. Per capire l’importanza dei numeri del precariato, che rappresenta il 17% dei lavoratori, rispetto all’intera classe lavoratrice è molto utile dare uno sguardo al seguente grafico che ci mostra una fotografia generale della composizione di classe in Italia.
Dalla tabella della popolazione attiva (sono esclusi i circa 25 milioni di pensionati, studenti, e minori) si evince che il totale dei dipedenti privati e pubblici, con contratti a tempo indeterminato, ammonta rispettivamente a circa 12 milioni e mezzo e 3,1 milioni di lavoratori fra i quali, sia pubblici che privati, i quadri e i dirigenti erano, al 2015, rispettivamente 1,1 milioni e circa 400mila[9]. A completare il quadro dei salariati, e in posizione di sfruttamento più pesante, vi sono i 3,3 milioni di lavoratori precari e altrettati, secondo recenti stime, di lavoratori in nero[10]. Alla categoria degli ipersfruttati si può ben iscrivere anche quella quota di circa mezzo milione di lavoratori cosiddette finte partite Iva[11], formalmente lavoratori indipendenti ma in realtà in una posizione di forte subordinazione e mancanza di qualsivoglia garanzie e diritti. Ad essi si aggiungono i disoccupati ufficiali (cioè iscritti alle liste di collocamento), circa due milioni, e un esercito di oltre 6 milioni di inattivi, dei quali una larga parte sono proletari, giovani, donne, disoccupati, che per diverse ragioni non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. I capitalisti (1,4 milioni), commercianti che sfruttano manodopera salariata e piccoli commercianti, professionisti, artigiani e altri lavortori in proprio che non sfruttano manodopera salariata (3,3milioni), rappresentano le altre classi e sono state approfondite in un nostro precedente articolo.
Di fronte a questi dati, che fotografano una realtà del proletariato composita dove si riscontrano diversi livelli di sfruttamento, è indubbio che la tendenza principale sia quella ad un generalizzato impoverimento dei lavoratori in termini di salari e diritti e ad uno sfruttamento vieppiù crescente soprattutto fra le fasce della popolazione meno tutelate. La borghesia e i suoi sicofanti della stampa, della politica e perfino fra l’intelighenzia accademica, hanno sempre cercato di portare il conflitto su livelli orizzontali, tentando di mettere l’una contro l’altra le diverse categorie di lavoratori e disinnescare il conflitto di classe. Tipico di questo atteggiamento è, per esempio, la retorica contro i lavoratori “garantiti” del settore pubblico che ha accompagnato molto spesso l’iter controriformista, in special modo del Jobs Act, e che perfino in tempi di pandemia ha raggiunto livelli grotteschi come per esempio gli attachi contro gli infidi bidelli con il posto garantito o i lavoratori in smart working che “rubano” i buoni pasto alla collettività.
Considerata questa situazione, la necessità di riconquistare quella fetta di lavoratori alla lotta di classe e farli avvicinare alle istanze che unicamente potranno consentire loro di uscire dalla barbarie capitalista diventa un imperativo impellente. Tuttavia, di fronte allo stato dei fatti, la risposta dei sindacati italiani è stata negli ultimi anni alquanto deficitaria. Se vi è un forte attivismo fra le componenti più combattive del sindacalismo di base, che però sconta una frammentazione e un radicamento discontinuo fra tutte le categorie di lavoratori, i sindacati confederali – (CGIL, CISL e UIL) che insieme nei numeri dovrebbero raccogliere niente meno che circa 11 milioni di iscritti – negli ultimi anni hanno assistito impotenti, quando non si sono resi complici, alle aggressioni contro i lavoratori da parte dei capitalisti. Negli ultimi 20 anni, la più grande stagione di scioperi generali indetti dai confederali fu quella contro il governo Berlusconi dei primi anni duemila fra i quali si ricorda lo sciopero generale contro l’abolizione dell’art. 18 (abolizione passata nel silenzio 15 anni dopo!) dell’aprile del 2002[12]. Ultimi sussulti, è proprio il caso di dirlo, furono quelli contro la “riforma Fornero” del 2011.
Da allora, ad eccezione di scioperi settoriali, le forze sindacali maggiori non sono riuscite a mobilitare i lavoratori contro le crescenti controriforme sperimentate negli ultimi anni. Tuttavia, viene il sospetto, soprattutto guardando alla vicina Francia, che a mancare non sia stata tanto l’occasione – oltre sicuramente al fatto che i milioni di iscritti sono molto più sulla carta che nel reale – quanto la volontà politica. Ciò dimostra ancora una volta, semmai vi fosse bisogno di ulteriore prova, il livello di collusione e organicità dei confederali ai desiderata del padronato. Un contesto di forte crisi, di continue aggressioni e controriforme contro i diritti dei lavoratori avrebbero dovuto avere una risposta molto più assertiva da parte dei maggiori sindacati: l’esempio francese, in questo senso, dovrebbe fare scuola. Su un humus di contraddizioni e di attacchi ai diritti dei lavoratori non molto dissimile, un sindacato nei numeri molto più ridotto come la CGT (653.000 iscritti nel 2017) è riuscito a farsi interprete di una stagione di lotta come non se ne vedevano in Francia, e in tutta Europa, dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso.
Per riuscire ad avere un quadro più chiaro di quanto accaduto in Francia sul fronte sindacale, è bene dunque approfondire lo stato della lotta sindacale francese negli ultimi anni.
Le lotte dei lavoratori e la questione sindacale in Francia negli ultimi anni
La Francia ha conservato un livello di mobilitazione sociale, sindacale e politica più forte che in Italia. Le condizioni di vita dei lavoratori, sebbene in peggioramento, sono state difese con maggiore combattività e consapevolezza. Non che l’offensiva padronale sia di minore intensità rispetto all’Italia, anzi. L’avvio delle ostilità fu dato dalla proposta di riforma del codice del lavoro – la “Legge El Khomri“, dal nome del Ministro incaricato – avanzata nel marzo 2016 sotto la presidenza del socialista Hollande. Una riforma che rispondeva alle esigenze capitalistiche di liberalizzazione del mercato del lavoro (sulla scia del Jobs Act passato senza contestazioni di rilievo l’anno prima in Italia) prevedendo, tra le altre cose, la facilitazione dei licenziamenti economici e l’allentamento del regime delle 35 ore settimanali[13]. Contro questo progetto si levò un’accesa opposizione, strutturatasi intorno a un movimento sociale, conosciuto poi come movimento contro la Loi Travail. A dare il via alla controffensiva fu l’appello congiunto della CGT (Confédération générale du travail, omologo della CGIL e primo sindacato del paese), del movimento studentesco (Unione degli studenti, UNEF), del FSU (sindacato della funzione pubblica e degli insegnanti) e del sindacato di base SUD-Solidaires. Queste organizzazioni andavano a costituire il nucleo dell’intersindacale, organizzazione di coordinamento informale che guida da quel momento le lotte, al quale si aggiungeva in seguito in maniera salutaria Force Ouvrière, terzo sindacato del paese.
Incoraggiati dalla grande partecipazione alle prime manifestazioni gli oppositori continuarono a incalzare il governo al ritmo di una o due imponenti giornate di sciopero e cortei settimanali – fino ad arrivare ad azioni eclatanti come i blocchi dei depositi di carburante – per almeno tre mesi, al punto che la legge dovette essere approvata in agosto facendo ricorso al famigerato articolo 49-3 (una sorta di fiducia, che consente di far entrare in vigore provvedimenti di governo senza voto parlamentare[14]). Il governo Hollande si trovava infatti senza maggioranza parlamentare solida disposta a votare a cuor leggero un progetto che aveva infiammato a tal punto le piazze e che scontava l’ostilità persistente dell’opinione pubblica.
Il rigetto verso la controriforma e le sensibilità anticapitaliste che avevano animato il movimento si espressero anche alle elezioni presidenziali dell’aprile 2017 dove il candidato della sinistra radicale (France Insoumise e Partito comunista), Jean Luc Mélenchon, raccolse 7 milioni di voti sfiorando il secondo turno. Più che la contigenza elettoralista, quel che conta rimarcare è che questi consensi provenivano prevalentemente dai settori popolari e precari – Mélenchon risultava il più votato da disoccupati e giovani, e il secondo tra gli operai (il 34% dei quali ha votato Le Pen, il 24% Mélanchon, il 16% Macron, il 6% Hamon, candidato PS[15]) – e su un programma socialdemocratico certo riformista ma molto avanzato nell’attuale contesto del capitalismo europeo. Questo ricollegarsi della sinistra politica alle classi popolari spezzava per la prima volta da anni il monopolio che il Front National aveva stabilito su una parte della classe operaia, vittima della disindustrializzazione in particolare nelle regioni del nord, abbandonata dalla sinistra riformista post ’89. In tal modo, aveva sottratto all’estrema destra parte della base sociale grazie alla quale Le Pen pensava di essere catapultata in testa al primo turno. Ciò fu possibile solo grazie alla lotta di classe che aveva investito il Paese e acceso la miccia del conflitto sociale, delineando chiaramente le linee di scontro di classe.
Non per questo il movimento (né Melenchon), si schieravano con l’altro candidato della borghesia, il centrista Macron, già Ministro sotto Hollande, spinto dai media monopolistici e dagli ambienti d’affari parigini a dar vita al proprio movimento personale, come pseudo baluardo anti Le Pen, dopo che il Partito socialista si era autodistrutto e screditato. Appena dopo la sua elezione Macron decise infatti, senza sopresa, di approfondire l’opera iniziata nella precedente legislatura proponendo una nuova serie di decreti di controriforma del codice del lavoro. Il movimento anti Loi Travail rialzò la testa, sempre su appello dell’intersindacale a guida CGT, con le stesse modalità di due appuntamenti nazionali settimanali di sciopero generale e cortei. Questa formula si era rivelata in grado di coinvolgere ogni volta centinaia di migliaia di manifestanti e scioperanti in tutto il paese, federando di fatto collettivi, associazioni, sindacati e partiti in un’azione comune, con un’agenda chiara e parole d’ordine condivise. Avendo perso anche la battaglia dell’opinione pubblica, a stragrande maggioranza favorevole alle ragioni della protesta, dopo quella delle piazze sempre piene e represse brutalmente, il governo vinse sull’unico tavolo nel quale il suo potere era indisputabile, quello della Presidenza che approvò le misure per decreto, a metà 2018.
Se è vero, dunque, che le proteste non hanno impedito la promulgazione delle leggi, esse hanno tuttavia rivelato i metodi autoritari, violenti e anti democratici cui non esita a ricorrere la democrazia liberale per imporre provvedimenti a favore del capitale. Le repressioni poliziesche, inoltre, hanno mostrato la sostanziale unità d’intenti tra destre, pseudo-sinistre e media borghesi quando si tratta di colpire il lavoro. Dall’altro lato esse hanno consolidato una corrente di lotta che percorre strutturalmente la società francese, che ha la sua voce nel dibattito nazionale e fa pesare gli interessi dei lavoratori quotidianamente nelle aziende e nei luoghi di lavoro contro l’arroganza del Medef (la Confindustria francese). Hanno costituito insomma una buona scuola per il conflitto sociale e politico e un accumulo prezioso di energie.
Certo, non si può dire che in seguito a questa sconfitta il movimento non abbia accusato il colpo, in particolare le direzioni dei sindacati di lotta trovatesi improvvisamente a corto di strategie. È in questo periodo che il testimone della protesta passa a un nuovo attore improvvisamente apparso sulla scena, i Gilet Jaunes. Nato dalla rabbia innescata dall’aumento dei prezzi del carburante –visto da molti come l’ennesimo insostenibile balzello che andava ad aggravare il costo della vita, in particolare per quella Francia periferica delle piccole professioni autonome, dei salariati delle PME e dei “dimenticati” della provincia – il movimento dei Gilet Jaunes andava riversandosi nelle piazze e nelle strade di Francia urlando il suo rifiuto categorico di Macron. Dal novembre 2018 a metà 2019, il movimento imperversò nelle strade e nelle piazze francesi con inedita irruenza, cosa che fece non poco tremare il governo, segnando profondamente la coscienza collettiva e il quadro politico-sociale francese.
Inizialmente le dirigenze sindacali guardavano con diffidenza a questo movimento certo popolare ma multiforme ed eterogeneo, apparso spontaneamente e slegato da appartenenze politiche e sindacali tradizionali, che non né faceva un referente comprensibile né “affidabile”. Allo stesso modo, la gran parte di coloro risvegliatisi alla vita politica e alla lotta per la prima volta grazie ai Gilet Jaunes diffidavano pregiudizialmente dei sindacati visti come “parte del sistema”. In seguito tuttavia, nel corso delle lotte, e soprattutto grazie alle sempre più frequenti iniziative congiunte tra i sindacalisti della CGT (molti quadri e militanti, in particolare di area comunista e socialista radicale, sono estremamente critici, va detto, col moderatismo di alcune parti delle direzioni confederali) e i gruppi di GJ sul territorio, i due soggetti hanno imparato a conoscersi e rispettarsi, e trovare un terreno comune d’incontro, nel contesto delle mobilitazioni quotidiane contro Macron. Il che porterà il segretario CGT ad affermare, in occasione della tradizionale manifestazione del 1 maggio 2019[16], che la CGT e i GJ “si trovano ad avere molte rivendicazioni sociali comuni come l’aumento dei salari, il ripristino della patrimoniale, la giustizia fiscale, la difesa e il rilancio dei servizi pubblici”. Un’unità d’azione di fatto che dura tuttora, sebbene i Gilet Jaunes abbiano perso gran parte della loro forza iniziale.
Il movimento anti Loi Travail riemerge poi, in tutta la sua forza, tra il dicembre 2019 e il febbraio 2020 in occasione della presentazione da parte del governo di una nuova controriforma sulle pensioni. Il progetto è visto come una minaccia vitale all’impianto solidaristico dello Stato sociale francese e del benessere dei lavoratori (tra diminuzione di importi e apertura ai fondi privati) e incontra, con sorpresa del governo, un’opposizione ancor più massiccia, se possibile, di quella manifestatasi contro la Loi Travail[17]. Gli scioperi, i più grandi in Francia e in Europa dal ’68, hanno letteralmente paralizzato il paese per più di due mesi, coi lavoratori dei trasporti pubblici a guidare la protesta, a cui si sono aggregati altri settori in sofferenza, molti dei quali già presenti nel precedente movimento anti-Loi Travail. In particolare i portuali e gli operai delle raffinerie, i lavoratori della scuola, della sanità e delle poste, gli operai della compagnia elettrica statale, le rappresentanze (minoritarie, vedremo tra poco perché) dei metalmeccanici e del manifatturiero privato.
Sospesa a metà marzo nel contesto della pandemia, dopo essere stata adottata in prima lettura dall’Assemblea nazionale ancora grazie all’infame 49-3, – a conferma di un governo sordo alle rivendicazioni della stragrande maggioranza della popolazione – il destino del disegno di legge sulle pensioni rimane ad oggi incerto. Quel che è certo, è che se senza gli scioperi a oltranza, con l’enorme rilevanza mediatica e adesione popolare che hanno suscitato, la riforma sarebbe già in vigore nel silenzio. E oggi, dopo mesi di gestione catastrofica della pandemia, nuove mobilitazioni sono in corso nei settori dell’istruzione pubblica, sanità, energia, contro la chiusura dei cantieri, per migliori salari e per le 32 ore settimanali, fino al primo sciopero generale della stagione realizzato lo scorso 4 febbrario. Per non parlare delle manifestazioni ricorrenti contro il vergognoso progetto della “legge di sicurezza globale”, tesa a difendere gli abusi della polizia vietando le riprese video durante i cortei, impedendo così ai giornalisti di documentare le violenze[18].
Si può dire insomma, a conclusione di questo rapido e sicuramente non esaustivo resoconto, che parte della società francese è mobilitata da 5 anni ininterrottamente contro il corso liberale impresso dai vari governi in carica.
Conflitto: una questione non (solo) di quantità, ma di qualità
Certo non è tutto oro quel che luccica: la lotta si svolge in condizioni di rapporti di forza profondamente sfavorevoli ai lavoratori, dato che il capitale può contare sul sostegno indefettibile dei partiti (ad eccezione di un manipolo di deputati della France Insoumise e del PCF) e dell’assoluta fedeltà dei media (in Francia come altrove sono detenuti da un pugno di oligarchi[19]) all’egemonia neoliberale di cui l’UE è uno dei baluardi internazionali.
Di certo, la ristrutturazione del capitalismo internazionale a partire dagli anni ’70 e le leggi sul lavoro in questione hanno contribuito anche in Francia a disarticolare la classe lavoratrice. Secondo le più recenti statistiche sono circa tre milioni e mezzo i precari su 24 milioni di salariati[20], una percentuale importante, anche se più bassa di quella italiana. In Francia inoltre non esiste la pletora di tipologie contrattuali tipiche della situazione italiana; ve ne sono sostanzialmente due, i contratti tempo determinato e ad interim, a dimostrazione di come i legislatori italiani siano assolutamente all’avanguardia nel servire padroni e padroncini. La precarizzazione, e in questo le lotte sindacali hanno sicuramente effetto dissuasivo, non tende a generalizzarsi come il padronato certamente vorrebbe e a cui l’offensiva governativa degli ultimi anni cerca di porre rimedio.
Eppure, per quanto meno intensa che in Italia, già questa soglia di precarietà contribuisce a rendere difficile il lavoro di ricomposizione e organizzazione delle lotte, soprattutto nel settore privato che più è preso di mira dalla deregolamentazione. Ciò è stato paradossalmente evidente durante il più riuscito dei movimenti, quello appunto contro la riforma pensionistica. Non potremmo esprimerlo meglio delle parole di una sindacalista CGT di area comunista intervistato sulla questione:
“Ciò che abbiamo visto anche in questa mobilitazione è […] in parte il declino del movimento operaio organizzato in diverse grandi aziende private […] Questo è legato a diversi fattori, alla precarietà e allo frammentazione delle imprese tra subappaltatori e società madri, e anche all’interno delle diverse strutture, tra contratti a tempo indeterminato, interinali, contratti a tempo determinato … Tutto questo fa sì che i collettivi di lavoro siano strutturalmente fragilizzati dalle politiche padronali degli ultimi anni che rendono piuttosto difficile l’organizzazione dei lavoratori, organizzazione collettiva con strutture stabili. Questa situazione può essere vista molto concretamente nelle zone industriali […] anche nei luoghi in cui sono presenti militanti della CGT di buona volontà, ma che devono confrontarsi con questi ostacoli oggettivi.
L’unica cosa certa che possiamo dire è che tutti noi abbiamo una forza collettiva, ma solo alcuni ne sono consapevoli. Se smettiamo di lavorare tutti insieme, soprattutto nel settore privato, l’intera macchina economica si blocca. Questo è il rapporto di forza. Ma ciò che ci attende negli anni a venire è ovviamente la ricostruzione del movimento operaio nel settore privato. Questo è uno dei problemi principali e l’intera CGT deve appropriarsene.”[21]
Questo è uno dei problemi principale francesi, che in teoria non dovrebbe riguardare l’Italia, dove il sindacato, ad esempio la CGIL che conta più di 5 milioni di iscritti, ha una ottima penetrazione sia nel publico che nel privato, la sola Fiom conta circa 350.000 iscritti, e l’USB, primo sindacato di base non meno di 250.000. È in generale il tasso di sindacalizzazione complessivo in Italia ad attestarsi a più del 30%, mentre in Franica la CGT, in quanto primo sindacato (insieme ai riformisti della CFDT), non giunge a 700.000 iscritti. Le stesse organizzazioni che fanno parte dell’intersindacale, tranne Force Ouvrière che conta tuttavia non più di mezzo milione di aderenti, sono “piccole” organizzazioni da centomila iscritti ciascuna. La Francia è infatti, controintuivamente rispetto al resoconto di lotte che abbiamo appena fornito, un paese con tasso di sindacalizzazione bassissimo:
“La percentuale di lavoratori iscritti a un sindacato è invece particolarmente debole in Francia: circa 8%. Si tratta del più basso tasso tra tutti i paesi industrializzati, inferiore anche a quello di Stati Uniti, Corea e Turchia. Ciò non significa però assenza di rappresentanza sindacale, che al contrario in Francia, è elevata, soprattutto nel settore pubblico e nelle grandi aziende”[22]
Eppure, queste organizzazioni sono state e sono tuttora la spina dorsale di un movimento nazionale di lotta, un catalizzatore di conflitti sociali e democratici. I problema principale non è dunque la quantità, il problema sta nella qualità: quella data da una linea conflittuale combinata a radicamento effettivo e rappresentanza nelle aziende strategiche, e alla capacità-volontà di unità d’azione tra le organizzazioni. Il sindacalismo che doveva essere di lotta in Italia si è dato invece il ruolo di pompiere, con una CGIL che tiene congelate masse enormi di lavoratori da una parte, per le sue strategia di concertazione e ossequio agli interessi “nazionali” e confindustriali, e follemente parcellizzato in micro organizzazioni di base che non comunicano tra di loro dall’altra, pur essendo in certi contesti molto combattive nel portare avanti la lotta.
Per quanto vi siano differenze fra la situazione sindacale francese e quella italiana, il modello delle mobilitazioni francesi potrebbe e dovrebbe rappresentare dunque un esempio importante per l’organizzazione delle lotte oggi in Italia.
Note:
[1] Marta e Simone Fana, Basta salari da fame!, pp. 50
[2]https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/Lavoro%20non%20standard.pdf
[3] Dal Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie (2016) – Ministero del Lavoro
[5] Dal Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie (2018) – Ministero del Lavoro
[6] Dal Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie (2020) – Ministero del Lavoro
[7] https://www.ilsole24ore.com/art/giovani-donne-precari-ecco-chi-ha-pagato-piu-crisi-lavoro-ADo21wGB
[10] https://www.agi.it/economia/news/2020-09-26/coronavirus-cgia-disoccupazione-lavoro-nero-9767429/#:~:text=Gli%20ultimi%20dati%20disponibili%20dicono,prestare%20la%20propria%20attivit%C3%A0%20lavorativa.
[11] https://www.money.it/Partite-Iva-fittizie-in-aumento-a-vantaggio-di-chi
[12] http://archivio.rassegna.it/2002/lavoro/articoli/flessibilita/16aprile/prima.htm
[14] https://it.euronews.com/2016/07/17/49-comma-3-anche-la-francia-riscopre-il-decisionismo-di-governo
[15] https://pcimarche.wordpress.com/2017/05/11/francia-2017-tra-reazione-e-nuova-sinistra-popolare/
[18] https://www.dinamopress.it/news/la-francia-rivolta-la-legge-sulla-sicurezza/
[20] 3,7 millions de salariés précaires en France (inegalites.fr)
[22] http://www.amblav.it/Download/Lavoro_INCA_CGIL.pdf



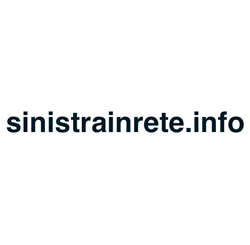




























Commenti recenti