Un libro necessario. “I confini contano” di Frank Furedi
Di La Fionda (Marco Adorni)

Ci sono libri che ti costringono a prendere una parte, che non ammettono vie di mezzo. Si tratta di opere d’intelletto che, anche quando non sono direttamente politiche, incorporano una funzione politica perché spingono il pensiero a confrontarsi in modo libero e disincantato con lo spirito del tempo.
In epoca di cancel culture, nazi-femminismo, polizia linguistica, antibinarismo, esaltazione fondamentalistica dell’apertura (in tutte le declinazioni possibili), dell’ibridazione (idem) e dell’identitarismo liberal (individualistico o di gruppo), un libro del genere è sicuramente Why Borders Matter: Why Humanity Must Relearn the Art of Drawing Boundaries del sociologo Frank Furedi, la cui traduzione in italiano, I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere, è stata pubblicata il marzo scorso con i tipi di Meltemi.
Operazioni come questa fanno bene a tutti, anche quando fanno male ai più; sono pubblicazioni che agiscono come vaccini quanto mai necessari al tempo della pandemia dell’indifferenza, quando non dell’aperta ostilità, verso quegli strumenti che l’astuzia della ragione storica ha “inventato” per erigere la democrazia moderna.
Di quali strumenti si tratta? Pensiamo al principio culturale di nazione; al concetto politico di patria; all’idea di politica come libero confronto dialettico tra opposte argomentazioni all’interno dello spazio pubblico; all’esistenza di un immaginario sociale fondato su tolleranza attiva, ovvero sia sulla capacità di ascolto sia sul coraggio parresiastico di «dire la verità» al potere; alla presenza di leggi che tutelano la privacy, la libertà e la coscienza individuale; a uno stile di pensiero fondato sulla distinzione binaria tra bene e male, sacro e profano, diritto e dovere, piacere e sacrificio, l’io e l’altro. Tutti questi strumenti compongono quella koiné democratica che, ai nostri giorni, è finita nel mirino, non dirò, di una critica serrata (cosa che sarebbe anche auspicabile e soprattutto in nome proprio di tale koiné) bensì di un’autentica crociata ideologica di chiara impostazione postmoderna, postdemocratica e neoliberale, che tiene come sacre bandiere quali l’apertura, l’illimitatezza, il desiderio, la liberazione dell’individualità, l’ibridazione dei saperi, dei generi, delle pratiche sociali, l’indeterminatezza morale e il relativismo etico, la trasgressione in sé e per sé.
Questa crociata considera come sua Terrasanta il χάος (lo spazio aperto-spalancato, l’entità primigenia della teogonia esiodea alle origini del mondo), la biblica terra inanis et vacua in cui non esiste possibilità di forma, ordine e senso. Se si trattasse di una parabola meramente nichilistica probabilmente non farebbe problema. Il punto critico è che tale orizzonte culturale è sostenuto a spada tratta dai poteri forti transazionali, particolarmente interessati all’idea che la si faccia finita, una volta per tutte, con l’odioso principio dello Stato-nazione (e gli istituti democratici che vi sono inestricabilmente connessi), causa di guerre e di intolleranza. Disfarsene è un’occasione ghiotta per far sì che gli animal spirits dei mercati del nostro tempo possano cacciare e predare a proprio piacimento.
Stiamo per approssimarci a un tempo in cui a mancare sarà proprio quel cosmos valoriale ed eteronormativo (di un ordine del mondo, di una forma e uno scopo sottratti alla congiuntura) dell’ordine delle “verità” che ha caratterizzato tanta parte della storia occidentale – non così per certo Oriente, in cui l’innovazione capitalistica va ancora a braccetto con l’ordine tradizionale, ma chissà per quanto.
Ordine del mondo di cui in Occidente vi sarebbe immensamente bisogno, in primis per costruire nuove fondamenta antropologiche e immaginarie al di fuori della “prigione biopolitica dell’aperto”. In fondo, si può anche dar ragione a Giorgio Agamben: effettivamente, il contemporaneo è il tempo del “campo”. Con una differenza da rimarcare, tuttavia: il “campo” non va inteso come riedizione del campo di concentramento nazista da riservare agli «scarti umani» (la massa degli apolidi migranti), quanto la dimensione ontologica delle esistenze di tutti, cittadini del mondo, cittadini delle nazioni e apolidi. Mi sto qui riferendo al fatto che si è introiettata, a livello di cultura di massa, una falsa idea di libertà come sprigionamento di sé, dei propri desideri di libertà e di autoaffermazione individuale. È avvenuto che siamo noi stessi la nostra prigione, che il nostro spettro cognitivo si sia ridotto a immagine e somiglianza della ragione liberale iperindividualistica. Se tutto è “aperto”, dove possiamo fuggire per ritrovare il senso perduto? A quale Recherche dovremmo dedicarci se il tempo della riflessione e dell’introspezione ci è stato tolto perché noi stessi non lo desideriamo nemmeno più?
Ecco, allora, la necessità di dotarci di attrezzi teorici per disegnare confini resilienti, capaci di resistere al mundus furiosus del capitale transnazionale e alla sua biopoliticizzazione. Il libro di Furedi è uno di tali strumenti: va interpretato allo stesso tempo come un manuale diagnostico dei disturbi della ragione liberale e, allo stesso tempo, come un manuale sull’arte di tracciare le frontiere necessarie a liberarcene in nome della democrazia e della giustizia sociale.
In netta opposizione con gli attivisti no borders e i fautori dell’ordine mondiale cosmopolitico, che considerano i confini «innaturali e immorali», Furedi li interpreta, in questa sua ultima pubblicazione, quali dispositivi spaziali che incarnano valori morali capaci di fornire significato all’esperienza umana. La questione, in sostanza, non è la naturalità dei confini. I confini certamente sono “inventati”; tuttavia, piuttosto che dedurre, da ciò, una presunta arbitrarietà dei confini, bisogna comprendere che la loro invenzione è necessaria per dare un senso e un progetto all’essere-nel-mondo. Da questa prospettiva, il pensiero cosmopolitico di Ulrich Beck finisce per essere il modello culturale a cui opporsi. Beck, insieme a Karl Popper, è a tutti gli effetti il capostipite del dispositivo ideologico odierno, il cui obiettivo è quello di smascherare la «menzogna dell’età della nazione» e portare a termine una rivoluzione cosmopolitica in nome della «giustizia globale».
Tale dispositivo parte dall’apparentemente virtuosa idea che «tutti gli esseri siano moralmente uguali a prescindere dalla loro origine e nazionalità, e che dunque dovrebbero essere riconosciuti loro gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri membri della comunità umana»; ne consegue che il patriottismo venga considerato «un vizio, e che coloro che appartengono a una comunità politica non abbiano il particolare dovere di prendersi cura l’uno dell’altro». Eppure, commenta Furedi, «con il fatto stesso di denunciare l’immoralità dei confini, [si ammette] che le linee che separano una nazione dall’altra sono in qualche modo rilevanti» (p. 49).
Certo, i confini possono essere escludenti e generare sentimenti di superiorità dei nativi rispetto ai nuovi arrivati. Tuttavia, è possibile costruire elementi di empatia e solidarietà, nonché «una prospettiva umanistica sul mondo», in assenza di confini territoriali?
«Un certo senso del territorio ha permesso alle persone di sentire che non appartenevano soltanto a un luogo fisico, ma a una comunità morale dotata di significato» (pp. 50-51). Se lo spazio incarna un contenuto morale, è perché acquisisce una connotazione concreta e specifica grazie ai confini. O uno spazio è delimitato o non è. E così vale anche per la morale: io sono io in funzione della mia differenza rispetto all’altro. La questione dei confini personali, peraltro, è estremamente presente anche ai più violenti critici nei confronti dei confini nazionali e ai più solleciti apologeti dell’apertura. Perché, è lecito chiedersi, tale sollecitudine non viene prestata nei confronti della tutela dei confini nazionali? Perché, appunto, la cifra ideologica della ragione liberale è oggi connaturata all’idea dell’illimitatezza e dell’assenza di freni al movimento di merci, capitali e persone. Eppure, la natura morale dello spazio è affermata in innumerevoli testi sacri, tra cui la Bibbia. Negli Atti degli Apostoli (17-22): «Dio creò da solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio».
Quando gli apologeti dell’apertura sostengono che il migrante sia una figura in sé negatrice dell’idea stessa di Stato-nazione, compiono un errore teorico di grossolana evidenza. Il migrante che lascia il proprio Paese va alla ricerca proprio di quella protezione che sa gli può essere garantita solo dal confine nazionale. Del resto, è proprio dal Chaos anomico e postnazionale che è fuggito: gran parte dei Paesi di origine dei migranti sono Stati falliti o in via di dissoluzione, alle prese col fondamentalismo islamico, la desertificazione e il rapace imperialismo delle multinazionali cinesi, americane ed occidentali (pensiamo solo al land grabbing e alle dittature militari africane) che ne depaupera le ricchezze naturali, determinando le migrazioni di massa.
Ciò detto, il vero fil rouge del libro di Furedi consiste in un ampliamento semantico del concetto di confine e dell’analisi su come il dispositivo ideologico liberale, devoto all’apertura, gli si sia accanito contro in tutti i suoi significati.
Tale dispositivo, infatti, è a tutti gli effetti un Kulturkampf permanente su scala globale il cui obiettivo palingenetico consiste nel riplasmare antropologicamente l’essere umano in un’entità polimorfa, in un nodo ibrido e transeunte costituito da un addensamento estemporaneo di linee prospettiche prodotte dai flussi perennemente in movimento della società globale (essenzialmente, tale è la caduta antropologica dell’immaginario cibernetico-transumanista). Di qui, la violazione continua dei confini tra privato e pubblico, la spettacolarizzazione della dimensione più intima (dalla sessualità alle tragedie personali) e delle emozioni (a scapito della ragione e del confronto ragionevole sulle idee), la svalutazione del riserbo, della sobrietà e del formale. Di qui, anche la fine della politica classica come arte del confronto dialettico ai fini del bene comune e la sua trasformazione in
un dispositivo retorico per attrarre l’attenzione. Gli studiosi sociali, accademici e non, si tengono occupati con riflessioni sulla Politica dei peli pubici. La prestigiosa rivista britannica «The Lancet» discute ampiamente della Politica della masturbazione. La politica delle mestruazioni è il tema di una seria monografia pubblicata su «Social Problems». Persino l’odore corporeo è stato politicizzato: secondo un intervento su «New Scientist», «se detesti l’odore del corpo, è più probabile che tu sia un sostenitore di Trump» (p. 166).
La rimozione del ‘politico’ tradizionale è figlia, d’altro canto, di un profondo e intenso attacco allo stesso pensiero binario, percepito ormai dal senso comune, non solo accademico, come sinonimo di arretratezza e abietto conservatorismo. Fenomeno di recente emersione, se pensiamo che, fino ancora agli anni Novanta del secolo scorso, non pochi intellettuali e di diversa estrazione (da Pierre Bourdieu al marxista Stuart Hall), sottolineavano come, pur essendo necessaria una critica agli odiosi fondamenti dei criteri di distinzione elaborati dalle élite dominanti, fosse indispensabile ammettere che «una cultura non può sopravvivere senza l’apporto dei confini simbolici» (p. 237). Ciò che si vuol dire è che le opposizioni binarie possono certamente essere usate in modo semplicistico e brutale, ma, senza il loro fondamentale contributo, il pensiero non può svilupparsi, men che meno un pensiero critico, radicale e rigoroso, che sappia accogliere il semplice fatto che «la categorizzazione duale “bianco o nero” non preclude il riconoscimento di un fenomeno che è grigio» (p. 241).
Fonte: https://www.lafionda.org/2021/05/31/un-libro-necessario-i-confini-contano-di-frank-furedi/


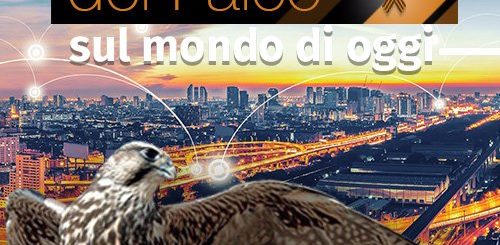





























Commenti recenti