La Repubblica Popolare a cento anni dalla nascita del Partito Comunista Cinese
di La Fionda (Alberto Bradanini)

Nel celebrare i cento anni di vita del Partito Comunista Cinese (Pcc), fondato a Shanghai nel luglio del 1921, va tenuto in conto che il Partito si trova alla guida del paese solo dal 1949, dunque 100 meno 28, 72 anni, una piccola ma significativa differenza, poiché sono soprattutto gli eventi del secondo dopoguerra quelli che ci aiutano a capire la storia della Cina contemporanea, gettando uno sguardo sul suo modello di comunismo, sulle eresie dottrinali rispetto all’Unione Sovietica, sulle scelte del Grande Timoniere Mao Zedong, sull’ascesa economica della Cina di Deng. In una scena affollata di quesiti, molti aspetti restano ancora tali, a dispetto del tempo trascorso. La Cina, infatti, non è ancora pronta ad aprire i suoi archivi, a rievocare i propri scheletri, a discutere per capire di più e meglio. Occorrerà aspettare che altra polvere si depositi sugli scaffali, che la dirigenza si convinca che l’emergere di qualche sgradevole verità non si rifletta in forma incresciosa sugli scenari politici attuali.
In estrema sintesi, il traguardo più straordinario per il quale il Partito meriterebbe il plauso universale, e non solo da parte del pensiero politico appartenente alla famiglia socialista, è rappresentato dalla vittoria sulla povertà, che nel caso della Cina profonda assumeva le sembianze di una miseria strutturale e secolare, nella quale la popolazione di un miliardo di persone sembrava destinata a languire per secoli e secoli. Ciò che sorprende la coscienza di chi condivide i valori eterni dell’umanesimo è il distacco emotivo, la fredda insensibilità della grande narrazione sinofobica occidentale che domina il discorso pubblico sulla Cina, una gigantesca postura omertosa di un sistema mediatico americano-centrico dominato dalla Menzogna. È ben evidente che, come affermava Mao, la rivoluzione non è un pranzo di gala, e dunque nemmeno l’uscita dal sottosviluppo lo è. Lo rivoluzione industriale in occidente ha richiesto il sacrificio di generazioni di uomini, donne e bambini, con danni profondi all’ambiente di vita. Si tratta di una realtà storica incontrovertibile che gli occidentali tendono a dimenticare, mentre nel mondo i paesi che hanno tentato di uscire dalla povertà e dal neocolonialismo, in cambio forzoso di sottomissione politica ed economica, sono costretti a confessare il fallimento del Washington consensus (l’acclamata via capitalista di uscita dal sottosviluppo) e guardano oggi al Beijing consensus con crescente interesse, quando non minacciati o occupati dalle truppe Usa. Il grandioso sviluppo economico della Cina costituisce la plastica evidenza del successo della via cinese all’uscita dal sottosviluppo, nonostante gli innegabili limiti in termini di libertà individuale e partecipazione politica effettiva (che del resto anche in occidente è un’araba fenice), i quali meritano un’analisi separata, senza pregiudizi tuttavia, o una strumentale demonizzazione.
La nozione di diritti umani, del resto, necessita di qualche approfondimento, poiché è di tutta evidenza che il primo diritto umano è quello alla vita, al cibo, a una casa per sé e la propria famiglia, e nei limiti delle risorse disponibili assistenza sanitaria in caso di malattia. Quando l’occidente denuncia i diritti umani in Cina oblitera strumentalmente questa fondamentale dimensione esegetica, concentrandosi solo sulle libertà politiche e civili individuali, il cui innegabile valore è tuttavia patrimonio di una sola parte della storia dell’umanità, non di tutta, sebbene sia auspicio universale che i migliori valori occidentali possano un giorno incontrare la migliore tradizione etica cinese (sia quella classica che quella politica recente, che è beninteso di genesi occidentale, pur essendosi incarnata nel modo di produzione asiatico).
D’altra parte, la rappresentazione deliberatamente deformata di tali scenari quotidianamente diffusa dai nostri media nasconde la cattiva coscienza di un occidente che distrugge la vita e le infrastrutture dei paesi che non si piegano al suo dominio (Iraq, Libia, Siria, Afghanistan, massacri e nefandezze di ogni genere, colpi di stato o esportazione di democrazia con bombe al napalm) non è nemmeno in grado di garantire il rispetto di quei diritti umani sostanziali che la sua ricchezza consentirebbe, quando la Cina (ben più povera in termini di Pil pro-capite) riesce invece a garantire alla sua sterminata popolazione una copertura simile o talora superiore (si pensi ad esempio ai livelli di occupazione). Va inoltre tenuto presente che nel contrattualismo liberale anglosassone dal quale nel Settecento è sorto il pensiero capitalista (Hume e Locke), tra i principali diritti umani era elencato anche quello alla proprietà privata, per di più senza limiti e garantita dallo stato. Un messaggio questo che il corporativismo privatistico americano-centrico – che controlla la piramide del potere finanziario mondiale ed è oggi al servizio permanente effettivo della conquista della Cina – non cessa di trasmettere al partito capitalista cinese, quale prospettiva di tutela della loro ricchezza privata illimitata. È questa una promessa alla quale i neoricchi cinesi prestano il massimo ascolto e a favore della quale tentano la scalata del potere politico cinese. Per il momento, tale velenosa deriva non sembra sfuggire al Partito Comunista, anche se l’esito finale è tutt’altro che scontato.
Sul piano internazionale, poi, la brutale contrapposizione alla Cina, imposta dagli Usa nel timore di dover condividere lo scettro del mondo, sembra riportare le alleanze al tempo lontano di Mao e Stalin, quando i due paesi allora entrambi comunisti erano alleati contro il medesimo nemico politico e ideologico. Dopo il giro di walzer di Nixon-Kissinger durante il quale Usa e Cina si erano de-ideologicamente accordati con un patto inedito in funzione antisovietica, Mosca e Pechino hanno riscoperto enormi cointeressenze economiche, energetiche e militari, insieme alla comune urgenza di tenere a freno la pervasiva aggressività degli Stati Uniti.
In linea con un’esegesi di genesi accademica, poi enfatizzata e finanziata dallo stato profondo Usa, il costante deterioramento delle relazioni tra Cina e Stati Uniti – che è invero l’esito deliberato della nuova guerra fredda che la patologia militarista americana ha lanciato contro la Repubblica Popolare – genera l’inquietudine che i due paesi possano un giorno venire alle mani (e le ricorrenti tensioni sullo stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale offrirebbero le migliori occasioni). Se i due paesi dovessero davvero piegarsi alla trappola di Tucidide, secondo la quale la potenza in ascesa e quella in declino non potrebbero evitare il conflitto per la supremazia mondiale, è facilmente intuibile cosa accadrebbe al nostro sciagurato pianeta.
Va invero tenuto presente che la guerra non è – e non dovrebbe essere – una realistica opzione per Pechino o Washington. È noto che i due paesi possiedono armi nucleari sufficienti per una plurima reciproca distruzione, insieme a quella di tutti noi. Non solo, persino le armi convenzionali detengono oggi la potenza di fuoco di distruggere la vita umana sul pianeta così come la conosciamo. In buona sostanza, la strumentalità della trappola di Tucidide mescola gli scenari politico-militari dell’epoca preatomica con la forza devastatrice di quella post-atomica, allo scopo di demonizzare la politica estera cinese, basata sul sacrosanto principio dell’indipendenza nazionale (al quale, sia detta en passant, i paesi europei hanno sciaguratamente rinunciato da tre quarti di secolo), con l’obiettivo di far crescere i bilanci della difesa, delle disinvolte agenzie di intelligence Usa e degli alleati-vassalli della Nato.
Non solo, un’azzardata narrazione di stampo accademico (finanziata dal complesso militare-industriale Usa) alimenta persino il convincimento che un eventuale confronto militare Washington-Pechino, se condotto all’interno di una finestra temporale ravvicinata, garantirebbe la vittoria dell’America, costringendo Pechino a capitolare. Come e chi possa realisticamente immaginare che questo sarebbe l’esito di tale scontro, resta un mistero insoluto. In realtà, molti fattori inducono a ritenere che nell’attuale scenario internazionale esista una sola opzione praticabile, vale a dire il compromesso politico, economico e dunque militare tra le due potenze, sebbene sia palese che una delle due è in ascesa e l’altra in (relativo) declino, al quale prima o poi dovrà rassegnarsi. Più che alla guerra, pertanto – e nonostante qualche inevitabile frizione economica e commerciale, e persino qualche sfioramento militare (ricordiamo tutti il bombardamento Usa dell’ambasciata cinese a Belgrado nel maggio 1999, che fortunatamente non ha avuto seguiti), Cina e America sono condannate alla pace!
D’altra parte, sono i governi che nella storia hanno voluto le guerre, non certo i popoli. Una semplice legge universale, se applicata, eliminerebbe i conflitti armati per sempre: “gli uomini politici che dichiarano una guerra, siano costretti a recarsi al fronte per primi”. In ogni caso, né il popolo americano, né quello cinese o l’umanità nel suo insieme, dunque, vogliono la distruzione del pianeta.
Compito di tutti, in specie dei movimenti politici e mediatici esterni al mainstream, ma anche dei partiti e dei grandi media che ci sommergono quotidianamente di analisi fantasiose e abborracciate, è quello di favorire il dialogo e il compromesso, con tutti e su tutto. A cento anni dalla nascita del Pcc, una delle lezioni che è forse possibile trarre è che la storia dell’emancipazione politica ed economica dei popoli è un fiume alimentato da numerosi torrenti che meritano tutti massimo rispetto e attenzione, affinché si giunga insieme e pacificamente al grande mare nostrum, dove i popoli della terra possano un giorno soddisfare le loro autentiche aspirazioni, sintetizzabili nella pace, libertà dal bisogno e dall’alienazione, nel rispetto dell’ambiente, nel progresso culturale e nella partecipazione politica.



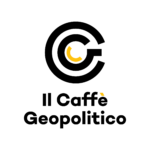




























Commenti recenti