Due nuovi protocolli sullo smart working: va peggio ai lavoratori del settore privato
di La Fionda (Savino Balzano)

A brevissima distanza l’uno dall’altro sono stati varati due importanti documenti in materia di smart working. Il primo riguarda la declinazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione: Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni(30 novembre 2021).Il secondo riguarda il settore privato: Protocollo nazionale di lavoro in modalità agile (7 dicembre 2021).
Per quanto entrambi i documenti presentino dei punti deboli decisamente evidenti, nondimeno i contenuti sono differenti e uno dei due risultati è marcatamente peggiore dell’altro.
Vi risparmio la disamina di apertura di entrambi i testi: la solita cascata di retorica secondo cui il mondo è cambiato, la crisi sanitaria ci ha dimostrato come certe cose siano possibili e necessarie, i cambiamenti (imminenti e ovviamente ineluttabili) ci renderanno tutti migliori e felici.
Andiamo al dunque.
In entrambi i documenti non si risolvono alcune questioni di fondo relativamente allo smart working: ad esempio quelle di natura economica, laddove non si prevedono indennità specifiche relative al fatto che il lavoratore si accolla parte dei costi di gestione quotidiana degli ambienti (le utenze innanzitutto, che specularmente il datore di lavoro si risparmia) e, soprattutto, nulla si dice in materia di buono pasto. È bene ricordare come il buono pasto sia uno strumento de facto retributivo a tutti gli effetti: le persone li adoperano per fare la spesa, per l’acquisto dunque di beni di primissima necessità. E non parliamo di due spicci: in alcuni casi il buono arriva a superare i 10 euro al giorno (se elettronico, defiscalizzato fino alla soglia degli 8 euro). Non mi venite a propinare la solita tiritera del risparmio dei costi per andare a lavoro (mezzi pubblici, carburante e roba del genere): quando ci sono (non è detto: uno potrebbe anche abitare a due passi dal posto di lavoro) non hanno nulla a che vedere con la prestazione lavorativa. Noi di questo dobbiamo discutere, della prestazione lavorativa: come le persone si recano a lavoro non ha nulla a che vedere con il rapporto tra azienda e dipendente. Sono fatti nostri: dobbiamo imparare ad essere gelosi di ciò che non riguarda il datore di lavoro; la controparte è molto più consapevole, ad esempio quando ci fa notare che l’organizzazione del lavoro è affar suo e dobbiamo tenere la bocca chiusa.
Resta in piedi il problema in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro: non sono chiari gli obblighi in capo al datore di lavoro, a prescindere da alcune affermazioni di dubbia applicabilità, se non quelli relativi all’informativa, poca roba davvero. Un luogo di lavoro sano non è affatto facile da costituire: servono sedie di un certo tipo, una illuminazione di un certo tipo, una scrivania di un certo tipo, aria di un certo tipo, un microclima di un certo tipo e così via (lo dice la legge: non è una mia opinione). Le caratteristiche di ogni strumentazione da adoperare, a partire da quelle più semplici, devono rispondere a criteri orientati alla salvaguardia della salute delle persone, nella sua accezione più ampia, quella di benessere. Ce lo ricordiamo peraltro che le case degli italiani sono assai diverse tra loro?
Qualcuno potrebbe obiettare che certe incombenze non possono essere addossate al datore di lavoro dal momento che lo smart working è libertà di lavorare da dove si vuole: dal mare, dalla crociera, dalla montagna, dai borghetti fantasma da ripopolare. E qui cominciano le differenze in quanto il protocollo del settore privato specifica chiaramente che il luogo di lavoro debba rispondere a specifiche caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Bye bye lavoro dal bosco: è chiaro l’intento di normalizzare la formula emergenziale di smart working conosciuta durante la crisi sanitaria, dal momento che le caratteristiche del luogo dal quale lavorare saranno indicate dai datori di lavoro che imporranno alle persone di lavorare da casa (come in moltissimi casi stanno già facendo!), senza ricorrere ovviamente al ben più tutelato telelavoro (che ve lo dico a fare…). È ciò che ho provato ad argomentare in altra sede: si ambisce ad una formula ibrida tra telelavoro e smart working, solo senza le tutele del primo. Semplice.
Le differenze non sono finite. A dispetto di una specifica previsione delle linee guida del settore pubblico, le quali chiaramente prescrivono come debba assicurarsi la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza, nulla si dice in merito nel protocollo del settore privato: chi si occupa di diritti dei lavoratori, anche per hobby (come molti dei quali si “cimentano” e ne scrivono), dovrebbe sapere come omettere determinati dettagli abbia un grande significato politico. Laddove la norma non è chiara e non disciplina nel dettaglio, a prevalere è la volontà del contraente più forte. Indovinate un po’ chi sarà.
Attenzione però perché quella che segue è ancora più grossa. Le linee guida (pubblico impiego) sono chiarissime su un punto: la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali. Vero è che questa previsione non è sufficiente in quanto tocca verificarne l’effettività e comunque anche la distribuzione del tempo (orario di lavoro) è importante perché consente di meglio definire i tempi di lavoro e quelli di riposo. Ma comprenderete come sia comunque molto diversa da quanto inserito nel documento relativo all’impiego privato: ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati. Riconosciamolo, si richiamano le norme di legge e di contratto, ma nessun riferimento esplicito si fa al tempo massimo di lavoro: per la verità, la parola massimo/a/i/e non è mai adoperata all’interno dell’articolato. Francamente desta preoccupazione la mancanza: l’idea è quella di un pericolosissimo avvicinamento col lavoro autonomo, magari superando il concetto di tempo massimo di lavoro (come si auspicava nel noto Piano Colao, laddove si proponeva di «massimizzare la flessibilità del lavoro individuale» e di «adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la performance sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile)»).
Occhio alla disconnessione. Vero, anche il documento in materia di pubblico impiego (infatti non mi entusiasma nemmeno quello) non indica espressamente quali siano gli strumenti per rendere effettivo il diritto, tuttavia si afferma che devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa: qui si esprime di fatto un vero e proprio divieto a lavorare (non può, inoperabilità) il che potrebbe persino esporre il lavoratore eccessivamente predisposto al lavoro fuori orario ad un procedimento disciplinare. Assai diverso da quanto si scrive nell’altro documento, laddove si prevede che vada individuata in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Nessun divieto: il tenore è assai diverso e incide, ve lo assicuro!, sulla effettività della misura.
Stesso discorso vale per la solita solfa sulla volontarietà del lavoro agile: non è obbligatorio. Certo, è vero, non lo è: come non è obbligatorio lavorare da una impalcatura senza cavi e senza casco. Eppure la gente lo fa lo stesso.
Vale la pena ricordare quanto affermava Luigi Mariucci nel 2010:
“Io domando sempre ai miei studenti perché mai nel 1970, ventidue anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che aveva già perfettamente dichiarato la serie dei diritti civili, politici, di libertà, ecc., c’è bisogno di fare una legge in cui c’è scritto che i lavoratori nelle aziende, nelle fabbriche possono esprimere liberamente la loro opinione. Perché c’è bisogno di fare una legge in cui c’è scritto che le guardie giurate non possono svolgere funzioni di controllo dei lavoratori? Perché c’è bisogno di scrivere una legge in cui si stabilisce che le visite personali di controllo, cioè le perquisizioni personali all’uscita dall’azienda sono vietate, tranne che siano regolate in un certo modo? Evidentemente perché quelle cose accadevano! Non basta dichiarare l’esistenza dei diritti individuali: la solitudine dei diritti individuali non porta molto in là; la storia è piena di dichiarazioni solenni sull’esistenza di diritti, nei fatti puntualmente violati. Quello che conta, e specialmente quando parliamo di diritti del lavoro, è mettere in moto meccanismi di effettività dei diritti, che alzino la soglia della effettiva realizzazione dei diritti. Questo è il punto[1].”
Entrambi i documenti mancano di adeguate protezione, ma pare assolutamente evidente come ad essere più esposti siano i lavoratori del settore privato (dove le esigenze di qualche famelico squalo sono intuibilmente più accentuate e legate a logiche di profitto), peraltro già gravati da una normativa in generale assai meno pro labour di quanto (giustamente!) sia quella del pubblico impiego. Eppure, se non ricordo male, da qualche parte una volta mi era parso di leggere che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (…) che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[1] Discorso tenuto il 4 giugno 2010, in occasione dell’Assemblea dei quadri e delegati CGIL di Venezia, intitolata Costituzione e Statuto dei lavoratori: senza diritti non c’è libertà.


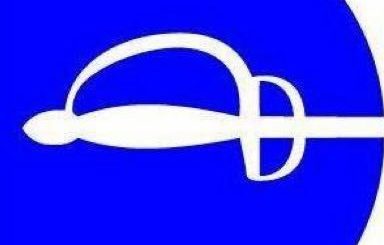





























Commenti recenti