Norimberga e i tribunali internazionali
di DOPPIO ZERO (Alberto Mittone)
“Un tribunale sul modello di Norimberga che processi la Russia per i crimini di guerra commessi in Ucraina”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’intervento al Consiglio di sicurezza Onu del 5 aprile, dove ancora ha ricordato che Mosca e i suoi generali stanno commettendo violenze atroci contro civili innocenti, accusando anche l’organizzazione internazionale di essere poco incisiva.
Il richiamo a Norimberga e a quel processo esige alcuni chiarimenti.
Il 20 novembre 1945 iniziava in quella città il processo penale che avrebbe giudicato i dirigenti del nazismo sopravvissuti alla caduta del regime. Era un evento straordinario sotto vari aspetti e il diritto internazionale ne fu influenzato perché si trattava di ridisegnare i legami tra Stato, violenza, guerra. In quell’occasione la sovranità giuridica dei singoli paesi fu posta in posizione subalterna rispetto a un tribunale internazionale costituito in quell’occasione dagli Alleati vincitori, ovvero da Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia, Regno Unito, per irrogare sanzioni nuove per i crimini nuovi. La scelta geografica cadde su Norimberga: il suo valore simbolico era indiscusso essendo la città delle “Celebrazioni del Partito del Reich” quando nel 1935, in occasione del 7° raduno nazionale nazista, furono varate alcune rilevanti normative quali la “Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco”, la “Legge sulla cittadinanza del Reich” e la “Legge sulla bandiera del Reich”. Inoltre Norimberga si trovava nel settore di competenza degli USA secondo la divisione dei territori stabilita nella conferenza di Potsdam tra i vincitori. Il palazzo di Giustizia era inoltre spazioso, quasi illeso dai bombardamenti e dotato di un’ampia prigione
I capi d’accusa erano una novità nel panorama penalistico e furono così strutturati: aver cospirato per commettere crimini contro la pace; aver pianificato, iniziato e intrapreso guerre d’aggressione, aver perpetrato crimini di guerra e, distinti da questi, anche crimini contro l’umanità. Si trattava di una rivoluzione politico-giuridica in quanto in precedenza la guerra veniva considerata la normale risoluzione dei conflitti (Hathaway-Shapiro, Gli internazionalisti, Neri Pozza, 2018).
Gli imputati furono variamente condannati tra il 30 settembre e il 1° ottobre 1946. I giudici francesi suggerirono la fucilazione per i militari condannati a morte, come avveniva davanti alle corti militari. Si opposero il giudice statunitense e quelli sovietici secondo cui, essendo stata violata l’etica militare, doveva escludersi una morte dignitosa quale la fucilazione. Si procedette all’impiccagione il 16 ottobre 1946 di 11 condannati, a cui avrebbe dovuto aggiungersi Goering che riuscì a suicidarsi la notte prima. Fu deciso che i cadaveri fossero cremati all’Ostfriedhof di Monaco, durante la guerra utilizzato per ricevere anche i corpi di prigionieri provenienti dai campi di concentramento. Le ceneri vennero sparse in un “fiume imprecisato della Germania”. I condannati al carcere furono trasferiti nella fortezza di Spandau.
Successivamente dal 1946 al 1949 si svolsero altri 12 processi, noti come “processi secondari di Norimberga”, davanti a tribunali militari statunitensi e non più a quello internazionale. Furono imputate per crimini di guerra circa duecento persone, classificate per professione (ad esempio medici, avvocati, giudici, industriali) attive nelle sfere politiche, economiche e sociali della Germania nazista.
I difensori contestarono la legittimità del processo invocando il principio di legalità secondo cui si può essere puniti solo per reati già vigenti al momento delle azioni perpetrate. L’eccezione fu respinta ritenendo che i crimini contestati rappresentavano una violazione di leggi internazionali preesistenti, quali la Convenzione dell’Aja, di Ginevra e il Patto Briand-Kellogg. I legali replicarono notando che questi trattati non erano vincolanti per Germania, Italia e Giappone in quanto non li avevano ratificati.
Anche questo argomento fu superato in quanto i giudici osservarono che, se una convenzione internazionale viene ratificata da un certo numero di Stati per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, essa può considerarsi vincolante per ogni nazione e non solo per quelle che l’hanno ratificata. Si squarciava il velo sul tema dell’irretroattività dei reati: gli Alleati avevano trovato la soluzione di definire i criminali nazisti come “hostis generis humani”, cioè nemici del genere umano. Si costruirono così nuove leggi per punire vecchi crimini innestati su presupposti “naturali”, cioè su quei principi di carattere generale, le ‘leggi non scritte’ ad esempio, che fondano il vivere civile, ritenendoli retroattivi, applicabili cioè anche al passato quando quei reati non esistevano. Si inanellarono dibattiti articolati e di alto livello (ampiamente Marquand-Melloni, La storia che giudica, la storia che assolve, Laterza, 2008; Portinaro, I conti con il passato, Feltrinelli 2011; Zolo, La giustizia dei vincitori, Laterza 2006).
L’illustre giurista H. Kelsen affermò che: “Solo una corte costituita da un trattato internazionale del quale non solo i vincitori, ma anche gli stati sconfitti siano parti contraenti, non incontrerà le difficoltà con cui dovrà confrontarsi una corte nazionale” (Il processo di Norimberga ed il diritto internazionale, Nuovi Studi Politici, vol.XIX,1989). Carl Schmitt, il più autorevole giurista tedesco del novecento, allorché dovette difendersi dalle accuse di connivenza con il nazismo eccepì il carattere politico del tribunale alleato. E contestò soprattutto la violazione dell’antico, inossidabile ed insuperabile precetto che impone di essere processati solo per comportamenti realizzati solo dopo l’entrata in vigore del reato di riferimento. (Risposte a Norimberga, Laterza 2006). Non trovò argomenti per replicare HannaH Arendt quando affermò: “Le motivazioni di solito addotte per giustificare che al Tribunale di Norimberga fu accordata la giurisdizione su questa materia, sono piuttosto deboli. È vero che dopo la prima guerra mondiale Guglielmo II fu citato dinanzi a un tribunale delle potenze alleate, ma il reato contestato non era la guerra, ma la violazione dei trattati….
È anche vero che il patto Briand-Kellogg dell’agosto 1928 condannò la guerra come strumento di politica nazionale, ma non conteneva un criterio per stabilire che cos’è un’aggressione, né accennava a sanzioni” (H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli 1963). In Italia entrò in campo il giurista Piero Calamandrei che, con spunti non strettamente giuridici, si oppose a quelle obiezioni “Qualche anima bennata si sente offesa e impietosita dinanzi a queste forche e a questi giustiziati. […] Non sarebbe stato possibile, di fronte a milioni di martirizzati innocenti adottare cautele che avrebbero trasformato la legge in uno sterile legalismo…. Né sarebbe potuto servire il pensiero di una giustizia amministrata dai vincitori, una giustizia disposta a dimenticare la bomba atomica e i bombardamenti a tappeto sulle città tedesche, giacché Norimberga aveva dimostrato che la spietata inumanità è sempre esposta al castigo, qualunque sia il campo da cui proviene”. (Le leggi di Antigone, Il Ponte, 1946).
Quest’intervento venne crudamente contrastato il 24.7.1947, nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente da Benedetto Croce: “Segno di turbamento sono i tribunali …che il vincitore ha istituito per giudicare, condannare, impiccare… abbandonando la diversa pratica, esente da ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere al vinto o ai suoi uomini, e se ne richiedeva la consegna per metterlo a morte, concludendo e proseguendo con ciò la guerra”. Il tribunale dei vincitori “offende la verità e la moralità perché cela l’utile ancorché egoistico del proprio popolo sotto la maschera del giudice imparziale e del proprio stato”.
Sempre nell’ambito dei principi giuridici fondamentali, denominati con magniloquenza l’“habeas corpus”, esisteva poi il problema dell’imparzialità, palesemente assente a Norimberga. La giustizia infatti trova la sua ragion d’essere nell’essere neutra, al di sopra delle parti in conflitto per contenere gli effetti distruttivi e le spinte aggressive. La contaminazione tra giustizia e politica è in larga parte ineliminabile, e in queste occasioni storiche la giustizia politica ebbe la meglio. “Se viene annullata la differenza tra giustizia e politica, il processo svolge soltanto funzioni extragiudiziarie come la teatralizzazione rituale della lotta politica, come stigma del nemico, come legittimazione procedurale delle misure da adottare” (Kirchheimer, Giustizia politica, Liberi libri, 2008). Del resto il problema dell’imparzialità non si è fermato a Norimberga, ma permane nei successivi Tribunale internazionali. Era ed è forse idealistico sperare che i governi che nominano i giudici, che mantengono personale e strutture, che finanziano le indagini, che mettono a disposizione le forze di polizia e le carceri, si astraggano dalle conteste processuali e si pongano in posizione neutrale. Soprattutto dopo aver sconfitto l’avversario, proprio quello che si vuole giudicare.
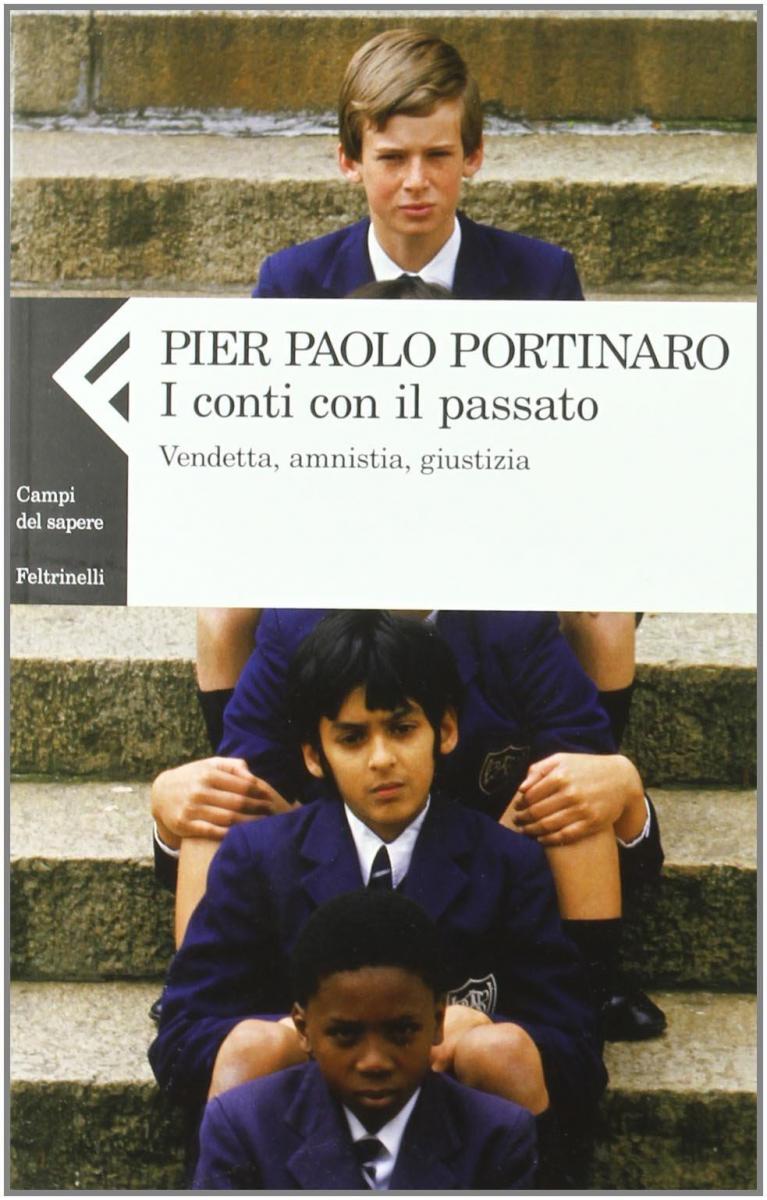
Il dopo. Il modello Norimberga
Norimberga ha avviato la stagione dei tribunali internazionali sui crimini di guerra istituiti ad hoc (ex Jugoslavia, Ruanda) e poi della Corte penale internazionale dell’Aja. (Su questi temi, tra i molti, Archibugi-Pease, Delitto e castigo nella società globale. Crimini e processi internazionali, Castelvecchi 2017; Baldissarra – Pezzino, Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica, L’Ancora del mediterraneo 2005; A. Cassese, L’esperienza del male, Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra, Il Mulino, 2011).
Il Tribunale per l’ex-Jugoslavia nacque nel 1993 programmato per sciogliersi nel 2017, con delibera del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, finanziato principalmente dagli USA, appoggiato sull’apparato istruttorio della Nato. Giudicò alcuni protagonisti di quella drammatica pagina, tra tutti Milosevic, coinvolto per crimini di guerra come l’uso di bombe a frammentazione e morto da imputato nel 2006. Si percepì subito che in quell’occasione si processava un avversario della Nato in una guerra dai ruoli non sempre nitidi. Più lineare fu il processo a Karadzic, incriminato per crimini commessi antecedentemente all’ingresso della Nato nella belligeranza. La condanna all’ergastolo, definitiva nel 2019, fu vissuta come un risarcimento ai bosniaci per l’orrenda guerra civile patita.
Del tutto peculiare è la vicenda giudiziaria relativa a Saddam Hussein. Invece di una corte internazionale fu costituito nel 2003 un Tribunale speciale formato da giudici iracheni. Palese fu la spinta degli USA che addirittura prepararono lo statuto, oltre che fornire le basi materiali e finanziarie. La competenza era chiara: non considerare i comportamenti delle truppe di occupazione, ma concentrarsi su Saddam e condannarlo il prima possibile. Si diede vita a un processo simulacro, teatrale e pubblicizzato, con un’impiccagione finale attesa, quasi annunciata, accompagnata da un sottofondo sonoro disonorevole, dal disprezzo e dagli sberleffi verso il condannato. Uno degli effetti fu di aumentare le divisioni settarie nel paese, legittimando verso l’ex dittatore ostilità in quanto nemico dell’umanità e contribuendo alla causa dell’odio. Non mancarono critiche severe, addirittura da parte di osservatori cauti e “diplomatici” come Sergio Romano (“Il tiranno martire”, Corriere della sera, 5.11.2006).
Si giunge alla Corte penale internazionale dell’Aja (International Criminal Court) istituita nel 1998 e operativa dal 1.07.2002. Essa non sostituisce la giurisdizione nazionale ma la affianca, per cui è stato eccepito dagli imputati che questo dualismo integra un vizio di giurisdizione. Si prefigurerebbe il rischio che venga violata la garanzia fondamentale secondo cui l’imputato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato, sia dalla giustizia nazionale che da quella internazionale. La Corte si può attivare solo con la notizia di un crimine commesso nel territorio di uno Stato firmatario o da un suo cittadino. Questo limite è superabile qualora uno stato non firmatario formalmente ne accetti la giurisdizione, come avvenuto con l’Ucraina nel 2014. Oggi sono 123 gli Stati che hanno aderito, sia inizialmente sia successivamente. Purtuttavia la Corte può superare anche quei limiti territoriali quando il Consiglio delle Nazioni Unite dà impulso a procedere per reati di sua competenza, così come avvenuto per i crimini commessi in Darfur e in Libia.
La Corte ha aperto numerose indagini, ma ha incriminato poche decine di persone (assai meno di quelle giudicate dai tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda che indagavano su un solo Paese e su un arco di tempo limitato) e ha chiuso non molti processi in quindici anni di attività. È pur vero che indagini e incriminazioni hanno un impatto politico incisivo perché segnalano quanto accadde in un paese, ma la Corte sconta comunque un difetto genetico. Grandi potenze come Russia, Cina ed USA non vi hanno aderito con le motivazioni più disparate. Quelle avanzate dagli USA sono quelle di sempre: solo la giustizia americana può avere a che fare con gli americani, ovunque si trovino o comunque si comportino.
Quando la Corte ha raggiunto imputati di rilievo, gli stessi Stati membri non hanno cooperato adeguatamente, come nella demoralizzante vicenda del capo sudanese Al-Bashir. Ricevuta la prima incriminazione, questi disse sprezzante che non valeva l’inchiostro con cui era stata scritta e purtroppo i fatti non lo smentirono. Iniziato il processo nel 2008 con due mandati d’arresto per crimini di guerra e contro l’umanità, nel 2010 al-Bashīr vinse le prime elezioni multipartitiche e poi nel aprile 2015 le successive con il 94,5% dei voti. Nel 2019, dopo proteste popolari, i militari lo destituirono, lo arrestarono per corruzione ed altri reati locali e fu estradato in seguito all’approvazione della legge con cui il Sudan aderì alla Corte dell’Aja. Dalle ultime notizie si è in attesa del processo.
Talora ha mostrato energia, ma si è trovata in difficoltà per l’inedia degli Stati membri, costretta a compiere una precipitosa marcia indietro come nella vicenda del presidente keniota Kenyatta. Nel dicembre del 2014 sono cadute le accuse di crimini contro l’umanità che sarebbero stati compiuti durante le elezioni del 2007, in quanto le prove sulla responsabilità non furono ritenute sufficienti. I procuratori avevano chiesto più tempo sostenendo che i testimoni erano stati corrotti e intimiditi e che il governo keniano si era rifiutato di consegnare documenti fondamentali. Non furono concessi rinvii e la situazione si è conclusa con l’archiviazione.
La giustizia di transizione
Il quadro che si compone è quello della “giuridificazione” della guerra, cioè il tentativo di far convivere il diritto e la guerra. La Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale aveva avuto l’obiettivo di evitare conflitti futuri, e si posero su questa linea dopo la seconda guerra mondiale l’Onu, i Tribunali di Norimberga, quelli successivi, la Corte penale internazionale.
Alcuni problemi possono ritenersi superati. I reati costruiti con Norimberga sono ora accettati, studiati e rientrano nel patrimonio penalistico. La questione della retroattività non è più attuale in quanto vengono contestati crimini commessi successivamente all’instaurazione dei Tribunali e Corti penali.
Rimane invece sempre in bilico il problema dell’imparzialità, così come è ancora attuale l’interrogativo sulla funzione della pena. Il tema è connaturato agli obiettivi del processo penale. A che serve quello strumento? Se viene individuato un responsabile, come deve essere trattato? Se si stabilisce con la condanna la sanzione, che finalità deve avere? Deve essere espiatoria, retributiva, esemplare, pedagogica, oppure riformatrice e rieducatrice come peraltro recita la nostra costituzione? Si deve fermamente ribadire che la pena esemplare, dall’acido sapore vendicativo, appartiene al diritto premoderno, impostato su una narrazione che voleva rafforzare i sentimenti popolari irrazionali e confermare gli stimoli della maggioranza.
Questa architettura della pena appartiene al rituale di degradazione dell’imputato, come osservato purtroppo ancora in tempi più recenti in una vistosa vicenda milanese (Fele-Giglioli- Cavicchioli, Rituali de degradazione: anatomia del processo Cusani, Il mulino,1997), rientra nella cerimonia collettiva in cui si assegna lo stigma, esclude la finalità di reinserimento, assolutizza il carcere come luogo di custodia per annientare i nemici della società. Oggi si può affermare serenamente che l’efficacia deterrente di quei processi internazionali è stata nulla, non sono diminuite le atrocità e i crimini, sono state avviate numerose guerre come quella di aggressione da cui siamo partiti. E analogamente si può affermare che il processo di Norimberga ha dato il via a un modo di regolare le pendenze che ha avuto un’enorme valenza simbolica. Del resto essere uccisi in guerra è normale, talora persino onorevole, ma essere giustiziati dopo un processo dal nemico vincitore è una sconfitta senza eguali, irrimediabile, degradante. Come è stato osservato, la guerra è uccidere il nemico, non condannare il vinto perché ha perso facendo trionfare l’arcaico “Guai ai vinti”. (Portinaro, introduzione a Demandt, Processare il nemico, Einaudi 1997).
E allora come può essere affrontato questo spinoso viluppo di problemi? Norimberga è stato un precedente giuridico negativo che ha contagiato la giustizia penale successiva? Quel processo e quelli seguenti, comunque la si metta e nonostante le obiezioni e le critiche, furono rilevanti per riconfermare un sistema normativo impostato sui ‘diritti umani’, da tutelare come principio prioritario e imprescindibile. Nel contempo fare giustizia ha l’obiettivo di interrompere la sequenza della divisione, dell’odio, dello spargimento di sangue. Deve tentare di esorcizzare il conflitto con i mezzi giudiziari per proteggere uno spazio di imparzialità senza il quale è arduo superare il conflitto. Per questo i tribunali internazionali, conclusa la guerra e lasciata la spada, possono costituire un passo verso la pacificazione della memoria collettiva e l’inibizione della vendetta generalizzata. Il compito è più complicato quando la guerra è ancora in corso, come nel caso ucraino, e i processi assumono le sembianze di armi puntate contro l’avversario.
Accanto a questa soluzione, teorica e idealizzata se ne individua un’altra, percorribile e legittima, la “giustizia riparativa”. Essa fu elaborata e concretizzata nel Sud Africa di Nelson Mandela con le “Commissioni per la verità e la riconciliazione” e poi riprese in molti paesi tormentati dalla guerra civile. Si tratta di leggere il fenomeno criminoso in termini relazionali, con il reo che si attiva con forme di riparazione del danno provocato, entrano in campo le reciproche narrazioni in cui gli uni e gli altri si sono trovati contrapposti, offensori o vittime. Si abbandona la prospettiva compensatoria, per appoggiare un comportamento attivo del reo volto a costruire il futuro con la vittima. Il danno, in altri termini, non si ripara, ma è la base per sanare la lesione sociale inferta dal crimine. In questi anni si sono aperte fessure in questo senso nella legislazione, ispirate dalla Raccomandazione n. 19 del 1999 del Consiglio d’Europa e oggi validate dalla Legge Delega sul nuovo codice processuale, la cd Riforma Cartabia (Legge 134 del 2021, art 1, commi 18 e 20). Vedremo. Sui tempi non si formulano previsioni.

































Commenti recenti