Franco Basaglia, 40 anni dopo
di GLI ASINI (Oreste Pivetta)

Ripubblichiamo un articolo uscito sul numero de Gli asini del 2020
Quarant’anni fa, a fine agosto, moriva appena cinquantenne Franco Basaglia, lo psichiatra veneziano che liberò i matti, mostrando poco alla volta come si sarebbe potuto restituire giustizia e diritti a chi le norme, anche antiche, il senso comune, una rassegnata consuetudine, persino la cultura accademica, persino la rassegnazione e la resa dei familiari avevano confinato tra le mura di uno spietato carcere a vita. Alla chiusura dei manicomi si giunse grazie alla legge 180, approvata nel 1978, nei giorni del rapimento e della morte di Aldo Moro e appena prima che venisse riconosciuto anche in Italia il diritto all’aborto. Furono due voti che chiusero un ventennio di riforme. Grandi riforme, dal divorzio al servizio militare, dall’obiezione di coscienza allo statuto dei lavoratori, dall’ordinamento regionale alla istituzione del servizio sanitario nazionale. Poi più niente. Poi ci fu Craxi e dopo Craxi arrivò Berlusconi. Alcuni parlamentari di Forza Italia proposero modifiche alla legge 180, soprattutto pretendendo che la durata del tso, il trattamento sanitario obbligatorio, si potesse allungare a discrezione di un medico, mortificando quelle misure e quei limiti fissati dalla stessa Costituzione a tutela del cittadino. Ci tentarono più volte, senza successo, anche solo per la sequenza di crisi di governo e per l’interruzione delle legislature. Sulla 180 provò ad allungare le mani Salvini, in nome della sicurezza, ripristinando l’idea che malattia mentale e pericolosità sociale andassero a braccetto come sosteneva la legge di un secolo fa, 1904, la prima nello stato unitario che regolamentasse in modo organico la materia psichiatrica.
Con quei regolamenti dovette fare i conti Franco Basaglia, quando per la prima volta entrò in un manicomio. Era il 1961. Basaglia aveva trentasette anni, una laurea in medicina e chirurgia (all’università di Padova), una specializzazione in malattie nervose e mentali (ancora a Padova, nella clinica del professor Belloni, un biologista che gli consigliò di rinunciare alla carriera universitaria), molte letture, letture spesso assai lontane dagli interessi specifici di uno psichiatra tradizionale, dalla fenomenologia di Heidegger all’esistenzialismo di Sartre, tanto è vero che era diventato per tutti, colleghi e professori, il “filosofo”. Per cultura, per sensibilità, per rifiuto di una pratica che faceva della psichiatria una sorta di casellario giudiziario, per classificare prima e reprimere poi, lasciò l’università e scelse il manicomio, con un posto di direttore.
Ricorderà che entrando negli stanzoni sudici di Gorizia era stato aggredito dalla stessa puzza che aveva provato nel carcere di Venezia, dove era stato rinchiuso nell’autunno nell’autunno del 1944, la città in mano ai nazisti, per la sua attività di antifascista, arrestato con alcuni amici per colpa di un delatore e liberato alla fine della guerra.
Comincerà, nella reazione all’obbrobrio del manicomio, di fronte a quelle scene di desolazione, all’uso della segregazione, quando la contenzione era la comoda abitudine per “curare” i malati (“E mi non firmo”, risponderà Basaglia all’ispettore capo di Gorizia che gli presentava, come doveva accadere ogni sera, l’elenco dei pazienti da legare), una “lunga marcia nelle istituzioni”, che si alimentava di piccoli gesti. Basaglia a Gorizia abolì le camicie di forza, tolse le sbarre alle finestre, aprì i reparti, accompagnò i malati a conoscere la città. Restituì anche i comodini, restituendo così uno spazio privato, che potesse custodire ricordi, oggetti, memorie di una vita o semplicemente uno specchio in cui ciascuno potesse riconoscersi. “Io non saprei proporre assolutamente niente di psichiatrico – dirà a Sergio Zavoli che lo intervistava per la Rai – in un ospedale tradizionale dove gli ammalati sono legati, perché nessuna terapia di nessun genere può dare un giovamento a persone costrette in una condizione di cattività nei confronti di chi le dovrebbe curare”.
Dopo Gorizia, Colorno, il manicomio di Parma nel castello che fu di Maria Luigia, la duchessa. A chiamare Basaglia fu Mario Tommasini, straordinaria figura di comunista eretico, operaio diventato assessore provinciale ai servizi sociali. Una breve esperienza interrotta di fronte alle resistenze della burocrazia regionale. Quindi l’incontro con Michele Zanetti, trentuno anni, democristiano, presidente dell’amministrazione provinciale di Trieste. Al San Giovanni (che “conteneva” allora un migliaio di pazienti), la sfida avviata a Gorizia si misurò con un nuovo obiettivo: il superamento del manicomio… Si arriverà alla chiusura, dopo aver accompagnato verso situazioni di normalità molti malati, dopo che fu costruita una rete di assistenza e di convivenza, case famiglia, centri di salute mentale nel territorio, prima comunque che una commissione parlamentare guidata dal senatore Bruno Orsini, psichiatra genovese, democristiano, varasse la 180, che verrà peraltro attuata vent’anni dopo, quando Rosy Bindi, allora ministro della sanità obbligò le Regioni a chiudere gli ospedali psichiatrici…
Trieste e la 180 rappresentano l’ultimo tratto del cammino di una riforma radicale, la dimostrazione che si poteva cancellare una istituzione totale, nata nella Francia della Rivoluzione, si potevano sottrarre i malati di mente a un’esistenza umiliante, cavie di un reclusione senza traguardi, si poteva cioè rispettare quanto la Costituzione aveva stabilito: che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non seguendo le disposizioni della legge, ma che la legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona (così l’articolo 32, voluto da Aldo Moro, allora giovanissimo costituente). Diceva Basaglia: abbiamo dimostrato che l’impossibile può diventare possibile. Come?
Basaglia, entrando a Gorizia, muovendosi tra quelle rovine materiali e morali, provò la solitudine e capì che avrebbe avuto bisogno di tanti alleati. Il primo fu Antonio Slavich, neolaureato senza esperienza alla prova d’esordio in quella terra di confine (il confine della ex Jugoslavia, che correva lungo il muro di cionta del manicomio). Gli altri alleati Basaglia li conquistò strada facendo: giovani medici, politici come Michele Zanetti e come Mario Tommasini, quanti lavoravano nei reparti, i malati stessi che poco alla volta riacquistarono una loro individualità, una loro volontà, la capacità di condividere e di partecipare (le assemblee, raccontate in un celebre libro, L’istituzione negata, furono l’occasione per tutti di discutere, di confrontarsi, di demolire le barriere tra medico e paziente), i fotografi che non avevano mai documentato quelle realtà e finalmente le mostrarono agli italiani, gli intellettuali che potevano attraversare quei mondi mai esplorati, gli artisti che impararono a esibirsi dentro quelle mura e, soprattutto a Trieste, i cittadini di Trieste. Aprire il manicomio fu vincere le paure, le diffidenze, i pregiudizi di chi stava oltre le mura.
La festa delle castagne fu un pretesto perché gli abitanti delle case vicine potessero entrare e sperimentassero che in fondo i matti non erano poi così diversi, soprattutto non erano più cattivi o pericolosi di qualsiasi altro loro concittadino. Quando Marco Cavallo, il quadrupede azzurro di cartapesta, fil di ferro e legno, creato lavorando con i matti da un artista come Vittorio Basaglia (scultore e cugino di Franco), varca il cancello del San Giovanni, seguito da un corteo di degenti, di medici, di infermieri, raccogliendo via via intorno a sé centinaia di persone, i problemi, le aspirazioni, i dolori di “dentro” incrociano i problemi, le aspirazioni, i dolori di “fuori”. Una questione di solidarietà, di vicinanza, di eguaglianza… Basaglia e i matti lo capiscono e così vincono la loro battaglia, una vittoria che nasce da un riformismo operoso, in un momento della nostra storia, a ridosso e oltre il nostro Sessantotto, quando l’orizzonte dei diritti è più vivo che mai. A suo modo Basaglia, un riformatore che giunge all’unica rivoluzione italiana (come in nessun altro paese al mondo), un intellettuale del fare, ci propone una lezione di politica per il presente: alleanze, condivisione, consenso, passi magari brevi ma un obiettivo chiaro… E viene in mente una frase di don Milani: “Bisogna fare per non subire e bisogna farlo con gli altri”.
FONTE:https://gliasinirivista.org/franco-basaglia-40-anni-dopo/


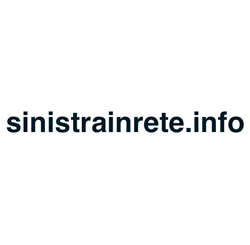





























Commenti recenti