Venti mesi in cui imparammo a disobbedire
di DOPPIOZERO (Enrico Manera)
Con Storia passionale della guerra partigiana (Laterza, 2023), Chiara Colombini, ricercatrice di Istoreto attiva nella rete dell’Istituto nazionale Parri, si colloca sulla scia della svolta impressa dall’opera fondamentale di Claudio Pavone, portando avanti l’indagine sulla soggettività dei partigiani e sulle tre guerre concentriche – anti-tedesca, antifascista e politicamente emancipativa – che costituiscono la Resistenza. È il racconto della lotta di Liberazione presa nel suo tempo e senza la consapevolezza del dopo, capace di sottrarsi tanto alla cristallizzazione memorialistica quanto alla monumentalizzazione ideologica, due dinamiche che interessano i decenni successivi, quando il “mito” della Resistenza diviene atto fondativo della Repubblica.
Rendere la Resistenza il faro del regime politico repubblicano si è rivelato un progetto di memoria pubblica sostanzialmente fallito, principalmente per lo scarto fra le migliori intenzioni della rinascita dello Stato nel dopoguerra e la realtà di una mancata presa in carico del rapporto con il fascismo e con le sue problematiche eredità. Se questo era uno dei focus del precedente lavoro di Colombini nella Storia passionale troviamo la pars costruens di una ricerca costituita da veri propri squarci di luce che ci portano lontano dall’uso pubblico della storia, un ambito usurato sul quale nel tempo si sono puntati i riflettori dell’agiografia o stese le ombre della demonizzazione ideologica, a seconda dei tempi e dei soggetti che ne hanno parlato.
L’impostazione del libro permette infatti di indagare una storia di grande complessità come quella dei venti mesi della lotta di Liberazione in Italia – che naturalmente ha un suo prima e un suo poi – parlando non di eroi o tantomeno di mostri, bensì entrando, con gli strumenti della ricerca storica, nel vivo di una vicenda di uomini e donne colti in relazione dinamica e dialettica con valori e istituzioni. A partire dal titolo, la Resistenza al centro del discorso è infatti quella della guerra partigiana: un fenomeno multidimensionale all’interno del più vasto scenario del secondo conflitto mondiale, dell’occupazione tedesca e della presenza del fascismo repubblicano, con una focalizzazione sul tema della violenza subìta e agìta, in un momento di guerra totale e civile internazionale.

In questo senso il libro intende ridare centralità alla Resistenza armata, dopo stagioni che avevano esplorato le resistenze “altre” (quelle senz’armi e dei civili, per esempio), sulla base di mutati paradigmi della memoria e sotto l’interdetto della violenza che la sensibilità post-totalitaria del tardo secondo Novecento ha contribuito a determinare.
La scrittura di Colombini, netta e chirurgica, ricostruisce la drammaticità di un processo in corso nel suo farsi incerto e problematico e risulta efficacissima grazie alle voci di protagonisti e protagoniste stratificate nella documentazione edita e inedita. L’analisi dell’autrice, che sintetizza periodizzazioni, dinamiche e tendenze caratterizzanti, adotta programmaticamente uno sguardo interno ed emico, costruito cioè a partire da fonti coeve, non posteriori agli eventi in atto. In questo modo, è possibile cogliere, in flagranti e in fieri, la dimensione passionale e conativa del fenomeno resistenziale, a partire dall’urgenza immediata e dalla mancanza di certezze su potenziale esito di una lotta asimmetrica, necessariamente imperfetta e costantemente bisognosa di tutto.
Non si può infatti dimenticare come la storia della Resistenza sia quella di un esercito di Liberazione che si forma in circostanze eccezionali ed estreme, composto da volontari – militanti, ex militari, intellettuali, renitenti, studenti, disertori italiani e stranieri – ma non solo: nella composizione delle bande dai vertici di comando alla base emerge la presenza di volta in volta di donne, operai e contadini e più in generale una sfera di coinvolgimento del “territorio”, senza il quale la lotta contro le truppe regolari meglio organizzate e armate del nazi-fascismo sarebbe stata impensabile.

Colombini, con rigore storico e al tempo stesso con una postura antiretorica di matrice fenogliana, usa dunque le decine di testimonianze incontrate nei lavori di ricerca documentale e storiografica e ci mette di fronte alla freschezza e alla tragicità dei vissuti, individuando una vera e propria palette di passioni e emozioni primarie amplificate dallo stato di eccezione. Dallo sgomento degli esordi alla gioia finale per la Liberazione, nelle parole dei tanti partigiani e partigiane evocate trovano posto le motivazioni della ricerca verso la giustizia e la libertà, lo slancio nella scelta e la fatica della lotta, l’angoscia dell’azione e lo strazio per i caduti, la paura del fallimento per sé e per gli altri, l’entusiasmo delle riuscite e delle vittorie.
Tali “passioni partigiane” sono rese ancora più interessanti nella loro urgenza e significatività quando nascono dalla comunicazione epistolare e dalla documentazione relativa alla risoluzione di problemi, divergenze o conflitti in corso. Da questa testualità, vivificata da una continua tensione per l’asprezza del contesto e per la drammaticità delle azioni che ognuno sente di dover compiere, emerge la determinazione del gesto fondativo della lotta partigiana: un atto continuamente rinnovato di disobbedienza collettiva a un’autorità ufficiale ma priva di legittimità; e una scelta di autodeterminazione in un presente incerto e da costruire, che comporta un lavoro costante prima di tutto su se stessi.

In altri termini, il cuore pulsante della Resistenza è l’affermazione di una sovranità individuale fondata in termini valoriali dopo l’abisso che si era spalancato sotto i piedi della società italiana dopo l’8 settembre. Pare banale dirlo, ma il valore e l’eredità di quella esperienza si misurano sul surplus di significato esistenziale che innerva la realtà quando sono in campo la vita e la morte, tanto nella dimensione privata quanto in quella pubblica e politica, in un contesto di rottura epocale e di apocalisse quotidiana, nella ricerca di un futuro nuovo, diverso e migliore rispetto allo stato di cose presenti generato da vent’anni di fascismo. Come scriveva Giorgio Agosti a Dante Livio Bianco nell’aprile 1944, «se ne usciremo vivi, ne usciremo migliori; se ci resteremo, sentiremo di aver lavato troppi anni di compromesso e di ignavia, di aver vissuto almeno qualche mese secondo un preciso imperativo morale».
«La stessa natura volontaria dell’esperienza partigiana», scrive Colombini, «è all’origine di gravi rischi e si crea una sorta di paradosso: per garantire la sopravvivenza del movimento diventa necessario cercare di mettere un freno – o per lo meno di costruire degli argini – alla libertà e alla spontaneità che ne hanno determinato la nascita». La dialettica tra spontaneità e organizzazione è la lente interpretativa per una fenomenologia di quegli aspetti – azioni di guerriglia e strategie d’azione, ma anche di amministrazione, disciplina e giustizia della “vita di banda” – che bisognava necessariamente utilizzare per il successo delle proprie azioni anche e a maggior ragione all’interno di un’organizzazione che nasceva come anti-fascista, anti-militarista e anti-gerarchica.
Le dinamiche storiche sono inseparabili dai moti dell’animo, dai sentimenti e dalle relazioni individuali e appaiono connesse alla passione politica e alla preparazione ideologica, anche queste vissute come novità liberatorie dopo una dittatura ventennale caratterizzata anche dalla retorica e dalla falsità della propaganda di regime; nell’antifascismo che si estende da sinistra a destra, nell’arco che va dal comunismo al liberalismo al cattolicesimo e di cui è specchio istituzionale il Comitato di Liberazione Nazionale, ricompare il pluralismo e con esso si va vivo per i soggetti che lo attraversano il bisogno di orientarsi nei dibattiti, di prendere posizione e di riconoscersi nelle differenti sfumature di significato delle parole come “Patria” e “Italia”.

Agli slanci dell’idealismo e dell’entusiasmo rispondono e fanno seguito i necessari compromessi dell’adattamento dettati dalla ragione e dalla durezza della realtà, tanto sul piano ideale e organizzativo quanto su quello logistico e militare: la Resistenza, scrive Colombini, appare così «un’insegnamento indelebile perché chi la vive scopre il prezzo, i limiti e la realtà entusiasmante della propria autonomia, e insieme sperimenta il senso dell’agire e del proprio protagonismo collettivo. In una parola, apprende il significato della libertà e della politica come mezzo per costruirla, impara i fondamenti della democrazia».
Decisivo in questo senso è l’interrogazione costante che emerge nei diari e nelle lettere sul significato dell’uso della violenza, ritenuta giusta e necessaria, difensiva ed emancipativa; un tema costantemente accompagnato dal ragionamento su mezzi e fini e dal sentimento di ingiustizia e di rabbia per il dolore provocato dalla brutalità dell’occupazione e della guerra civile. Si tratta di un dato che caratterizza l’orizzonte mentale comune e che entra in conflitto con le convinzioni politiche, morali e religiose dei combattenti e dei militanti, per i quali – a differenza del nemico – la violenza non è un valore identitario né fondativo. Una intera gamma di elementi separa il bisogno di giustizia dalla voglia di vendetta e dall’odio, un rischio percepito e che va evitato, in cui osserviamo il partigianato impegnarsi nella ricerca dell’equilibrio e nel disciplinamento della violenza – a partire dai regolamenti del Corpo Volontari della Libertà – in cui si avverte da un lato la preoccupazione di non perdere l’umanità, mostrarsi diversi da tedeschi e fascisti e non cadere nell’arbitrarietà dell’azione; e dall’altro quella di non cedere sull’intransigenza e sulla necessità di essere parte di un nuovo ordinamento di legalità e legittimità che prenda il posto di quello generato dai disvalori del nazifascismo.

La Storia passionale della guerra partigiana mostra chiaramente attraverso le parole dei suoi protagonisti, uomini e donne, come tra le molte difficoltà e non senza contraddizioni la lotta partigiana sia stata una esperienza di vita densa e rivoluzionaria, tale da trasformare per sempre chi l’ha vissuta. Un’esperienza orientata al futuro e alimentata da un profondo amore per la vita e da un bisogno di rinascita collettiva. Nell’aprile 1945, a Liberazione avvenuta, nell’imminenza del ritorno dalla prigionia in Germania, Enrica Filippini Lera scriveva al padre una lettera, simile a moltissime nei toni capaci di trasmettere una gioia e un’emozione collettiva di grande proiezione e trasporto: «Tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta. Lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande».
Da un nucleo incandescente di una gioia impastata di dolore e dal bisogno di “ballare sulle macerie” del dopoguerra sorge il meglio dello spirito della democrazia in fase aurorale del 1946-48. La guerra partigiana appare dunque così un processo che avviene nonostante tutto e anche quando tutto sembrava perduto, perché al feroce inverno 1944-45 segue la primavera del 1945 che diventa la marea della Liberazione alla fine di aprile: in quei venti mesi eccezionali hanno preso vita la progettazione creativa e l’utopia pratica di uno spazio pubblico che si trattava di inventare, dopo che la tradizione, la monarchia, il fascismo, una società ipocrita, arcaica e immobile avevano mostrato di aver fallito.

L’eredità della Resistenza appare opaca, quando non perduta o sconosciuta nel senso comune dell’attuale democrazia in crisi, anche a causa di un processo di “revisione” storico-istituzionale al ribasso, che ha accompagnato le vicende politiche degli ultimi decenni e che si è associata, rafforzandosi, all’amnesia storica e all’analfabetismo emotivo diffuso. Il presente pare dominato da un realismo individualista e da un disamore per qualsiasi ethos pubblico, quando non orientato a forme di integralismo e radicalismo risentito: a quasi ottanta anni da allora si tratta, ancora una volta, di fare propria quella forza immaginativa verso il futuro che ha caratterizzato la Resistenza.
In una prefazione del 1985 a Il barone rampante, l’ex partigiano Italo Calvino scriveva che «la disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella»: sono parole che ben descrivono il progetto della lotta partigiana e di quello che ancora significa nel presente.
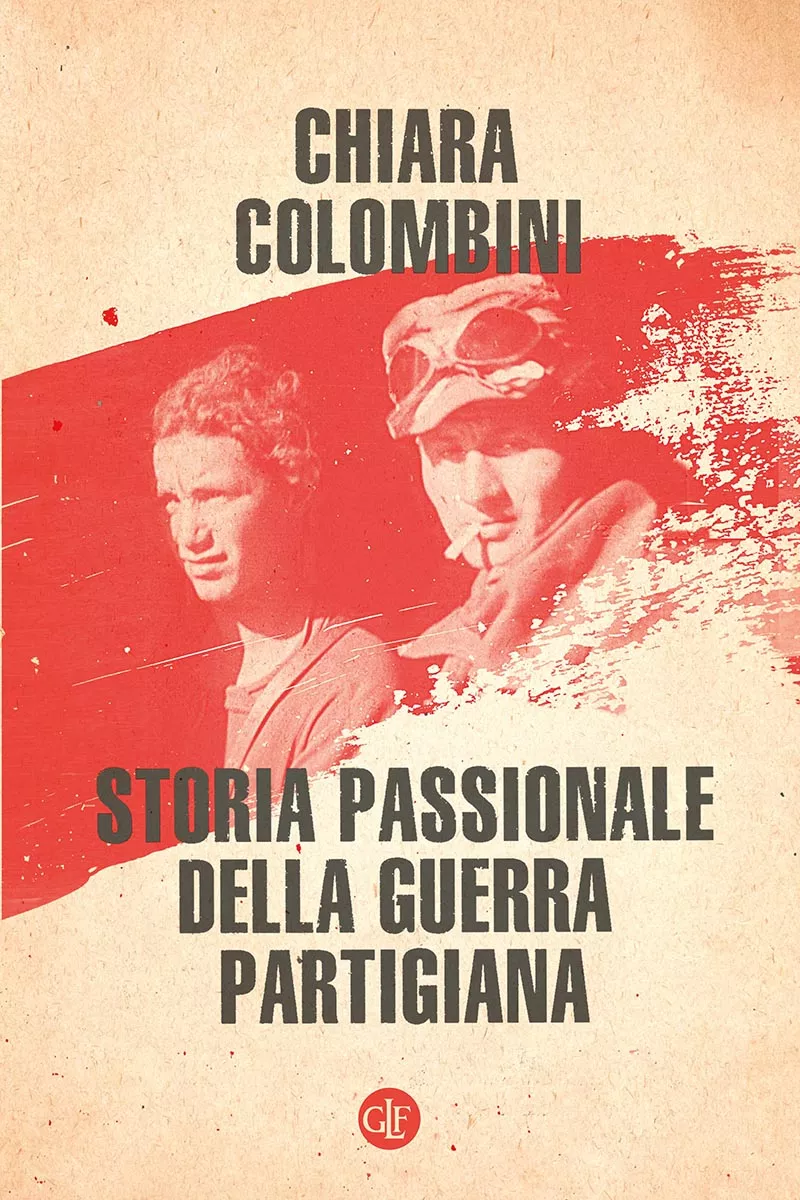
































Commenti recenti