Descrivere quanto accaduto a Columbia e più in generale nelle università degli Sati Uniti non è facile, soprattutto per me, che mi ci sono ritrovato coinvolto un po’ per caso, per via di alcune ricerche accademiche che mi hanno portato a New York, in quella che sarebbe diventata il cuore della protesta. Il lavoro perde d’importanza quando la storia ti capita così improvvisamente tra i piedi e provare a ricostruire quello che ho vissuto in questi giorni è un grande onore.
Rimando anche all’intervista che ho fatto ad Aidan, attivista queer e una delle voci della rivolta, per Napoli Monitor e Radio Onda d’Urto, e che ha ispirato questo articolo (disponibile qui e qui).
La notte tra il 30 aprile e il primo maggio, abbiamo assistito a una brutale prova di forza da parte delle autorità di Columbia e della polizia di New York. Almeno un migliaio di agenti ha fatto incursione all’interno del Campus, istituendo una zona rossa che militarizzava di fatto tutto l’Upper West Side. Sono state arrestate circa 170 persone, tra occupanti e solidali. Immagini di studenti trascinati e scaraventati giù dalle scale sono state diffuse sui social dagli stessi studenti presenti perché l’accesso al Campus era stato in parte limitato anche ai giornalisti e agli osservatori legali. Nel frattempo, veniva sgomberato anche l’accampamento di CCNY – City College of New York – mentre a UCLA, in California, l’accampamento degli studenti veniva attaccato da manifestanti pro-israele con lanci di fuochi d’artificio, mattoni e spranghe. Quanto accaduto quella notte è stato l’evento culminate di giorni di grande tensione e l’ultimo atto della politica di zero tolleranza promossa dalle autorità della Columbia. La spettacolarizzazione dello sgombero e l’impiego massiccio e sproporzionato della polizia è stato il chiaro tentativo delle autorità universitarie, cittadine e nazionali, di mostrare la loro fermezza e una prova di forza di fronte a un movimento che stava diventando sempre più grande e incontrollabile. Per capire come si è arrivati a questo punto, è giusto fare un passo indietro.
Fin dal mio arrivo, a gennaio, il campus era attraversato ogni due o tre giorni da qualche manifestazione per la Palestina. Il 17 Aprile, la presidente di Columbia Minouche Shafik era attesa alla Camera del Congresso per rendere conto di come l’amministrazione universitaria stesse gestendo le protesta all’interno del campus, accusate di antisemitismo. Prima di lei, a dicembre 2023, altre tre presidenti di importanti università – MIT, Pennsylvania University e Harvard – erano state sottoposte alle medesime procedure, conclusesi con le dimissioni di due loro. Questo è già particolarmente eloquente circa le modalità, anche piuttosto plateali, in cui la politica americana è in grado di intromettersi nella gestione delle università americane. Bisogna poi considerare il ruolo, decisivo, dei finanziatori che, con la minaccia di ritirare i fondi, possono direzionare drasticamente la gestione delle università americane, specie quelle Ivy League. Con il trumpismo e l’acuirsi della frattura cultura e sociale che attraversa il paese, il tentativo delle destre americane di intromettersi nell’educazione pubblica è diventato sempre più minaccioso e riguarda tanto le università pubbliche quanto quelle private. In Florida, per esempio, il governatore De Santis già dall’anno scorso ha bloccato i programmi “DEI – Diversity, Equity, Inclusion” in tutte le università pubbliche in nome della battaglia alla “dittatura woke”, cancellando corsi vicini alle “identity politics” e “divisivi” o basati “sulle teorie del razzismo, del sessismo e dell’oppressione sistemici”. In modalità diverse, università pubbliche e private sono facilmente influenzabili dalla politica e da interessi ideologici ed economici e il clima è quello di un rinnovato maccartismo, spinto dalla destra ma sostenuto anche da una parte dei democratici. Oggi la destra americana sfrutta l’antisemitismo – da sempre galoppante nelle loro fila – per attaccare i movimenti di protesta e le minoranze. È fondamentale tenere a mente questa strumentalizzazione e trasformazione delle Università in campi di battaglia politica e culturale, in atto da ben prima delle proteste contro il genocidio a Gaza, per comprendere il clima di tensione e caccia alle streghe che si vive oggi.
Minouche Shafik ha dimostrato di aver appreso la lezione inferta alle altre rettrici, chiarendo la sua netta condanna all’“antisemitismo” e destreggiandosi bene tra le domande, compresa quella del deputato repubblicano Rick Allen il quale, ricordando il passo della Genesi che afferma che chiunque maledica il popolo ebraico sarà a sua volta maledetto da Dio, le chiede: “Do you want Columbia University to be cursed by God?” “Definitely not”, la laconica risposta. La Presidente aveva già avuto modo di provare il suo posizionamento, fondando, alcuni giorni dopo l’attacco del 7 ottobre, una taskforce sull’antisemitismo all’interno dell’università, che tuttavia non dava una chiara definizione del concetto e lo faceva di fatto corrispondere a qualsiasi tipo di critica verso il sionismo e lo stato di Israele. Nello stesso periodo, ha anche modificato regole dell’università sulla gestione delle proteste, scavalcando il Senato accademico, e concentrando sull’amministrazione il potere di intervenire a propria discrezione. Poco dopo, Shafik ha fatto chiudere le due associazioni che più si stavano impegnando nel campus in supporto della causa palestinese, Students for Justice in Palestine e Jewish Voices for Peace, con l’accusa di violare le regole sulle proteste e di antisemitismo, impedendo così anche alcuni incontri di discussione sul tema all’interno dell’Università. Conseguentemente, gli attivisti hanno dato vita al Columbia University Aparthaid Divest, una rivitalizzazione del collettivo istituito contro l’aparthaid sudafricana. Il 3 aprile, sono stati sospesi tre studenti per aver deciso di non collaborare con le indagini dell’università. Il 10 aprile compare sul Columbia Spectator, giornale dell’università, una lettera di alcuni professori ebrei che denunciavano l’uso strumentale dell’antisemitismo e la narrazione distorta di quanto stava avvenendo all’interno del campus. Il clima, fuori e all’interno di Columbia, era quindi comprensibilmente molto teso già prima delle occupazioni.
Lo stesso giorno in cui Shafik si presentava alla Camera, veniva occupato l’east lawn, il prato est di fronte alla Butler Library, la biblioteca centrale di Columbia, con una trentina o quarantina di tende. Gli occupanti chiedevano trasparenza finanziaria degli investimenti dell’Università e la cessazione degli accordi di investimento verso e da Israele e l’amnistia verso gli studenti sospesi. Il giorno dopo, con un gesto ostentato e arrogante, per dar prova del pugno di ferro annunciato il giorno prima, Shafik ha risposto militarmente, acconsentendo all’entrata della polizia all’interno del campus che avrebbe portato allo sgombero coatto dell’accampamento e all’arresto di più di 100 persone e alla loro sospensione dal campus. Gli studenti sospesi sono stati privati dell’accesso ai buoni pasto e alle cure mediche e sfrattati dalle loro abitazioni. Gli studenti non americani che hanno solo un visto temporaneo sono quelli che rischiano più di tutti, per loro la minaccia più grande è l’espulsione dal paese. Nel frattempo, un buon numero di solidali si radunava intorno al prato picchettandolo per difenderlo dall’imminente sgombero. Le immagini delle decine e decine di poliziotti che trascinano via gli studenti e distruggono le tende sono state tristi e penose – sembrava il peggio a cui si potesse pensare, invece non erano nulla a confronto di quelle del 30 aprile. Fin da subito l’arrivo della polizia ha scatenato la rabbia degli studenti venuti in supporto, ormai parecchie centinaia, al punto che alcuni di loro, senza pianificazione, hanno deciso di saltare la piccola siepe che circonda il prato ovest, occupandolo mentre lo sgombero dell’altro era ancora in corso e dando così vita al secondo accampamento, che il giorno dopo sarebbe stato ben più grande e organizzato del primo. Anche buona parte del corpo docente si è espressa contro la scelta della Presidente, e molti professori hanno manifestato sulle gradinate sotto la statua della Minerva con in mano cartelli con la scritta “Hands off our students”, “giù le mani dai nostri studenti”. Nei giorni seguenti, molti di loro hanno dato supporto all’accampamento, pattugliando il perimetro e assicurandosi che non entrassero provocatori o infiltrati. Moltissime sono state anche le lettere di condanna a Shafik: ho trovato significativa la lettera scritta dai professori “untenured”, ovvero senza contratto determinato perché molti dei firmatari hanno aderito in modo anonimo: per timore di rappresaglie da parte dell’amministrazione, indicano solo il grado accademico e il dipartimento.
È nato così l’accampamento di Columbia, il primo di moltissimi altri che sarebbero sorti in giro per gli Stati Uniti. I 14 giorni di accampamento resteranno nella Storia e saranno un ricordo prezioso nella memoria collettiva di chi vi ha partecipato. Centinaia di studenti lo hanno attraversato tra dibattiti, incontri e momenti di festa. Ad ogni ora era possibile trovare da mangiare, grazie alle provviste fornite dagli studenti ma anche dagli abitanti e dai negozi del quartiere. Una delle tende era diventata la biblioteca dell’accampamento, un’altra dava assistenza sanitaria e psicologica. I professori tenevano lezioni e discussioni. L’aria che si respirava era di grande entusiasmo, desiderio e combattività, in netto contrasto con l’aura austera e elitaria che aleggia spesso intorno ai grandi college americani. Uno degli aspetti più interessanti da sollevare è quello della composizione sociale e culturale di chi protesta dentro e fuori dai campus. La maggior parte, e soprattutto coloro che più si sono esposti, fanno parte di minoranze black, brown e queer, nonché arabe e musulmane, che già da tempo negli USA come altrove sono diventati i nuovi protagonisti delle lotte sociali. Ovviamente, Columbia fa i conti con il suo essere una scuola di élite e la differenza di classe è talvolta percepibile, tuttavia la stessa composizione è riscontrabile anche negli altri college dove la protesta è esplosa e anche al di fuori delle università. Va però anche sottolineato che molti ricevono borse di studio mentre per altri le famiglie sono disposte a indebitarsi perché i figli abbiano accesso all’istruzione di alto livello che è l’unica forma di ascensore sociale negli USA. Questa differenza è ben percepibile quando si osservano le contro-proteste dei sostenitori di Israele, generalmente bianche e spesso piene di fondamentalisti cristiani e gruppi neofascisti, spesso molto violenti. Un altro aspetto da notare è l’ampissima partecipazione di studenti ebrei, fin da subito in prima fila nelle proteste. Come dicevo, a Columbia, una delle associazioni che più si è esposta è stata Jewish Voices for peace, chiusa a novembre. E molti studenti ebrei sono stati sospesi, amara ironia, con l’accusa di antisemitismo. Nei giorni di Pesach, nell’accampamento gli studenti ebrei hanno festeggiato il Seder insieme agli altri manifestanti mentre a New York si teneva una grossa manifestazione di soli ebrei contro il genocidio. Grande supporto è stato espresso anche dagli ebrei ultraortodossi Neturei Karta, che si oppongono allo stato di Israele e hanno manifestato fuori dal campus in sostegno all’occupazione.
Nel frattempo, le occupazioni si diffondevano prima a New York e dintorni – NYU, Yale, CUNI ecc. – e poi in tutti gli Stati Uniti, da una costa all’altra, spesso represse con la stessa logica violenta e securitaria da parte delle amministrazioni. La polizia ha spezzato il cordone di professori che difendeva gli studenti accampati a NYU, arrestandone alcuni. Particolarmente forti sono state le immagini arrivate dalla Emory University di Atlanta, dove la polizia ha brutalmente picchiato studenti, soprattutto neri, e professori. Lì la tensione è particolarmente alta a causa dell’opposizione da parte di attivisti/e e cittadine/i all’Atlanta Public Safety Training Center, meglio nota come Cop City, un enorme campo di addestramento della polizia in costruzione in una foresta fuori città. Un giovane attivista è stato ucciso l’anno scorso dalla polizia durante degli scontri.
La scelta di campo dell’amministrazione di Columbia, caduta completamente nella trappola della destra repubblicana, è stata tanto chiara da aver permesso allo speaker repubblicano Mike Johnson di tenere un comizio sui gradini centrali sotto la Low Memorial Library, di fronte all’accampamento, accusando gli attivisti di antisemitismo e invocando l’invio della Guardia Nazionale. Lo stesso giorno, nonostante già alcuni giorni prima dell’inizio dell’accampamento l’accesso al campus fosse stato ristretto solo a chi era dotato di identificativo della Columbia, a provocare gli studenti c’era anche Gavin McInnes, fondatore dei Proud Boys, organizzazione neofascista militante vicina all’ex presidente Donald Trump. È interessante poi notare che dietro la gestione eufemisticamente intransigente della protesta a Columbia c’è, tra gli altri, Cas Halloway, nominato “chief operating officer” a gennaio 2024 per gestire la “tensione” nel campus. Cas Halloway è stato deputy mayor durante l’amministrazione Bloomberg della città nel 2011 e responsabile della repressione delle proteste di Zuccotti Park durante Occupy Wall Street. Mentre alcune università, come University of Minnesota e Brown, hanno effettivamente accettato di intavolare una seria negoziazione, accettando per esempio di rendere pubblici gli investimenti e, nel caso della Brown, di mettere ai voti la proposta di disinvestimento, alla Columbia il tavolo di trattative non ha portato a nulla. Il 29 aprile, dopo più di dieci giorni di accampamento, la rettrice ha dichiarato concluse, con un nulla di fatto, le negoziazioni intraprese con gli studenti in protesta e ha annunciato l’ultimatum delle 2 del pomeriggio per abbandonare l’accampamento. A quel punto è stato distribuito da parte delle autorità universitarie un modulo che gli/le occupanti sarebbero stati tenuti a firmare, autodenunciandosi, per evitare la sospensione. I cestini del campus si sono improvvisamente riempiti di carta stracciata mentre sopraggiungevano altri studenti e le studentesse a difendere l’accampamento.
In almeno un migliaio si sono radunati e hanno marciato intorno all’area centrale del Campus di Columbia in sostegno agli occupanti. Questi non si sono consegnati e alle 10 di sera l’amministrazione ha annunciato i procedimenti di sospensione. A mezzanotte e mezza circa, i manifestanti hanno occupato uno degli edifici della Columbia, Hamilton Hall, rinominato “Hind’s Hall”, in onore a Hind Rajab, bambina di 5 anni uccisa dall’esercito israeliano. La scelta dell’edificio non è casuale: quello stesso edificio fu occupato e sgomberato durante le storiche proteste di Columbia contro la guerra in Vietnam e contro il razzismo, che fecero scoppiare il ‘68 americano.
La linea dura di Shafik, sebbene sia il tentativo, goffo e sgraziato, di mantenersi al proprio posto, ha anche avuto un effetto positivo. Come mi ha fatto notare Elizabeth Povinelli, Franz Boas Professor di Antropologia e Studi di Genere e fra coloro che si sono attivati in sostegno degli studenti, non solo la rettrice ha compattato studenti e professori, compresi quelli più restii a esporsi, ma ha fatto esplodere un movimento nazionale e internazionale riunito intorno a un nuovo simbolo, quello di una tenda. Simbolo che, con l’invio della polizia e lo sgombero, lei stessa ha contribuito a creare. Mentre, infatti, gli accampamenti vengono sgomberati negli Stati Uniti, tanti altri si diffondono in Canada, Spagna, Francia, Inghilterra… Inoltre, richiamandosi alla storica occupazione di Columbia del’68, gli studenti hanno ritessuto un filo che li lega alle lotte passate, dandogli forza, e contribuito a sentirsi figli e parte di un immaginario e di una storia collettiva. Per quanto dolorose siano state le immagini dello sgombero e di quelli che stanno avvenendo via via anche negli altri campus, sono giornate che passeranno alla Storia, repressione o meno, e uno spartiacque si è creato, qui, come anche nel resto del mondo. È presto per dire cosa avverrà dopo questa ondata repressiva ma sicuramente qualcosa è cambiato nella società americana contribuendo a definire sempre più chiaramente i termini dello scontro politico culturale e sociale degli ultimi anni, come già aveva fatto Black Lives Metter, tra una destra che ha gettato via la maschera e mostrato il suo volto sempre più conservatore, suprematista e razzista e il movimento variegato delle diverse minoranze che compongono il paese e che hanno trovato nella lotta contro il genocidio a Gaza un punto di unione e identificazione.




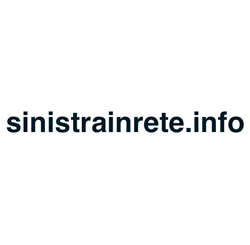




























Commenti recenti