La transizione spagnola: dalla dittatura militare alla dittatura dei mercati
di AZIONE CULTURALE (Andrea Virga)
L’ultimo anno, trascorso in Spagna, mi ha naturalmente portato ad approfondire la storia di questo Paese e in particolare le radici dell’attuale crisi economica e politica. Se analizziamo la transizione spagnola alla democrazia liberale possiamo vedere come questa, per come fu condotta, contenga già in nuce questi problemi.
Cominciamo dalla parte economica. Nel secondo dopoguerra la Spagna, già arretrata rispetto al resto dell’Europa occidentale, soffriva, oltre alle conseguenze di una feroce e distruttiva guerra civile costata più di un milione tra morti e profughi, l’isolamento sul piano internazionale dovuto al persistere di un regime nazionalconservatore e filofascista. D’altra parte dagli anni ’50, grazie ad un accordo con gli Stati Uniti che assicurava aiuti economici in cambio della base navale di Rota, e allo sviluppo dell’industria turistica, l’economia iniziò a crescere, seppure rallentata da una macchinosa burocrazia. Solo verso la fine del decennio, Francisco Franco sottrasse il controllo dell’economia ai falangisti, fautori di una politica autarchica, per affidarla ai tecnocrati dell’Opus Dei.
La loro politica di liberalizzazione dell’economia e di apertura agli investimenti stranieri (soprattutto statunitensi, ma anche svizzeri, tedeschi, francesi e italiani) era però controllata e regolata da una forte presenza statale. L’Instituto Nacional de Industria controllava praticamente tutta l’industria pesante, le attività estrattive e i servizi turistici, e pure ferrovie e telecomunicazioni appartenevano allo Stato. Inoltre una serie di dazi proteggevano il mercato interno, consentendo all’industria nazionale di svilupparsi, tant’è che nel 1975, appena un ottavo dei capitali investiti erano stranieri.
Un esempio da manuale fu l’industria automobilistica Seat, azienda a maggioranza statale, fondata nel 1948 – con l’aiuto della Fiat, che contava così di rientrare dei crediti bellici contratti durante la guerra civile –, e divenuta uno dei motori della crescita. Se aggiungiamo l’esodo di forza lavoro a basso costo dalle campagne alle città industriali, il contributo delle rimesse dei numerosi emigranti e l’esplosione del turismo (20 milioni di turisti già nel 1960), si comprende come mai si parli di “Miracolo Spagnolo” per il periodo tra il 1959 e il 1974, quando la Spagna crebbe più di ogni altro Paese, eccetto il Giappone.
La morte di Franco nel 1975, con la conseguente instabilità data dal processo di transizione, coincise con la crisi economica mondiale dovuta all’aumento dei prezzi del petrolio, di cui la Spagna era peraltro un forte importatore. Questo determinò una forte inflazione, unita ad un calo della produttività e ad un aumento della disoccupazione. Il primo ministro socialista Felipe González (1982-1996), a fianco di una riforma dello stato sociale su base avviò una serie di politiche liberiste di tagli alla spesa pubblica, flessibilizzazione del mercato del lavoro e privatizzazioni di aziende pubbliche. Queste ultime, a partire dall’ingresso spagnolo nella CEE, furono in gran parte acquisite da multinazionali straniere. Ad esempio la Seat diventò parte del gruppo Volkswagen e il gruppo siderurgico Aceralia fu assorbito dalla lussemburghese Arcelor.
Questo processo di svendita fu proseguito negli anni successivi dai conservatori del Partido Popular, andando a toccare molte aziende importanti come Endesa, Casa, Iberia, Repsol, Telefónica. Tuttavia la crescita spagnola era rimasta abbastanza modesta per tutto questo periodo, dato anche il persistere di problemi strutturali come un’alta disoccupazione. L’integrazione europea, visti i rapporti di forza esistenti, aveva significato semplicemente una maggiore dipendenza dell’economia spagnola dal capitalismo europeo, a discapito di quello statunitense. Nondimeno il governo accelerò questo processo, sostenendo l’entrata nell’euro. Con la moneta unica avvenne una nuova espansione economica, grazie all’ulteriore aumento del turismo (terzo Paese al mondo per arrivi internazionali dopo Francia e Stati Uniti) e al fatto che centinaia di migliaia di cittadini nordeuropei (in particolare inglesi e tedeschi), tendenzialmente pensionati, avevano deciso di stabilirsi nei più ameni luoghi della Spagna. Entrambi i fattori diedero nuovo impulso al settore edile già tendenzialmente saturo.
A metà degli anni 2000 si vagheggiava ormai addirittura il sorpasso dell’Italia. Con la crisi globale del 2008 queste illusioni crollarono, insieme allo scoppio della bolla immobiliare che fece schizzare la disoccupazione alle stelle. Allo stesso tempo il Paese fu coinvolto nella crisi del debito sovrano, con la triplicazione del debito pubblico nell’arco di pochi anni. Questo ha portato l’Unione Europea a imporre misure di austerità che hanno impedito qualsiasi politica espansiva che potesse fronteggiare la crisi.
Nonostante dal 2014 gli investitori abbiano mostrato nuova fiducia nella Spagna del primo ministro Mariano Rajoy (PP), la disoccupazione continua a superare il 20%, il 36% dei bambini spagnoli è a rischio povertà, e le diseguaglianze economiche tra ricchi e poveri e tra regioni settentrionali e meridionali sono cresciute enormemente, causando gravi ripercussioni politiche, come l’ascesa dei social-populisti di Podemos e delle formazioni regionaliste.
In sintesi, nei quarant’anni trascorsi da quando la borghesia spagnola si è liberata della rigida sovrastruttura dittatoriale per aprirsi al libero mercato, all’aumento nominale della ricchezza non ha corrisposto un concreto progresso della giustizia sociale. Inoltre l’assorbimento del capitalismo nazionale spagnolo all’interno di quello europeo ha portato ad una devastante perdita di sovranità, non solo monetaria, ma anche produttiva, nel momento in cui le principali aziende sono in mano a privati spesso stranieri. È un esempio vicino, da tenere ben presente, di come spesso le promesse di libertà e democrazia per tutti, in bocca ai soliti noti, significhino potere e profitto per pochi.


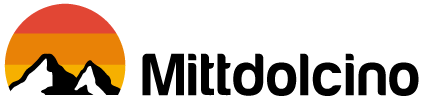




























Commenti recenti