Occhi verso Oriente: Trump, Iran e Gerusalemme
di L’INTELLETTUALE DISSIDENTE (Riccardo Antonucci)
Mancano pochi giorni all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e le ultime vicende nello Stretto di Hormuz sembrano incrinare i rapporti fra Washington e Teheran. Lo scontro effettivo, tuttavia, è fra pragmatismo e mentalità imprenditoriale, la quale non sempre si dimostra flessibile come la geopolitica richiede.
Il 2017 si presenta sin dall’inizio come un anno complesso, soprattutto dal punto di vista dellerelazioni internazionali: l’incognita rappresentata dalla presidenza di Donald Trump, prossima a divenire realtà il 20 gennaio, è solo il più ingombrante fra i tasselli che dovranno essere collocati nel grande mosaico della politica statunitense. A pesare sulle spalle del tycoon, infatti, è prima di tutto la laboriosità del mondo in cui dovrà operare, a partire dallo scacchiere del Medioriente. L’approccio delineato in campagna elettorale è stato fin troppo chiaro, ossia il riproporre una politica visibilmente muscolare, enunciata con parole forti e senza nascondersi dietro mezze misure: emblematica è la dichiarazione fatta nei confronti delle navi iraniane responsabili di infastidire la marina militare USA, contro cui a settembre Donald Trump si era espresso promettendo di aprire il fuoco.
Apparentemente, però, il nuovo anno sembra essere intenzionato a fornire una possibilità al presidente eletto: il 9 gennaio ha visto la pubblicazione sulle principali testate giornalistiche, americane e non solo, alcuni resoconti di un incontro fra il cacciatorpediniere statunitense USS Mahan e quattro navi d’attacco veloce iraniane, evento che avrebbe visto il vascello americano sparare tre colpi d’avvertimento contro le navi di Teheran. La motivazione del gesto, fornita all’agenzia di stampa britannica Reuters da due ufficiali statunitensi, sarebbe la mancata riduzione della velocità di navigazione, richiesta dagli americani attraverso il contatto radio e a cui i membri della flotta iraniana non hanno risposto. Prima dei colpi d’avvertimento, un elicottero della Marina Militare USA avrebbe lasciato cadere un fumogeno.
L’episodio si sarebbe svolto di domenica: le navi iraniane si sarebbero avvicinate entro 800 metri dal Mahan, il quale stava scortando altre due navi militari statunitensi. Al momento della vicenda e del successivo riferimento alla stampa, né il team di transizione di Trump né la Guardia della rivoluzione islamica iraniana erano disponibili per un commento a riguardo. Il punto in cui è avvenuto il fatto si trova vicino allo Stretto di Hormuz, che rappresenta uno dei principali canali delle rotte petrolifere provenienti dal Medioriente e dirette verso Stati Uniti ed Estremo Oriente – Cina in particolare –. Si trova fra il Golfo dell’Oman e il Golfo Persico ed è l’unico canale d’accesso dal Golfo Persico all’oceano. Esso è il punto di passaggio di circa un terzo del traffico petrolifero via mare. In tempi di crisi diplomatica ne è stata minacciata più volte la chiusura da parte di Teheran.
Probabilmente si è trattato di una vicenda non destinata a creare un nuovo clima di diffidenza fra le due nazioni, eppure negli ultimi tempi il Golfo sembra essere teatro di numerosi incidenti fra le due marine militari: il 29 novembre 2016 viene pubblicata la dichiarazione di ufficiali del Pentagono riguardo il puntamento contro una nave militare statunitense da parte di un’imbarcazione iraniana, sempre nello Stretto di Hormuz. Gli ufficiali fanno notare che l’incidente sia avvenuto in acque internazionali; nel luglio 2016 la USS New Orleans e la USS Stout, impiegata nella scorta della prima imbarcazione, vennero raggiunte da numerose navi iraniane che hanno poi filmato l’equipaggio; nel gennaio 2016 sono stati presi in custodia 10 marinai dopo che la loro nave ebbe attraversato le acque iraniane – fatto giustificato dal Pentagono come dovuto ad un malfunzionamento –.
Non è dunque una novità che avvengano incontri piuttosto tesi fra le due Marine Militari, eppure solo raramente si è raggiunto il punto del fuoco d’avvertimento, come ci ricorda Al Jazeera. Forse è da supporre che gli ultimi eventi indichino la presenza di un malumore più forte del solito e, infondo, risulterebbe anche comprensibile: la fine della presidenza Obama, fautrice del Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), rappresenta un cambio importante all’interno del sistema politico americano e della strategia che il Paese vorrà adoperare in Medioriente. I reparti militari USA, d’altra parte, sono stretti dalla pressione di dover portare avanti una transizione molto complessa anche a causa dell’impreparazione di Donald Trump, che ha confermato, a seguito dei suoi incontri con i vertici delle Forze armate e dell’Intelligence, di avere difficoltà non indifferenti riguardo i dossier strategici. Determinando di fatto, a partire dalla Guerra Fredda, la politica estera americana, il Pentagono ha bisogno di una figura presidenziale capace di comprendere le dinamiche belliche quanto basta per poterlo indirizzare verso una strategia coesa, cosa che Trump dovrà dimostrare di saper fare. Per avere successo nel compito sarà necessario ristabilire un maggiore equilibrio fra il Pentagono ed il segretario di Stato, figura cardine nella gestione degli affari internazionali soprattutto grazie alle capacità analitiche del corpo diplomatico, ineguagliate da qualsiasi altra agenzia governativa e determinanti per aiutare il neopresidente nel suo compito – per il quale sembra avere una visione fin troppo semplicistica, soprattutto per quanto riguarda il Medioriente –.
Il ruolo di Rex Tillerson, dunque, risulterà determinante, sia perché rispecchia il ritratto di un tecnico competente e dalla forte personalità, sia perché da ex CEO di ExxonMobil conosce le dinamiche del mercato petrolifero nelle stesse regioni in cui gli Stati Uniti continuano ad investire gran parte delle loro energie e budget. Oltretutto, fra Tillerson e l’Iran esiste già un legame molto forte: fra il 2003 ed il 2005, durante il periodo delle sanzioni, la Exxon ha fatto affari con l’Iran, la Siria ed il Sudan attraverso una società sussidiaria europea, la Infineum – joint venture fra Exxon e Shell –, di cui la compagnia americana deteneva il 50%. All’epoca Tillerson era presidente e direttore dell’azienda, prima di divenire CEO nel 2006. La notizia è stata riportata il 10 gennaio 2017 da USA Today, citando dati della Securities and Exchange Commission. In quei tre anni la Exxon guadagnò 53.2milioni di dollari di vendite dall’Iran, 600mila dollari dal Sudan e 1.1milioni di dollari dalla Siria, soldi che la società ha dichiarato derivare da attività legali, in quanto Infineum agirebbe come un’entità indipendente dalla compagnia statunitense, come affermato dal media manager di Exxon Alan Jeffers.
Indubbiamente, dunque, i legami fra gli Stati Uniti e l’Iran non sono destinati a crollare di colpo, anche per via della complessa battaglia per le concessioni petrolifere che vedrà Tillerson lottare contro la Cina, particolarmente legata al Governo di Teheran. A giocare un ruolo determinante nel rapporto fra le due nazioni sarà la componente conservatrice della classe dirigente iraniana, che con la morte dell’Ayatollah Rafsanjani, avvenuta l’8 gennaio di quest’anno, vede rafforzata la propria influenza sugli equilibri politici interni. La conferma di Rouhani alle elezioni politiche è sempre più incerta, ma a giudicare da quanto scritto da Nicola Pedde per il volume di Limes “L’agenda Trump” ciò non dovrebbe rappresentare un problema: la stessa ala conservatrice era quella che guardava di buon auspicio all’elezione di Trump, visto come un’occasione per portare avanti gli accordi economici a velocità contenuta, scongiurando dunque una spinta sul processo avviato da Obama. Il rischio che Teheran teme di più è l’apertura troppo repentina della propria economia, ancora bisognosa di interventi strutturali e legislativi per poter reggere il confronto con l’Occidente. Per questo il programma di Trump, seppure piuttosto incerto sulla questione e critico nei confronti dell’accordo, risultava più gradito delle certezze offerte da Hillary Clinton. Naturalmente la loro visione è basata sul postulato che l’accordo, nonostante non subirà un’accelerazione, rimarrà in vigore.
Ora che la presidenza Trump sta per divenire realtà, i conservatori iraniani proveranno ad imporre la propria linea sulla questione del Jcpoa, su cui probabilmente troveranno Trump bendisposto. A determinare la crisi fra i due Paesi, al contrario, non sarà con tutta probabilità un’escalation militare ma una questione ancor più complessa: Israele. La presidenza di Barack Obama ha dimostrato col tempo di non vedere più Tel Aviv come una priorità della politica estera USA in Medioriente: il mancato sostegno a Netanyahu sulla questione degli insediamenti coloniali in terra palestinese è solo l’ultimo di una serie di episodi – fra cui lo stesso Jcpoa, concordato con l’Iran anche a scapito del legame fra Stati Uniti ed Israele – che segnano un progressivo distacco fra i due Paesi. Le ragioni, oltretutto, sono evidenti: se l’Iran è un mercato in fase di consolidamento, oltre ad essere una nazione sostanzialmente stabile, Israele è ormai in uno stato di caos alimentato anche dalla coalizione di Governo, ostaggio dei diktat dell’estrema destra religiosa, la stessa destra a cui Trump sembra voler dare credito. La battaglia per spostare la sede dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme non è mai stata abbandonata dal tycoon, che proprio pochi giorni dopo l’astensione degli USA nei confronti della risoluzione ONU contro gli insediamenti israeliani nei territori occupati palestinesi ha scritto:
«Non possiamo continuare a lasciare che Israele sia trattato con un tale sdegno e disprezzo. Una volta erano grandi amici degli Stati Uniti, ma ora non più. L’inizio della fine è stato l’orribile accordo sul nucleare iraniano, e ora questo (l’ONU)! Sii forte, Israele, il 20 gennaio arriverà presto!»
Il principale rischio di una simile dichiarazione è la mentalità imprenditoriale di Donald Trump, abituata a ragionare in termini di “guadagno” e “perdita”, discostandosi dalla mentalità politica che include, nella stessa decisione, bene e male, perdite e guadagni. Come ha scritto Moderchai Kedar, il pericolo principale è che Trump spinga Netanyahu ad agire per trovare un accordo con i suoi vicini arabi, minacciando di intervenire in prima persona in caso di insuccesso. Una simile prospettiva, però, è resa ancor più complessa da due dettagli fondamentali: il peso politico dell’estrema destra israeliana, la quale rallenterebbe qualsiasi processo di negoziazione con le nazioni arabe e che detiene la possibilità di rovesciare il Governo qualora Netanyahu provasse ad agire autonomamente; gli scandali in cui il Primo Ministro è coinvolto, che proprio in questo momento sembrano segnare un punto di svolta.
La vicenda più seria in cui è coinvolto il politico israeliano è il tentato accordo con proprietario del giornale Yediot Haronot, Arnon Mozes: in cambio di un alleggerimento dei toni critici nei confronti del Governo, Netanyahu avrebbe offerto un sostegno al giornale per migliorare la propria posizione nel mercato della stampa. Non si tratta, però, dell’unica vicenda in cui il leader politico e la sua famiglia sono coinvolti. L’accumularsi di questi scandali lo espone sempre più alla possibilità di finire sotto processo, considerando anche che lo stesso procuratore generale, alleato del Primo Ministro, non ha potuto evitare una formale investigazione della Polizia nei suoi confronti in queste ultime settimane. Sebbene si tratti di un leader fragile, Netanyahu è attualmente l’unico interlocutore su cui Trump può fare affidamento in Israele, e le sorti del suo Governo inficeranno pesantemente sul rapporto fra Washington e Teheran, il quale sarebbe il primo attore a mobilitarsi contro lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme – che in base ad accordi internazionali costituisce una dichiarazione di sovranità illegittima –. Il 12 dicembre 2016, il ministro della Difesa iraniano Hossein Dehghan ha dichiarato che una guerra fra Iran ed USA avrebbe comportato la distruzione di Israele. Forse la scelta migliore, almeno per il momento, è quella di posticipare qualsiasi questione relativa a Gerusalemme a quando il Governo israeliano avrà risolto le vicende giudiziarie del proprio capo, mantenendo un basso profilo con la controparte iraniana fino a quando non sarà più chiaro cosa aspettarsi da Tel Aviv. Ciò che è chiaro, ad ogni modo, è che le sorti dei due Paesi mediorientali siano ancora una volta – e forse anche più di prima – indissolubilmente legate.
Fonte: http://www.lintellettualedissidente.it/esteri-3/locchio-verso-oriente-trump-iran-e-gerusalemme/


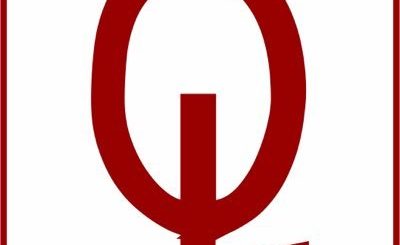




























Commenti recenti