I sauditi hanno l’atomica?
di CRITICA SCIENTIFICA (Giacomo Gabellini)

Forse l’Arabia Saudita ha già acquistato ordigni nucleari dal Pakistan.
Mentre l’attenzione del mondo viene tenuta puntata verso il programma nucleare iraniano altri soggetti, nell’indifferenza generale, sono già in possesso di armi nucleari.
Israele dispone di un arsenale imponente mentre l’Arabia Saudita sembra aggiungersi adesso al club. Equilibrio del terrore o pericolosa miccia?
Di Giacomo Gabellini
Attualmente, il ‘klan’ degli Stati dotati di armi atomiche riunisce Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Nord, Pakistan e India. Israele, non avendo mai ammesso di possedere un arsenale nucleare e non avendo sottoscritto il Trattato di Non Proliferazione (Tnp), non rientra ufficialmente in questo gruppo. Nel 1986, tuttavia, il tecnico israeliano Mordechai Vanunu – poi rapito a roma da un commando del Mossad e internato nelle carceri israeliane – rivelò al ‘Sunday Times’ che il suo Paese era riuscito a dotarsi fino a quel momento a dotarsi di 200 bombe atomiche grazie alle informazioni segrete passate a Tel Aviv dalla spia della Marina Usa Jonathan Pollard – liberato nel luglio 2015 dopo trent’anni di galera – e alla collaborazione con gli esperti francesi e con il Sud Africa dell’apartheid – è del 1979 l’incidente Vela, al largo delle coste sudafricane, che alcuni esperti considerano il primo test nucleare israeliano.
Dodici anni prima (1967), gli stessi Stati Uniti avevano fornito all’Iran dello Shah Reza Pahlevi i primi 5 reattori nucleari. Nel 1970, lo Shah decise di aderire al Tnp dietro sollecitazione di Henry Kissinger, il quale si era fatto promotore di un partenariato nucleare con Teheran i cui termini definitivi vennero fissati nel 1975, con la ratifica di un accordo sottoscritto da entrambe le parti. In quella specifica fase, Iran e Israele erano gli unici paesi del Medio Oriente a sposare la causa statunitense ed ottennero sostanziosi aiuti economici oltre a forte sostegno politico affinché si imponessero – la Persia in particolare, in virtù della sua posizione geografica strategicamente fondamentale – a bastioni dello schieramento occidentale contro le mire egemoniche sovietiche sul Golfo Persico e sull’Asia centrale. La fuga dello Shah in seguito alla Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Ruollah Khomeini scompaginò i rapporti diplomatici tessuti negli anni precedenti, alla luce della spiccata ostilità nei confronti degli Stati Uniti mostrata fin dai primi istanti dal leader spirituale iraniano.
Khomeini bloccò subito il progetto dichiarando il possesso dell’arma atomica rappresentava un oltraggio ai precetti dell’Islam. Di conseguenza, i vincoli dell’accordo con gli Stati Uniti decaddero e il programma nucleare iraniano subì una brusca battuta d’arresto. L’Iran deteneva però alcune barre di uranio scarsamente arricchite e il timore che un successore di Khomeini riattivasse lo sviluppo del programma nucleare stimolò l’azione degli occidentali, specialmente in seguito (2002) alla diffusione dei dettagli relativi all’impianto nucleare di Arak da parte del Consiglio Nazionale della Resistenza, un gruppo d’opposizione con sede a Parigi. Nel febbraio del 2003, il presidente Mohammad Khatami riconobbe l’esistenza dell’impianto di Natanz e accettò la richiesta dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) di ispezionare il sito. Quattro mesi dopo, gli ingegneri dell’Aiea consegnarono il proprio rapporto in cui si sosteneva che l’Iran non aveva rispettato tutti gli obblighi previsti dal Tnp. Gran Bretagna, Germania e Francia (Ue-3) lanciarono allora un’iniziativa diplomatica per accertarsi che il programma nucleare iraniano seguisse le norme fissate dal Tnp e spingere allo stesso tempo nell’angolo le posizioni più oltranziste assunte dai neocon inseriti nell’Amministrazione Bush. Dal 2003 al 2005, il ruolo di capo-negoziatore della delegazione iraniana incaricata di trattare con il gruppo Ue-3 fu ricoperto da Hassan Rohani, un religioso vicino al presidente Khatami e al ricchissimo ex capo di Stato Ali Akbari Rafsanjani.
L’approccio conciliante, quasi passivo, tenuto da Rohani spinse gli europei a mettere sul tavolo richieste molto impegnative, quali l’abbandono totale del programma nucleare – anche di quello civile, contemplato da Tnp – e lo smantellamento delle filiere d’insegnamento di fisica nucleare come prova inequivocabile della buona fede di Teheran. L’elezione, nell’agosto del 2005, di Mahmoud Ahmadinejad – laico sostenitore del rilancio della Rivoluzione khomeinista – cambiò radicalmente i rapporti di forza. Il nuovo presidente respinse immediatamente l’accordo negoziato da Rohani, diede nuova linfa a materie ‘scottanti’ come la fisica nucleare giungendo ad incaricare gli scienziati iraniani di mettere a punto un programma di ricerca finalizzato a sviluppare un processo di produzione di elettricità a partire dalla fusione e non dalla fissione.
Israele, che rifiuta – a differenza dell’Iran – di partecipare alla Conferenza per la creazione in Medio Oriente di una zona libera da armi nucleari, cominciò quindi ad esercitare forti pressioni sugli Usa e sui Paesi sunniti per dar vita a un fronte comune contro la minaccia iraniana. Una minaccia che le monarchie sunnite del Golfo Persico ritennero superiore a quella rappresentata dal poderoso arsenale di cui dispone Israele. Non aderendo al Tnp né alla Convenzione che proibisce lo sviluppo di armi biologiche, Israele è riuscito a mettere insieme circa 300 testate nucleari e relativi vettori di lancio, come missili balistici e cacciabombardieri. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Israele ha prodotto qualcosa come 950 kg di plutonio, e continua a produrne in quantità sufficiente da fabbricare ogni anno diverse testate atomiche di potenza analoga a quella lanciata su Nagasaki.
Produce anche trizio, gas radioattivo con cui si ricavano le testate neutroniche, che provocano minore contaminazione radioattiva ma più alta letalità. Stando a quanto riportato dal quotidiano israeliano ‘Haaretz’, armi biologiche e chimiche vengono sviluppate ogni anno presso l’Istituto per la ricerca biologica di Ness-Ziona. I resoconti più accreditati indicano che, a livello ufficiale, «fanno parte dello staff 160 scienziati e 170 tecnici, che da cinque decenni compiono ricerche di biologia, chimica, biochimica, biotecnologia, farmacologia, fisica e altre discipline scientifiche. La massima segretezza copre la ricerca sulle armi biologiche: batteri e virus che, disseminati nel Paese nemico, possono scatenare epidemie. Tra questi il batterio della peste bubbonica (la ‘morte nera’ del Medioevo) e il Virus Ebola […]. Vi sono anche seri indizi su ricerche per lo sviluppo di armi biologiche in grado di annientare nell’uomo il sistema immunitario».
La necessità di mantenere questo primato tecnologico e militare rispetto a tutti gli altri Paese del Medio Oriente spinse quindi il governo di Tel Aviv ad affiancare operazioni militari alle iniziative diplomatiche, incaricando il Mossad di sabotare il programma nucleare iraniano. Sotto la direzione di Meir Dagan, uno dei principali oppositori all’opzione militare auspicata da parecchi esponenti politici israeliani (Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Liebermann su tutti), il Mossad predispose e mise in pratica il ‘Decapitation Programme’, un’operazione volta ad abbattere con la forza il programma nucleare iraniano. Nell’ambito di questa operazione rientrano le fughe di gas tossici, le esplosioni scatenate da materiali difettosi e gli agguati di vario genere che, nel corso degli anni, hanno provocato la morte dei fisici ed ingegneri iraniani Ali Mahmoudi Mimand, Daryoush Rezaie, Majid Shahriari, Hassan Moghaddam, Abbassi Davani e Mustafa Ahmadi-Roshan. Senza dimenticare che nell’agosto 2008 un aereo decollato da Biskek, in Kirghizistan, e diretto a Teheran si schiantò al suolo causando la morte di altri 44 scienziati iraniani.
Nel 2013, quando Ahmadinejad si apprestava a concludere i suoi due mandati presidenziali, la Guida Suprema Ali Khamenei accettò di incontrarsi con emissari statunitensi in Oman per discutere le modalità di uscita dalla situazione di stallo venutasi a creare. Khamenei era conscio che le sanzioni e i piani di sabotaggio orditi da Israele, pur non riuscendo a piegare la Repubblica Islamica, avevano comunque messo a dura prova la capacità di resistenza del popolo iraniano, e ritenne quindi necessario prendere in considerazione la possibilità di raggiungere un accordo che sancisse la revoca delle sanzioni garantendo allo stesso tempo il rispetto del diritto iraniano di portare avanti un programma nucleare a scopi civili.
Secondo il sempre ben informato Thierry Meyssan, Khamenei accettò di impedire che il presidente uscente si ripresentasse alle elezioni del 2013 e di appoggiare la candidatura di Hassan Rohani, il capo-negoziatore iraniano rimosso dall’incarico nel 2005 per volere di Ahmadinejad. L’elezione di Rohani determinò, come era ampiamente prevedibile, la ripresa delle trattative interrotte nel 2005 e la successiva accettazione, da parte di Teheran, del divieto di arricchire l’uranio al 20% nell’ambito del cosiddetto ‘Accordo 5+1’. Il che ha di fatto minato alle fondamenta le ricerche sulla fusione avviate da Ahmadinejad.
Il che ha spinto i khomeinisti, i nazionalisti e i Pasdaran a contestare duramente l’intesa tra Washington e Teheran, nel timore che la nota vicinanza del presidente Obama con la figura di Zbigniew Brzezinski, il noto stratega ferocemente nemico della Russia fin da prima di ricoprire l’incarico di Consigliere per la Sicurezza Nazionale sotto il presidente Carter, indichi il ripristino di una particolare strategia anti-russa e anti-cinese che vincolerebbe l’Iran a tornare a svolgere il ruolo ricoperto fino all’avvento della rivoluzione khomeinista. Secondo questa valutazione, Brzezinski sarebbe disposto persino ad inimicarsi la potente ‘Israel Lobby’ pur di creare le condizioni strategiche ideali ad assicurare l’indebolimento di Mosca e Pechino, che implicherebbero il completo reintegro dell’Iran nella ‘comunità internazionale’. Non a caso, nel 2009, Brzezinski aveva dichiarato che a suo parere Obama avrebbe dovuto mettere immediatamente in chiaro con Tel Aviv che qualora i caccia israeliani si fossero alzati in volo per bombardare i siti iraniani le forze statunitensi allora dislocate in Iraq li avrebbero abbattuti senza indugio. «nessuno lo desidera, ma si potrebbe verificare un ‘caso Liberty al contrario’», ammonì allora Brzezinski. Il riferimento è a una delle pagine più oscure della marina statunitense che ben delinea i contorni del peculiare rapporto che intercorre tra Washington e Tel Aviv.
Durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, la nave di ricerche tecniche Uss Liberty che incrociava nel mediterraneo venne attaccata da diversi Mirage-3 israeliani e da una motovedetta senza bandiera. Non è chiaro se l’obiettivo era quello di eliminare l’equipaggio della nave, reo di aver assistito a qualche crimine di guerra perpetrato dall’esercito israeliano, o di spingere gli Stati Uniti ad entrare nel conflitto con un attacco sotto falsa bandiera (‘false flag’). Stupisce comunque che nonostante i 34 morti e 172 feriti causati dall’aggressione israeliana, il presidente Lyndon Johnson abbia ordinato alle forze navali statunitensi di non rispondere al fuoco. Così, quando parla di ‘caso Liberty al contrario’, Brzezinski non si limita ad intimare agli israeliani di guardarsi dal muovere le proprie pedine contro Teheran, ma prende automaticamente le distanze dalla tradizione palesemente filo-israeliana dell’apparato militare Usa per concentrare gli sforzi nella creazione di un altro tipo di scenario, ovvero quello di un’Asia in cui il ritiro strategico statunitense venga compensato con una buona dose di caos finalizzato a mettere i principali attori eurasiatici uno contro l’altro. Nello scenario prefigurato dallo stratega polacco-statunitense, l’Iran dovrebbe quindi trasformarsi in un solido alleato degli Stati Uniti – come era all’epoca dello Shah – ed ottenere eventualmente il nulla osta a dotarsi di un arsenale nucleare andando a chiudere il cerchio atomico areale (i suoi vicini israeliano, russo, cinese, pakistano, indiano e anche turco, visto che Ankara permane sotto l’ombrello strategico Usa, dispongono tutti della bomba atomica) che fornisca a Teheran la deterrenza necessaria a consolidare la propria sicurezza nazionale e che controbilanci il vecchio alleato pakistano, che negli ultimi tempi tende sempre più a fungere da catalizzatore del ‘complesso sino-islamico’ prefigurato da Samuel Huntington, il teorizzatore dello ‘scontro delle civilità’.
L’accordo ha quindi mitigato notevolmente l’ostilità occidentale nei confronti dell’Iran ed accresciuto le capacità della Repubblica Islamica di influenzare le dinamiche geopolitiche regionali. L’Iran, che non essendo un Paese arabo, rappresenta il naturale polo d’attrazione per la popolazione sciita disseminata in Iraq, Bahrein, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen e nazioni dell’Asia centrale e ciò permette alla Repubblica Islamica di imporsi quale attore regionale di primo livello, di cui il wahhabismo saudita rappresenta l’antitesi. Il che ha indotto Riad a discutere in sede di Consiglio di Cooperazione del Golfo (che riunisce anche Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait ed Oman) la strategia comune da adottare al fine di contrastare efficacemente le la crescente influenza iraniana sul Medio Oriente. Successivamente, i sauditi hanno deciso di intensificare il programma di acquisto di armamenti statunitensi. Nel solo 2014, Riad ha comprato armi per ben 6,4 miliardi; una cifra superiore a quella spesa complessivamente da tutta l’Europa occidentale che ha permesso all’Arabia Saudita di scavalcare l’India nella graduatoria dei maggiori acquirenti mondiali di armi.
Il 25 marzo 2015, l’Arabia Saudita ha sferrato un durissimo attacco allo Yemen per re-insediare il presidente rovesciato dalla rivolta scatenata dal gruppo filo-sciita degli Houthi dopo aver firmato, di concerto con i rappresentanti di Bahrain ed Emirati Arabi Uniti, accordi con gli Stati Uniti per la fornitura di tecnologie nucleari e materiale fissile, di cui Riad e le altre monarchie del Golfo Persico si sarebbero ovviamente potute servire per costruire armi nucleari in un futuro non troppo remoto. L’ex funzionario dell’intelligence militare israeliana Amos Yadlin aveva già rivelato l’intenzione saudita di dotarsi di un arsenale nucleare, rivelando alla ‘Bbc’ che Riad aveva da tempo pagato il Pakistan per ottenere una bomba.
La stessa Arabia Saudita ha poi ammesso di aver attivato i propri canali per acquistare armi nucleari, e tutti gli esperti hanno nuovamente individuato nel Pakistan il venditore più probabile, alla luce del fatto che il programma nucleare di Islamabad è stato finanziato per oltre il 60% da Riad. Sospetti sulle reali intenzioni di Riad riguardo al nucleare erano emersi negli anni ’90, in seguito alle accuse lanciate dall’ex funzionario dell’ambasciata saudita presso le Nazioni Unite a New York Mohammed al-Khilewi, il quale, dopo aver ottenuto asilo politico dagli Stati Uniti, parlò di un programma nucleare a scopi militari avviato dal suo Paese nel 1975 e interrotto per l’insufficiente padronanza della materia da parte degli scienziati sauditi. Il che avrebbe indotto Riad ad appoggiarsi ai più esperti tecnici alle dipendenze di Islamabad guidati da Abdul Qadeer Khan, che dopo aver fornito il maggior contributo a realizzare la bomba atomica pakistana mise in piedi una rete internazionale di traffico di tecnologia nucleare di cui si sarebbe servita, tra gli altri, la Corea del Nord per ottenere gas centrifugato ed esafluoruro di uranio.
Lo scorso 19 febbraio, l’influente analista politico saudita Daham al-Anzi ha infine dichiarato all’emittente in lingua araba di ‘Russia Today’ che il suo Paese possiede la bomba atomica da almeno due anni e che i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono al corrente di tutto ciò. L’esternazione ha avuto una grande ed immediata eco in tutto il mondo arabo, persiano ed israeliano, ma una risonanza pressoché nulla in Europa e negli Stati Uniti. Eppure, c’erano già state numerose avvisaglie in questo senso. Nel marzo 2015, durante un’intervista rilasciata alla ‘Cnn’, l’ambasciatore saudita negli Stati Uniti Adel al-Jubeir aveva maldestramente eluso una domanda del suo interlocutore che gli chiedeva delucidazioni riguardo il programma nucleare di Riad. Quattro mesi dopo, l’esperto di intelligence Duane Clarridge aveva dato per conclusa la vendita di almeno una bomba atomica ai sauditi da parte del Pakistan in diretta sul canale ‘Fox’. Di fronte a queste esternazioni, il segretario di Stato John Kerry ha cercato di rassicurare i cittadini statunitensi illustrando le difficoltà che comporta il trasferimento di un ordigno nucleare da un Paese all’altro e annunciando pesanti conseguenze per l’Arabia Saudita nel caso venisse appurata una così grave violazione del Tnp, cui Riad aderisce dal 1988.
Ciononostante, le ammissioni di un uomo addentro all’establishment saudita come al-Anzi – molto vicino a re Salman – non hanno avuto alcun seguito. Il che suggerisce che gli Usa, alleati dei sauditi dal 1945, fossero stati informati da Riad di cosa stesse bollendo in pentola e abbiano lasciato fare per poi mettere gli altri Paesi di fronte al fatto compiuto. L’equilibrio di forze in Medio Oriente è del resto sempre stato l’obiettivo cardine degli Stati Uniti, conformemente al quale Washington istigò l’Iraq di Saddam Hussein ad aggredire l’Iran rivoluzionario foraggiando poi entrambi gli schieramenti affinché nessuno dei due sopraffacesse l’altro. Lo ha spiegato con disarmante disinvoltura George Friedman, direttore dell’agenzia di intelligence ‘Stratfor’.
Fonte: http://www.enzopennetta.it/2018/02/i-sauditi-hanno-latomica/



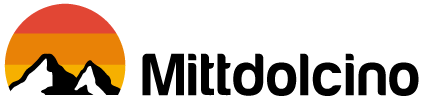




























Commenti recenti