Informate Grillo: il lavoro non è finito!
di LA CITTA’ FUTURA (Carmine Tomeo)
La fine del lavoro è assunta come presupposto (indimostrato) della necessità del reddito di cittadinanza. Ma il lavoro non è finito ed il reddito di cittadinanza non risolverà i suoi problemi.
In un articolo dello scorso 15 febbraio pubblicato sul suo blog [1], Beppe Grillo si lancia nell’ipotesi della fine del lavoro per affermare, in conclusione, la necessità di istituire un reddito di cittadinanza. Il comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle prende spunto da Rifkin, economista americano che affermava, appunto, la fine del lavoro (che diede il titolo al suo celebre libro), con l’ipotesi che lo sviluppo della capacità produttiva avrebbe lasciato nella disoccupazione masse crescenti di lavoratori. “Se non c’è lavoro, non c’è consumo, non c’è produzione, non c’è la nostra società”, scrive Grillo e perciò “Dobbiamo superare questa visione, il lavoro di massa è finito, volge al termine”. Di qui il motivo per cui “dobbiamo immaginare un altro mondo, in cui esiste un reddito slegato dal lavoro”. La soluzione sarebbe, allora, il reddito di cittadinanza. In un post successivo del 14 marzo [2], il fondatore del Movimento 5 stelle torna sul tema. Questa volta la base di partenza è La società senza lavoro di Dominique Méda. Le conclusioni, però, sono le stesse: la soluzione è il reddito di cittadinanza. Emerge, in Grillo, una visione centrata su questa parte del mondo, quella a capitalismo più maturo e che non tiene conto della divisione internazionale del lavoro, che invece bisognerebbe tenere presente parlando di fine del lavoro e (connessa a questo) di reddito di cittadinanza.
È evidente la possibilità di fare a meno di una certa quantità di forza lavoro con l’avanzare della tecnologia e della conseguente produttività. Non bisogna, però, dimenticare che questo processo di sviluppo non è affatto neutrale, come spesso viene presentato e come lo stesso Grillo lo rappresenta, ma attiene all’uso capitalistico che viene fatto della tecnologia. Del resto, è una lettura che si può ricavare anche dal McKinsey Global Institute (non certo tacciabile di simpatie marxiste), che in uno studio del 2012 ammette che, nelle economie avanzate, spesso l’adozione di tecnologie ha lo scopo di risparmiare lavoro quale risposta al rallentamento della crescita della forza lavoro e all’aumento della concorrenza globale [3]. Così, “dal 1977 al 2007, l’occupazione manifatturiera nelle economie avanzate è diminuita di 20 milioni di unità, con le maggiori perdite in termini di manodopera nei settori ad alta intensità di mano d’opera come il tessile, la pelle, le calzature e i prodotti in legno”. Emblematico l’esempio della Germania, che nonostante sia tra i maggiori esportatori mondiali di manufatti, la sua “occupazione manifatturiera totale ha subito una contrazione di oltre il 25%”.
Eppure, lo stesso McKinsey sostiene che dal 1980 al 2010, il numero di lavoratori nel mondo è aumentato da 1,2 miliardi a circa 2,9 miliardi e che entro il 2030 raggiungerà i 3,5 miliardi. A questo dato è bene aggiungere un altro, importante aspetto. A vedere la classifica delle più grandi società del mondo per ricavi e profitti [4], si nota che le prime dieci sono tutte società che impiegano un gran numero di lavoratori, che fanno parte del settore manifatturiero (automobilistico, ad esempio) o che non esisterebbero senza la manifattura (vedi Walmart che conta 11.000 negozi fisici o il settore petrolifero) ed occupano da sole (è bene ripeterlo: 10 società) oltre 7 milioni di lavoratori. È vero che, come rileva l’International Labour Organization (Ilo), si prevede che la quota dell’occupazione manifatturiera continui a diminuire nei paesi a reddito medio-alto e in paesi sviluppati, e che cresca solo marginalmente in quelli a medio reddito inferiore [5]. Ma la crescita solo marginale dei lavoratori impiegati nella manifattura nei paesi in via di sviluppo non sembra poter rappresentare una tendenza, dal momento che i cambiamenti che sono stati portati nell’uso della tecnologia e nella divisione internazionale del lavoro nei mercati e nei settori produttivi hanno avuto il non trascurabile risultato di un aumento di 900 milioni di posti di lavoro nel settore non agricolo nei paesi in via di sviluppo. Nel frattempo – e dal nostro punto di vista pare quasi un’ammissione di colpa da parte dei sostenitori dell’attuale modo di produzione capitalistico – “le economie avanzate sono state in grado di aumentare la produttività investendo nella tecnologia e sfruttando nuove fonti di manodopera a basso costo, creando al contempo nuovi lavori ad alto salario per lavoratori altamente qualificati” [6].
Insomma, allargando un po’ la visuale, si osserva che la tecnologia non determina di per sé la fine del lavoro. In sostanza, riprendendo Marx, “la macchina non libera dal lavoro l’operaio” ed anzi si può arrivare facilmente al “paradosso economico che il mezzo più potente per l’accorciamento del tempo di lavoro si trasforma nel mezzo più infallibile per trasformare tutto il tempo della vita del lavoratore e della sua famiglia in tempo di lavoro disponibile per la valorizzazione del capitale” [7]. E ciò avviene attraverso la crescita del comando del capitale sul lavoro, ad esempio attraverso la precarizzazione di masse crescenti di lavoratori, la condensazione dei cicli produttivi, l’intensificazione dei ritmi di produzione, l’estensione dell’impiego di mano d’opera povera e a basso costo, quest’ultima specie nei paesi in via di sviluppo. Seppure viviamo anche sulla nostra pelle la svalorizzazione del lavoro nel mondo sviluppato, la stessa ci appare lontana, a volte invisibile, se parliamo del lavoro nei paesi in via di sviluppo. Eppure lì si concentrano 1,4 miliardi di lavoratori occupati in lavori vulnerabili ed in condizioni di povertà estrema o moderata, vale a dire con reddito o consumo pro capite inferiore ai 3,1 dollari statunitensi al giorno [8]. Questa enorme crescita di manodopera a basso costo a scapito del settore agricolo (facendo arrivare al 70% i posti di lavoro non agricoli sul totale dell’occupazione nel 2010, dal 54% di trent’anni prima), ha portato – afferma McKinsey – le economie in via di sviluppo a diventare “i maggiori fornitori mondiali di lavoro di bassa qualità”, contribuendo “a soddisfare anche la domanda proveniente dall’economia globale” [9].
McKinsey non la dice con l’asprezza che servirebbe, ma dovrebbe essere chiaro cosa questo significhi: le merci a basso costo che devono essere vendute anche da questa parte del mondo (“per soddisfare i bisogni dell’uomo”, afferma Grillo in un suo post già citato, inconsapevole del vero scopo della produzione capitalistica e cioè l’accumulazione), dove pure la svalorizzazione del lavoro prosegue senza soluzione di continuità da più di trent’anni, sono prodotte da manodopera scarsamente qualificata e sottopagata nelle fabbriche dei paesi in via di sviluppo. A questo punto del discorso occorre inserire il reddito di cittadinanza, considerato come reddito sganciato dal lavoro, soluzione – dice Grillo – per “immaginare un altro mondo”.
Ora, però, si pongono almeno due ordini di problemi.
Il primo riguarda la possibilità di percepire un reddito sganciato dal lavoro, che non sia solo un’integrazione al salario. Questa possibilità può essere garantita solo se intanto i lavoratori dei paesi più poveri producono per noi. Lo sintetizza bene Giovanna Vertova, docente dell’Università di Bergamo: “Assumendo la teoria marxiana del valore, secondo la quale si può distribuire solo quello che è stato prodotto […] se la classe lavoratrice dei paesi ricchi può permettersi di vivere senza lavorare (o, almeno, di fare questa scelta), chi produrrà la ricchezza da distribuire? La classe lavoratrice dei paesi poveri. […] La classe lavoratrice dei paesi avanzati può permettersi di vivere senza lavorare perché, per loro, lavora la classe lavoratrice dei paesi poveri”. Una condizione che, inevitabilmente, “produce una frammentazione, a livello globale, della classe lavoratrice” [10].
Ora, se i rapporti di forza entro i dati rapporti sociali di produzione non permettono alla classe lavoratrice di drenare la ricchezza dai profitti ai salari, invertendo una tendenza più che trentennale, “I capitalisti hanno tutto l’interesse a ridurre i salari– sostiene ancora, giustamente, Giovanna Vertova – visto che la classe lavoratrice percepisce già una forma di reddito”. Un effetto perverso che, evidentemente, anziché produrre una distribuzione più equa tra profitti e salari, tende ad aumentare le diseguaglianze spostando ancora quote di salario verso il profitto, senza che la realizzazione dello stesso attraverso il consumo venga compromessa, in quanto il minor salario sarebbe compensato dal reddito di cittadinanza. E ciò, quindi, anche in una forma di reddito di cittadinanza più modestamente concepita come integrazione del reddito. Così, come “la macchina non libera dal lavoro l’operaio”, non lo fa nemmeno il reddito di cittadinanza, che si troverebbe ad essere un mezzo per consentire non la liberazione dal lavoro, non la liberazione dallo sfruttamento, ma una più prosaica libertà – limitata – di consumo.
E qui veniamo al secondo ordine di problema.
La libertà diventa libertà di consumare, e da lavoratori nel processo capitalistico di produzione si passa ad essere consumatori di una merce, considerata solo nel suo valore d’uso senza accorgersi che rimosso quel velo “rimane loro soltanto una qualità, quella di essere prodotti del lavoro” [11]. Ma se si rimuove questo carattere della merce (quello di essere un prodotto del lavoro) si ha solo un consumatore di fronte ad un prodotto con il suo valore d’uso, si rimuove, cioè, sia il carattere della produzione capitalistica quale produzione per l’accumulazione di ricchezza (e non per la soddisfazione dei bisogni, come afferma banalmente Grillo), sia l’antagonismo delle principali classi in lotta: quella capitalista e quella lavoratrice, che posti semplicemente di fronte al consumo di merci sembrano avere interessi comuni. È rimossa in origine, quindi, la stessa idea di conflitto sociale, di lotta di classe, di intervento negli attuali rapporti sociali di produzione. È tenuta nascosta, per questa via, anche la sola idea di una trasformazione sociale. Ciò in quanto viene rimossa la classe sociale; perde di senso il soggetto collettivo. E ciò in un quadro nel quale già lo sviluppo tecnico, l’uso capitalistico della tecnologia, le forme di organizzazione del lavoro producono una disgregazione di classe ed frantumano in mille tasselli la complessità del processo produttivo. Ma in questo modo, mentre si afferma la necessità di un reddito per la liberazione dal lavoro, rimangono nascosti i rapporti sociali di produzione, di cui invece occorre prendere coscienza, quando davvero ci si vuole emancipare dall’attuale modello di produzione.
È ovvio porsi, a questo punto, la domanda che già Marx faceva dopo aver osservato che “lo sviluppo dell’industria moderna deve far pendere la bilancia sempre più a favore del capitalista, contro l’operaio”: “Se tale è in questo sistema la tendenza delle cose – si chiedeva retoricamente Marx – significa forse ciò che la classe operaia deve rinunciare alla sua resistenza contro gli attacchi del capitale e deve abbandonare i suoi sforzi per strappare dalle occasioni che le si presentano tutto ciò che può servire a migliorare temporaneamente la sua situazione?”. Ovviamente, no, perché “Se essa lo facesse, essa si ridurrebbe al livello di una massa amorfa di affamati e di disperati, a cui non si potrebbe più dare nessun aiuto, [… ma allo stesso tempo …] Non deve dimenticare che essa lotta contro gli effetti, ma non contro le cause di questi effetti […] Perciò essa non deve lasciarsi assorbire esclusivamente da questa inevitabile guerriglia, che scaturisce incessantemente dagli attacchi continui del capitale o dai mutamenti del mercato” [12].
Ha perfettamente ragione, allora, Giovanna Vertova a sostenere che la proposta di un reddito di cittadinanza potrebbe essere “accettabile solamente se inserita in un quadro più ampio” che prima di tutto tenesse presente “la messa al lavoro, il contenuto del lavoro, il ‘cosa, come, quanto e per chi si produce’, accompagnando la discussione con proposte di riduzione della giornata lavorativa e di aumenti salariali” [13]. E senza tenere fuori da questo quadro, inoltre, la cancellazione della legislazione che impone la precarietà e la necessità di ripensare un sistema di welfare degno di questo nome. E questo in quanto tali rivendicazioni, nel loro insieme e diversamente dalla proposta del reddito di cittadinanza specialmente quando preso come soluzione ai problemi che pone la tendenza dello sviluppo capitalistico, delineano un quadro che si prefigura come obiettivo intermedio che tende all’unione dei lavoratori, a promuovere una presa di coscienza nel corso della lotta e ad ottenere riforme di carattere non temporaneo e capaci di incidere sul sistema di produzione.
NOTE:
[1] B. Grillo, La fine del lavoro, https://goo.gl/rp3wyW
[2] B. Grillo, Società senza lavoro, https://goo.gl/cB7s7N
[3] McKinsey Global Institute, The world at work: Jobs, pay, and skills for 3.5 billion people, 2012
[4] Fortune, The Global 500: The Top 10, 2017
[5] International labour organization, World employment social outlook trends, 2018
[6] McKinsey Global Institute, op. cit.
[7] K. Marx, Il Capitale, Libro I, Newton, 1996
[8] International labour organization, op. cit.
[9] McKinsey Global Institute, op. cit.
[10] G. Vertova, in Etica & Politica, XIX, 2017
[11] K. Marx, Il Capitale, Libro II, Newton, 1996
[12] K. Marx, Salario, prezzo e profitto, Editori riuniti, 1970
[13] G. Vertova, op. cit.
Fonte: https://www.lacittafutura.it/editoriali/informate-grillo-il-lavoro-non-e-finito



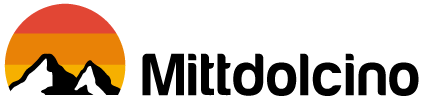




























Commenti recenti