All’università (ci tengo a precisare, una delle migliori d’Italia e d’Europa) ho studiato economia, anzi, per l’esattezza, economics (traducibile all’incirca con “scienze economiche”) ed economia pubblica. Durante la laurea triennale ho maturato la forte percezione che, in quello che stavo imparando, ci fosse qualcosa che non andava.
Così, mi sono avvicinata istintivamente alla storia del pensiero economico, per capire innanzitutto come fossimo arrivati a definire gli esseri umani “consumatori” o alla formulazione delle curve di indifferenza. Come si usa dire, mi si è aperto un mondo. Ho finalmente capito da dove veniva la sensazione di disagio e spaesamento che provavo durante le lezioni e gli stessi argomenti visti in classe cominciarono ad assumere un senso diverso. Finalmente iniziavo a capire quello che stavo studiando.
Proseguendo gli studi universitari (e parallelamente lo studio del pensiero economico), ho capito che di economia non sapevo davvero nulla. Sapevo fare i calcoli, conoscevo le teorie economiche e i metodi statistici, ma non sapevo che cosa stessi facendo. E, questione per me più grave, i miei professori non avevano mai reso esplicito che la teoria che ci stavano insegnando non solo ha un nome preciso (teoria economica neoclassica), ma anche che non è l’unica teoria economica possibile. Che la teoria economica neoclassica è una teoria che ha un’origine, ma soprattutto che ha dei problemi. Che l’economia che studiavo non si è sempre chiamata economics, ma prima si chiamava in un altro modo (political economy) e studiava altri problemi.
Col tempo, ho capito che non tutti erano in malafede: molti professori semplicemente non sapevano queste cose, perché nessuno gliele aveva insegnate e loro non si erano fatti domande. A loro andava bene così. E però resta comunque molta disonestà intellettuale, perché altri sanno benissimo che esiste una pluralità di idee, ma la tacciono, convinti che l’economia sia come le scienze dure, che progrediscono in modo incrementale. Secondo questa impostazione, studiare storia del pensiero economico ha la stessa utilità di studiare storia della scienza per un fisico: per la professione, di fatto nessuna. Come afferma Jean Paul Fitoussi nel libro-intervista La neolingua dell’economia:
“È straordinario rendersi conto che è ormai impossibile definire questo approccio come partigiano o fazioso, che è impossibile addirittura far notare che si tratta di un’opzione, di una scelta teorica, perché si nega che esistano opzioni”.
(Fitoussi 20191, 7).
E qui vengo al punto chiave. Il problema di fondo è che dell’economia non si sa più nulla.
Le ragioni di un tracollo
Oggi lo stereotipo dei laureati in economia è il seguente: persone con cui è estremamente penoso parlare, il cui ragionamento economico si limita al concetto di “rendimento”, che adorano figure moralmente ambigue che però nella vita “ce l’hanno fatta”. Nel pantheon ci sono Elon Musk o Warren Buffett, ma anche l’onnipresente Steve Jobs, di cui sciorinano le citazioni sull’innovazione, bevendosi ingenuamente tutta la retorica della Silicon Valley. Si potrebbero definire, senza timore di perdere complessità, persone piuttosto aride. Ma anche se ignoriamo l’appiattimento caratteriale, resta l’appiattimento oggettivo delle conoscenze economiche di chi l’economia dovrebbe averla studiata. Ciò ha ragioni molto precise. La spiegazione, in sostanza, è che l’economia non viene più insegnata.
Lo studio dell’economia si è ridotto a un veicolo per trovare lavoro (come molte altre facoltà del resto). Questo uso prettamente strumentale del sapere economico ha trovato un terreno fertile nel processo di matematizzazione dell’economia cominciato nel secondo dopoguerra, ma forse già con i marginalisti. Un processo che ha progressivamente svuotato l’economia delle sue premesse filosofiche e del ragionamento, in favore della predominanza del calcolo e di una modellizzazione matematica sempre più sofisticata. Tutto questo ha a sua volta un’origine, che intreccia la fascinazione di alcuni tra i primi economisti per la fisica classica, il sentire culturale e filosofico delle epoche del positivismo e il sogno, mai sopito nell’uomo, di poter un giorno controllare ogni aspetto di questa nostra vita. Tolto il senso, rimane lo strumento, il calcolo.
Anche l’orrenda neolingua parlata dalle nuove classi dirigenti economiche, quel mix di italiano e inglese ormai oggetto di ironia, ha una sua origine in questo progressivo tecnicizzarsi dell’economia. Come vedremo qualche riga sotto, le pubblicazioni che contano sono solo in lingua inglese e solo di articoli accademici (detti rigorosamente paper). L’effetto è stato quello, tra gli altri, di far sparire il lessico economico italiano, per cui oggi è quasi impossibile pensare e scrivere di economia in italiano in modo decente. Ma la perdita della lingua è la perdita del pensiero. C’è una differenza abissale tra i libri di economia scritti prima e dopo agli anni Ottanta. Non è un fenomeno solo italiano: recentemente i Paesi Bassi hanno deciso di limitare i corsi in inglese per paura che si perda la capacità di portare avanti la ricerca in olandese, perché significherebbe perdere proprio la capacità di pensare il mondo.
Due fenomeni su tutti mostrano in modo lampante questa involuzione: la progressiva scomparsa dello studio del pensiero economico in quasi tutto il mondo occidentale e la progressiva standardizzazione degli esami in test a crocette o vero/falso, modalità importata dagli Stati Uniti dove era già utilizzata almeno dagli anni Sessanta.
In un articolo accademico del 1987, “Out of the Closet: A Program for the Whig History of Economic Science”2, il principe dell’economia moderna Paul Samuelson (1915-2009) sosteneva che per gli studenti non aveva più senso studiare storia del pensiero economico, perché l’economia era diventata ormai così complessa che il tempo limitato degli anni universitari doveva essere impiegato per studiare l’economics e affinare le competenze matematiche. Gli studenti si sarebbero dovuti dedicare alla matematica avanzata e alla statistica se volevano stare al passo con una modellizzazione sempre più sofisticata. È la formulazione della cosiddetta “whig history of economics”, dal titolo del paper, che ricalca l’idea per cui l’economia sarebbe una scienza che procede in modo incrementale. A dire il vero, poi, nella formulazione di questo approccio Samuelson fu particolarmente scorretto: molta della sua fortuna in ambito accademico, infatti, deriva proprio dalla sua profonda cultura di economia e storia del pensiero. Esistono carteggi copiosi in cui Samuelson discute di Karl Marx, ma anche di Adam Smith.
Il deserto di oggi
Gli esami a crocette sono la naturale modalità di esame in un’università sempre più aziendalizzata e votata al risparmio di tempo e denaro. La distruzione del welfare pubblico e le distorsioni di alcuni mercati, fra cui quello immobiliare, hanno mostrato senza più ipocrisie che studiare non è per tutti. Anzi, spesso è una scelta che comporta enormi sacrifici. Le università, per decenni feudi incontrollati, ora per ottenere i fondi hanno bisogno di raggiungere obiettivi di performance calcolati sul numero di studenti laureati e altri parametri. Hanno bisogno di far vedere che i propri studenti si laureano e che lo fanno in tempo, senza sprechi di soldi, che comunque le famiglie non hanno in abbondanza. I corsi da annuali sono diventati semestrali. Non c’è letteralmente più tempo per pensare e riflettere. Si ingurgitano nozioni e si segnano crocette.
Dal lato della ricerca non va meglio, anzi, forse la vera tragedia si consuma proprio qui. C’è un problema colossale con la difficoltà di pubblicare ricerche non in linea con la teoria economica neoclassica. Inoltre, il modello di selezione delle carriere accademiche ha fatto sì che in molti casi si smettesse di entrare nel merito delle pubblicazioni, per concentrarsi solo su parametri numerici come l’impact factor della rivista accademica e il numero di citazioni ricevute. Come disse una volta un professore di storia (di cui purtroppo non ricordo il nome) durante una conferenza:
“L’ANVUR1 si è inventata il modo per non dover leggere più i libri”.
Di fatto, l’abissale ignoranza del laureato medio in economia sulla sua stessa materia non è nemmeno più un problema: ormai è molto difficile che debba entrare davvero nel merito del retroterra di ciò che ha scritto. È sufficiente citare le conclusioni a cui sono giunti autorevoli autori pubblicati su altrettanti autorevoli journals, poco importa che siano fondati su errori di calcolo su o teorie che la realtà ha dimostrato essere false. Al massimo gli viene richiesta una verifica sui dati… che però non sempre accade. Celebre il caso della ricerca di Reinhart and Rogoff (2010)3 sul legame tra debito pubblico e crescita, i cui risultati (si è scoperto poi) erano basati sul cherry picking dei casi-studio e su un errore di selezione delle celle di Excel. Peccato che questo studio è stato alla base delle politiche di bilancio restrittive di mezzo mondo e influenzi ancora oggi l’approccio di molti economisti e governi al debito pubblico.
Insomma, si è innescato un circolo vizioso: agli studenti viene insegnata una sola teoria economica, la cui egemonia si consolida attraverso un saldo monopolio delle pubblicazioni necessarie per fare carriera accademica, che a sua volta produce solo insegnanti omologati al paradigma vigente che a loro volta fanno ricominciare il ciclo.
E gli studenti? Parlando con loro, ho rilevato spesso una mancanza di senso su quello che stanno studiando. Si trovano spaesati, tra grafici che spuntano a ogni lezione, complesse equazioni e definizioni che spesso prendono acriticamente. Ad alcuni va bene così, basta concludere, prendersi un pezzo di carta e cominciare a fare stage nella speranza di trovare un buon lavoro. Altri invece ne vorrebbero sapere di più, ma spesso non trovano nessun professore che possa soddisfare la loro curiosità.
Addio o arrivederci?
Alla luce di questa perdita di senso, le facoltà di economia sono destinate a scomparire. Allo stato attuale, sono inutili allo scopo per cui sono frequentate, cioè trovare lavoro ed avere skill appetibili per le aziende nel minor tempo possibile. Ci sono già indirizzi dove gli studenti sono incentivati a non venire a lezione, come finanza. Ma non è difficile immaginare un futuro dove le grandi aziende e banche fonderanno accademie proprie dove formare i futuri impiegati, ovviamente attraverso una prima rigorosa selezione dei candidati. Se il sapere economico è già sparito, quindi perché tenere in piedi facoltà che non possono fornire quello che davvero è richiesto sul mondo del lavoro?
Ma ci sono anche spunti di ottimismo. Esistono autori critici del presente stato di cose, sia a livello di metodo di insegnamento che della teoria dominante, che pubblicano ricerche e libri dove mostrano l’esistenza di teorie alternative, o dove spiegano le ragioni delle aberrazioni di quelle esistenti. Lo stesso campo di studio del pensiero economico non è scomparso, anzi, esistono riviste dedicate e vengono tutt’oggi pubblicati libri ed esiste anche un dibattito sull’opportunità o meno di continuare a studiare la storia delle idee economiche, nonostante il corso di storia del pensiero economico sia sparito dalla maggior parte degli atenei. Bisogna solo avere la fortuna di studiare in un’università in cui insegna qualcuno di questi professori. Ma, appunto, se ne deve avere la fortuna.
Dell’economia pochi sanno qualcosa e quei pochi che sanno non è facile trovarli. Il paradosso è che più questo deserto avanza e più lo studio di questa materia diventa appassionante. Proprio perché dell’economia non si sa più nulla, e forse non si è mai saputo nulla, è questo l’ambito in cui si dovrebbe pensare e cercare di più. L’economia è bella, è interessante, è avvincente. Dietro ogni concetto, anche al più arido e tecnico, si nasconde un’immensa complessità di temi, una pluralità di concezioni filosofiche, di guerre di metodo. Ci sono personaggi e studiosi con le loro storie e la loro visione del mondo. L’economia ha mosso la storia, ha plasmato il diritto, fa parte della vita quotidiana di tutti noi, eppure nessuno sa dire davvero cosa sia.
Economia dovrebbe essere la materia più lunga e complessa da studiare, perché, come disse John Maynard Keynes nell’elogio funebre del suo maestro Alfred Marshall, un buon economista…
…“deve essere matematico, storico, statista, filosofo in una certa misura. Deve capire i simboli ed esprimersi con le parole.
Deve contemplare il particolare in termini di generale, e toccare l’astratto e il concreto nello stesso volo del pensiero. Deve studiare il presente alla luce del passato in vista del futuro. Nessuna parte della natura umana o delle istituzioni deve essere completamente estranea alla sua attenzione.
Deve essere allo stesso tempo interessato e disinteressato, distaccato e incorruttibile come un artista, ma a volte vicino alla terra come un politico”.
Spunti per ripartire
Nel 2021 Roberto Artoni scriveva un articolo intitolato “Passo d’addio” in cui delineava un riassunto degli sviluppi della teoria economica dagli anni ’60 a oggi, il cui bilancio è sostanzialmente negativo:
“Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni si pongono problemi per la ricerca economica. Oggi si assiste a una sorta di silenziamento dei dibattiti sui fondamenti della disciplina.
(…)
Credo inoltre che uno degli aspetti deteriori dei curricula accademici vigenti sia stato l’emarginazione della storia delle dottrine. È stato affermato che chi studia oggi medicina può tranquillamente ignorare Galeno e tutti i medici non moderni.
A questa affermazione si può obiettare che Le Corbusier era un attento studioso dell’architettura antica. Si deve dunque decidere se l’economia è più simile alla medicina o all’architettura. Personalmente propendo per la seconda ipotesi”.
(Artoni 2020, 12)4.
Ma d’altronde, era la “Cronaca di una morte annunciata”, per citare il titolo di un celebre romanzo, in cui tutti sanno della morte del protagonista, ma per un motivo o per l’altro nessuno fa nulla per impedirlo. Nel 1985 l’economista italiano Claudio Napoleoni scrisse alcune delle righe che più mi sono rimaste impresse:
“L’economia politica sembra (…) una disciplina singolare.
La sua singolarità sta in ciò: che se essa è ricondotta a una forma ‘scientifica’ (secondo il paradigma, cioè, delle scienze naturali), ‘si sa’, indipendentemente dalla possibilità di fondare o anche solo di argomentare bene questo ‘sapere’, che qualcosa di essenziale va perduto: di essenziale, si badi bene, per la conoscenza delle cose di questo mondo”.
(Napoleoni 1985, 154)5.
Quello che è accaduto, e che tanti studenti sperimentano ogni giorno, è stata proprio la perdita di questo qualcosa di essenziale. Sempre Napoleoni, in un articolo del 1978, “Sraffa’s Tabula Rasa”, osservando il capolinea a cui era arrivata secondo lui la teoria economica dopo l’opera di Piero Sraffa, concluse lasciando un compito ai futuri studiosi di economia:
“Bisogna ricominciare tutto da capo” (“he forces us to take everything back to the beginning”)
(Napoleoni 1978, 77)6.
Ecco, l’economia andrebbe rifatta da capo. E invece si è deciso di ignorare i problemi e non ricominciare proprio niente.
Ma quindi, cosa si dovrebbe fare? Come dovrebbe essere ristrutturato l’insegnamento dell’economia? Nessuno ha il rimedio perfetto, ma qualche linea di intervento si può intravedere. Si potrebbe ricominciare ad affiancare allo studio delle materie tecniche la storia del pensiero economico, non come sguardo sterile sul passato ma come via per comprendere quei fondamenti della disciplina di cui parla Artoni; un ritorno a modalità di esame che stimolino il ragionamento degli studenti e non siano un mero strumento di rendicontazione; un approccio alla ricerca che non si basi sul principio di auctoritas delle classifiche delle riviste accademiche, ma ritorni ad entrare nel merito di ciò che viene pubblicato.
Per quanto mi riguarda, assisto con dolore e impotenza alla morte dell’economia, uccisa proprio da coloro che dicono di amarla, dai vincenti della società e dell’accademia che consumano questo delitto tra le lodi del pubblico7.




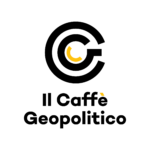



























Commenti recenti