Alla fine di gennaio, ho lasciato la mia casa in Virginia, dove lavoro come chirurgo plastico e ricostruttivo e mi sono unito a un gruppo di medici e infermieri in viaggio verso l’Egitto con il gruppo di aiuto umanitario MedGlobal per fare volontariato a Gaza.

Ho lavorato in altre zone di guerra. Ma quello a cui ho assistito durante i successivi 10 giorni a Gaza non è stata la guerra, è stato l’annientamento.
Almeno 28.000 palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento israeliano di Gaza. Dal Cairo, la capitale dell’Egitto, abbiamo viaggiato in auto per 12 ore verso est fino al confine di Rafah. Abbiamo superato chilometri di camion di aiuti umanitari parcheggiati perché non potevano entrare a Gaza. A parte il mio team e altri inviati delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, c’erano pochissimi altri.
Quando sono entrato nel sud di Gaza il 29 gennaio, dove molti sono fuggiti dal nord, mi è sembrato di leggere le prime pagine di un romanzo distopico. Le nostre orecchie erano intorpidite dal ronzio costante di quelli che mi dicevano essere i droni di sorveglianza che giravano costantemente. I nostri nasi erano consumati dal fetore di 1 milione di esseri umani sfollati che vivono nelle immediate vicinanze senza servizi igienici adeguati. I nostri occhi si sono persi nel mare di tende. Abbiamo alloggiato in una guest house a Rafah. La nostra prima notte è stata fredda e molti di noi non riuscivano a dormire. Stavamo sul balcone ad ascoltare le bombe e a vedere il fumo che si alzava da Khan Younis.

Quando ci siamo avvicinati all’ospedale europeo di Gaza il giorno dopo, c’erano file di tende allineate che bloccavano le strade. Molti palestinesi gravitavano verso questo e altri ospedali sperando che rappresentasse un rifugio dalla violenza: si sbagliavano.
Le persone si sono riversate anche nell’ospedale: vivevano nei corridoi, negli androni delle scale e persino negli armadietti. Le passerelle un tempo larghe progettate dall’Unione Europea per accogliere il traffico intenso di personale medico, barelle e attrezzature sono state ora ridotte a un passaggio in fila indiana. Su entrambi i lati, coperte pendevano dal soffitto per delimitare piccole aree per intere famiglie, offrendo un briciolo di privacy. Un ospedale progettato per ospitare circa 300 pazienti stava ora lottando per prendersi cura di più di 1.000 pazienti e altre centinaia cercavano rifugio.
C’era un numero limitato di chirurghi locali disponibili. Ci è stato detto che molti erano stati uccisi o arrestati, e che non si sapeva dove si trovassero o addirittura se fossero vivi. Altri sono rimasti intrappolati in aree occupate nel nord o in luoghi vicini dove era troppo rischioso recarsi in ospedale. C’era solo un chirurgo plastico locale rimasto e copriva l’ospedale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sua casa era stata distrutta, così viveva in ospedale ed era in grado di infilare tutti i suoi effetti personali in due piccole borse. Questa narrazione è diventata fin troppo comune tra il resto del personale dell’ospedale. Questo chirurgo è stato fortunato, perché sua moglie e sua figlia erano ancora vive, anche se quasi tutti gli altri che lavoravano nell’ospedale erano in lutto per la perdita dei loro cari.
Ho iniziato a lavorare immediatamente, eseguendo da 10 a 12 interventi chirurgici al giorno, lavorando dalle 14 alle 16 ore alla volta. La sala operatoria tremava spesso per gli incessanti bombardamenti, a volte frequenti ogni 30 secondi. Abbiamo operato in ambienti non sterili che sarebbero stati impensabili negli Stati Uniti. Avevamo un accesso limitato alle attrezzature mediche critiche: eseguivamo amputazioni di braccia e gambe ogni giorno, usando una sega di Gigli, uno strumento dell’epoca della Guerra Civile, essenzialmente un segmento di filo spinato. Molte amputazioni avrebbero potuto essere evitate se avessimo avuto accesso ad attrezzature mediche standard. È stata una lotta cercare di prendersi cura di tutti i feriti all’interno dei costrutti di un sistema sanitario che è completamente collassato.

L’ultimo giorno, mentre tornavo alla pensione dove la gente del posto sapeva che alloggiavano stranieri, un ragazzino è corso da me e mi ha consegnato un piccolo regalo. Era uno scoglio della spiaggia, con un’iscrizione in arabo e una scritta a pennarello: “Da Gaza, con amore, nonostante il dolore”. Mentre mi trovavo sul balcone a guardare Rafah per l’ultima volta, potevamo sentire i droni, i bombardamenti e le raffiche di mitragliatrice, ma questa volta c’era qualcosa di diverso: i rumori erano più forti, le esplosioni erano più vicine.
Questa settimana, le forze israeliane hanno fatto irruzione in un altro grande ospedale a Gaza e stanno pianificando un’offensiva di terra a Rafah. Mi sento incredibilmente in colpa per essere stato in grado di andarmene, mentre milioni di persone sono costrette a sopportare l’incubo a Gaza. Come americano, penso ai soldi delle nostre tasse che finanziano le armi che probabilmente hanno ferito i miei pazienti. Già cacciate dalle loro case, queste persone non hanno nessun altro posto in cui andare.
Irfan Galaria è un medico con uno studio di chirurgia plastica e ricostruttiva a Chantilly, in Virginia.
Articolo originale: Opinion: I’m an American doctor who went to Gaza. What I saw wasn’t war — it was annihilation, Irfan Galaria, Los Angeles Times, 16 febbraio 2024





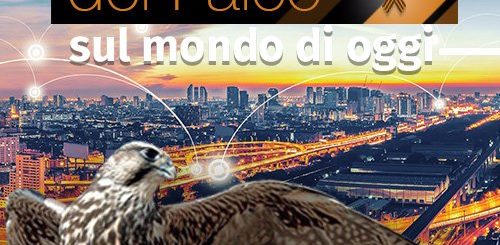



























Commenti recenti