Black Marxism
di DOPPIOZERO (Mimmo Cangiano)
Quanto mai meritoria l’operazione di Alegre di tradurre e pubblicare un classico situato all’intersezione fra storiografia radicale, marxismo, Black e Postcolonial Studies. Originariamente uscito nel 1983, Black Marxism di Cedric J. Robinson è un lungo ma assai godibile volume incentrato su tre direttive d’analisi: 1) una ricostruzione della storia europea tesa a mettere in luce il “razzialismo” come elemento costitutivo dell’identità europea e delle sue modalità di espansione (un “razzialismo”, chiariamolo subito, che si origina al di fuori della “linea del colore” e solo in seguito passa a riferirsi più direttamente a questa); 2) la critica a un marxismo tradizionale che legge il razzismo esclusivamente nei termini di un epifenomeno del capitalismo, mancando cioè di cogliere l’effetto diretto sui processi di sfruttamento ed espropriazione di una concrezione socio-culturale (“capitalismo razziale”); 3) la persistenza di una tradizione radicale nera che, a differenza del marxismo tradizionale, si sarebbe mantenuta estranea ai più nocivi effetti sintomatici (ci torniamo dopo) provenienti dall’eurocentrismo, esprimendo in tal modo concezioni alternative della società, della storia, della politica, ecc.. I tre intellettuali che Robinson analizza in tale direzione sono W.E.B. Du Bois, C. L. R. James e Richard Wright.
Forse sorprendentemente, è proprio la seconda direttiva d’analisi (già emersa prima di Robinson nel dibattito marxista sudafricano) ad aver ottenuto un generale consenso (anche fra i marxisti). Il mancato sviluppo del modo di produzione capitalistico secondo una logica omogeneizzante, tesa cioè a sussumere le differenze di razza, genere, nazione mediante un’occidentalizzazione e razionalizzazione del sistema produttivo, ha permesso non solo di chiarire meglio gli effetti strutturali delle sovrastrutture, ma anche di sottolineare tutta una serie di fenomeni di “sur-sfruttamento” (Claudia Jones) legati alla razzializzazione e anche (Robinson non ne parla ma è facile estendere intersezionalmente il suo discorso) alla sessizzazione. Le sue concezioni sono poi ovviamente tornate alla ribalta tanto per lo sviluppo accademico dei Postcolonial, Black e White Studies, quanto per le più recenti esperienze di lotta, come quelle legate a Black Lives Matter.
Sebbene alcune voci si siano certo levate a sottolineare la presenza di discorsi in questa direzione già nell’ultimo Marx, Engels e, ancor di più, in alcune tradizioni del marxismo novecentesco (ad esempio Gramsci), l’assunto di Robinson ha comunque aiutato ad arricchire il campo d’analisi con nuove e pregnanti considerazioni, fornendo – anche al marxismo tradizionale – strumenti di comprensione del reale dai quali sarebbe ormai ridicolo prescindere.
La parte storica del volume, dedicata al formarsi della borghesia e del capitalismo europei, ha invece trovato numerosi critici, soprattutto fra gli storici di professione. Benché il principio di una pre-esistenza del razzismo al capitalismo sia genericamente accettato (ma vale la pena ricordare che anche l’oppressione di classe precede il capitalismo), si è sottolineato una scarsa messa a fuoco del modo in cui il razzialismo eurocentrico si sia trasformato in seguito all’imporsi del nuovo modo di produzione, e si è notato che i caratteri dell’eurocentrismo, per come qui intesi, sono troppo facilmente legati a un principio trans-storico, e di carattere “emanativo”, teso ad assorbire proprio le differenze di classe, così trasformando il capitalismo (e addirittura la teoria del Destino Manifesto) in un epifenomeno della mentalità europea. Sotto la lente della critica, voglio dire, non è finito il principio (pure questo generalmente accettato) di una partecipazione delle classi subalterne ai principi razziali dell’eurocentrismo (e neppure la razzializzazione come elemento determinante dell’economia continentale: particolarmente efficaci risultano le pagine dedicate alle potenze italiane del periodo rinascimentale); ma proprio, dagli antichi Greci al fascismo, il rischio, per paradosso, della chiusura a-dialettica del concetto stesso di razzializzazione in una presupposto che da socio-economico tende talvolta effettivamente a trasformarsi in psicologico.
Allo stesso modo è finito sotto accusa il legame troppo stretto che Robinson crea fra Europa e schiavitù. Si è cioè sottolineato un estendersi dei principi connessi alla razzializzazione ben al di là dei confini europei (Cina, Giappone, sud-est asiatico, imperi arabi, alcune società amerinde, ecc.), e si è dunque indicata la necessità di una più corretta spiegazione per ciò che concerne il momento storico di connessione fra le schiavitù e l’accumulazione originaria di capitale. Non sono uno storico dell’età moderna e dunque non me la sento di dare un giudizio su tali possibili “errori” di Robinson, ma – facendo in particolare riferimento ai lavori di Peter Linebaugh e di Marcus Rediker – si può forse affermare che l’appiattimento della mentalità “razzializzante” sull’Europa è problematico quando non inteso in una più stretta relazione col formarsi, certo europeo e bianco, del capitalismo. Ciò ovviamente non significa che Robinson non abbia, a mio giudizio, pienamente ragione nell’indicare la persistenza di stilemi concettuali di carattere antico e/o feudale anche nell’Europa moderna, ma significa che la progressiva formazione di una “coscienza razziale” (Theodore W. Allen) necessita sempre un più stretto legame anche con i processi materiali che contribuisce a creare e che, a loro volta, la modificano. Non si tratta dunque di criticare la preservazione di modi di produzione e mentalità pre-capitalistiche nell’Europa moderna (e dunque la persistenza del razzialismo e il suo successivo ‘passaggio’ da infra a extra europeo: queste mi paiono conquiste decisive del discorso di Robinson), ma di sottolineare la necessità di una maggiore attenzione (come del resto poi fatto da molti studiosi simpatetici verso Robinson) agli effetti di ritorno dei processi materiali sulle mentalità, al fine di evitare un troppo marcato determinismo sovrastrutturale. Detto banalmente, se la working class europeaha certo mantenuto in sé i tratti del razzialismo europeo, si è spesso anche dimostrata in grado di superarli. E resta infatti tutto da vedere se, come volevano ad esempio Fanon e in parte lo stesso Du Bois, gli effetti delle lotte in occidente non abbiano poi prodotte dialettiche decisive anche nel quadro delle lotte extra-europee, ma questa è un’altra storia.
La parte finale di Black Marxism è dedicata, come dicevamo, alla formazione e emersione di una tradizione radicale nera, sviluppatasi al di fuori degli stilemi ideologici europei e dunque estranea allo stesso marxismo. Qui Robinson ha certamente il grandissimo merito di distruggere tutte quelle concrezioni ideologiche di matrice occidentale legate alla figura del nero (passività, ecc.), insistendo su una storia di ribellioni (Haiti), resistenze (Brasile, Indie Occidentali, ecc.) e rifiuti del discorso omogeneizzante e universalizzante che dall’Europa marciava verso l’Africa e verso i nuovi territori ora abitati da africani: “Si tratta di una coscienza rivoluzionaria nata dall’esperienza storica del popolo nero nel suo complesso e non soltanto dalle formazioni sociali della schiavitù capitalista o dai rapporti di produzione del colonialismo”.
L’analisi ha però qui due problemi che non mi paiono di poco conto. In primo luogo su in che cosa consista questa “totalità ontologica garantita da un sistema metafisico” Robinson è davvero vago, nel senso che i dati empirici che pure riporta (stile di vita, religione, associazionismo, ecc.) fanno molta fatica a delineare un possibile quadro teorico. Va però detto che, da un lato, alcuni studiosi si sono negli anni impegnati a riempire il contenitore approntato da Robinson; dall’altro che il rifiuto di uno sviluppo teorico dei dati empirici riportati, potrebbe essere funzionale al rifiuto di sviluppare uno schema teorico di questi che, a sua volta, rischierebbe effettivamente di rientrare in una modalità occidentale di sistematizzazione strumentale del dato stesso. Su questo dunque sospendo il giudizio.
In secondo luogo, e ciò mi pare più problematico, i popoli africani vengono compressi in un mega-contenitore epistemologico che tende ad annullare ogni linea di differenziazione geografica o temporale (ma non di classe: dal momento che Robinson riferisce spesso a una piccola-borghesia nera che ha sussunto le direttive bianche). Pur volendo accettare il presupposto di Black Marxism secondo cui la tradizione radicale nera tende a superare ogni economicismo rivalutando il ruolo “dell’ideologia e della coscienza”, così dunque finalmente integrando la sovrastruttura nella struttura, il paradigma identitario – certo anche per ragioni di tattica politica – tende ad essere davvero troppo omogeneizzante, e di ciò finiscono col risentirne le stesse analisi dedicate a Du Bois, James e Wright. Mi spiego: il nesso che Robinson stabilisce, in particolare attraverso Du Bois, fra la veicolazione del lavoratore nero all’interno del sistema globale moderno secondo rapporti sociali che continuano però a essere determinati dall’ideologia suprematista bianca, mi pare sacrosanto, e mi pare valida anche l’affermazione di una persistenza “dell’influsso corrosivo dello schiavismo” all’interno del socialismo euro-statunitense.

Ma poi, per mantenere integri i suoi principi identitari, Robinson è da un lato costretto a leggere ogni apertura marxista nei confronti della questione di razza in termini di pura tattica strumentale e, dall’altro, a intendere la (quasi) mancata dialettica multi-razziale fra lavoratori sulla base di un principio che trapassa continuamente da un senso storico a uno metafisico-antropologico secondo cui il proletariato bianco è, da sempre e per sempre, legato a una società capitalista di cui non può essere negazione. Quella che insomma è certo una questione ideologica, storica ed economica reale (la cooptazione della classe lavoratrice nelle strutture di pensiero delle classi dominanti) rischia continuamente di trasformarsi – e l’omogeneizzazione dei neri è, a rovescio, un gigantesco sintomo di ciò – in un dato non solo trans-storico ma direttamente naturalizzante, che rischia di far collassare, per dirla con Jason Moore, gli stessi nuclei storici da cui Robinson ha mosso il suo discorso. E, inoltre, si rischia così addirittura di cominciare a sottovalutare, per estremo paradosso, il ruolo giocato nella questione anche da schiavitù e colonialismo, vale a dire il modo in cui questi hanno effettivamente alterato e complicato, come scriveva Cabral, le forme della lotta di classe.
Allo stesso modo, Robinson si trova poi infatti costretto a scrivere, nelle pagine su James, che il discorso di quest’ultimo implica l’irrilevanza di cultura, pensiero e ideologia borghese per la coscienza rivoluzionaria nera, a favore di una completa negazione a-dialettica che finisce per immaginare i gruppi sociali in lotta, e davvero non era il punto di James, come compartimenti stagni (con la solita eccezione della piccola-borghesia nera).
Dei tre intellettuali analizzati, Wright è forse l’unico davvero funzionale alla totalità del discorso di Robinson, e lo è perché in Wright la formazione di una tradizione radicale nera affonda in un discorso creaturale che presenta lo sviluppo storico del “popolo nero” direttamente come negazione del capitalismo occidentale e dei suoi derivati. Ma, anche in questo caso, il rischio è quello di cadere in un’essenzializzazione del subalterno su base essenzialistico-identitaria, un subalterno che si immagina (o viene immaginato) come totalmente altro dalle forze strutturali e sovrastrutturali con cui entra continuamente in contatto, in un discorso che finisce pericolosamente per ricordare tanto le opzioni Gemeinschaft quanto i vari ‘socialismi’ su base etnica che si erano diffusi fra gli intellettuali di quelle nazioni europee (come la Germania di Weimar) che si ritenevano spiritualmente estranee alla marcia trionfante del capitalismo anglo-americano e francese.
Il rischio è qui che la legittima (e dialettica) richiesta di integrare la sovrastruttura nella struttura si trasformi in un discorso di tipo idealistico che, pur se sviluppato su base storica, finisce poi per soggiogare la storia stessa (rapporti materiali, di mentalità, diverse conformazioni sociali, ecc. ecc.) a un universo culturale, quello appunto della tradizione radicale nera, che si trasmette, viene arricchito, ma mai muta nei suoi assunti base. Ma, anche volendo fermarci a un solo esempio, ci si dovrebbe a questo punto chiedere perché la tradizione radicale nera emerga poi a coscienza teorica (in Du Bos, James, Wright, ecc.) proprio grazie (anche se contro) all’iniziale adesione di questi autori al marxismo occidentale. Ma chiaramente anche solo rispondere a questa domanda farebbe crollare il presupposto di una completa separazione fra la stessa tradizione radicale nera e l’occidente, quell’occidente dove, sempre secondo Robinson, “la dialettica hegeliana dell’Aufhebung, quella marxiana della lotta di classe […], l’evoluzione della specie di Darwin e la lotta per la sopravvivenza di Spencer, sono tutte forgiate dalle stesse convinzioni metafisiche”.
Non si pensi che io abbia messo in luce quelle che mi paiono alcune problematiche di Black Marxism per sottrarre in qualche modo valore a quelle che invece ritengo le sue fondamentali puntualizzazioni: una raffinata spiegazione del “capitalismo razziale”, una in gran parte efficace analisi storica di questo, l’effetto nel mondo capitalistico di concezioni pre-capitalistiche, la necessità di comprendere più compiutamente il ritorno della sovrastruttura nella struttura e, infine, la stessa capacità di leggere gli elementi culturali persistenti in determinate tradizioni autoctone. Condivido anzi la quasi totalità delle affermazioni con cui Miguel Mellino, nella prefazione e postfazione, impreziosisce il volume, così come condivido il suo invito a mettere i concetti di Robinson a lavoro nelle specificità dei contesti storico-geografici.
Allo stesso modo, l’impossibilità di sussumere la razza astrattamente nel concetto di classe resta certo la decisiva legacy di Black Marxism: l’unico punto su cui non sono d’accordo con Mellino è infatti nella facilità con cui si sbarazza, in una nota, delle critiche di Vivek Chibber agli sviluppi dei Subaltern Studies. Il punto di Chibber non è negare la dialettica fra universalizzazione e gerarchizzazione del lavoro per come tipica del “capitalismo razziale” (e di genere), ma è proprio criticare l’assunto secondo cui la mancata formazione universalistica delle strutture del liberalismo che oliano il mercato capitalistico metterebbe di per sé in crisi l’analisi marxista del capitalismo. Per lui l’universalizzazione coincide infatti non con lo sviluppo di istituzioni politiche e di un sistema di produzione e mercato razionalizzato di tipo occidentale, ma con il principio della produzione a fini di valore di scambio. Anche questo assunto è certo criticabile (si veda la posizione di Sandro Mezzadra), però non va confuso con un rifiuto del “capitalismo razziale”, che anzi anche per lui resta uno dei modi preminenti in cui il capitalismo si esprime in determinati contesti geografici e temporali.
Ma bisogna comunque in conclusione domandarsi, come fanno ad esempio i nuovi marxisti afro-americani come Cedric Johnson, se il discorso di Robinson – involontariamente – non abbia però favorito, negli ultimi anni, un certo accademismo liberal più teso a rigettare l’analisi di classe che a intenderla, come comunque provava a fare Black Marxism, in una più ampia dialettica. E allo stesso modo è necessario sottolineare che il volume ha certo anche qualcosa a che fare con gli anni in cui è stato pubblicato, anni di generale arretramento del movimento dei lavoratori e di una rinnovata attenzione del capitale, a scopi di profitto e di espansione, per le questioni identitarie e per le specificità culturali, seguendo un processo che, anche a livello accademico, ha finito sempre più per liberalizzare gli stessi concetti di razza e di genere, cioè per intenderli come separati dal funzionamento della struttura economica (è la ragione per cui Mark Fisher ha scritto che “il concetto di classe [vale a dire di posizionalità rispetto al capitale] serve a de-liberalizzare i concetti di razza e genere”). Sono emerse negli ultimi anni analisi del razzismo (Peggy McIntosh, Tim Wise) su base meramente culturale e pregiudiziale (cioè come un problema risolvibile al di fuori della sfera economica), così come si è fatto strada il mito di una working class vista essenzialmente come bianca, una meta-narrativa che, ad esempio nel discorso di David Roediger, si è appoggiata proprio su considerazioni psicologico-culturali, sempre più lontane da quel riferimento posizionale nella struttura di cui parlava appunto Fisher. Ciò esula dagli intenti di questa recensione, ma forse varrebbe anche la pena chiedersi cosa accade quando il capitale, pur continuando in prassi a mettere a funzione i processi di razzializzazione, si dimostra sempre più in grado anche di mettere a profitto, su un piano culturale che è però anche economico, le prospettive anti-razziste.
Questa domanda ci porterebbe a dover fare i conti con la capacità multi-ideologica del capitale post-fordista, una cosa che gli intellettuali liberal preferiscono ignorare, immaginandolo sempre come legato alle prospettive di un potere definitorio, monologico, assolutizzante. E l’impianto così rigidamente binario che, anche suo malgrado, Black Marxism ospita, forse qualche colpa in tutto questo ce l’ha. Allo stesso modo – ed è anche per questo che è un libro così difficile da presentare – molte delle sue intuizioni sono vitali per portare avanti vecchi e nuovi discorsi di lotta, anche qui in Italia. La mia speranza è che non sia utilizzato per creare nuove divisioni, ma nuove alleanze.
Il libro: Cedric J. Robinson, Black Marxism. Genealogia della tradizione radicale nera, Roma, Alegre 2023.
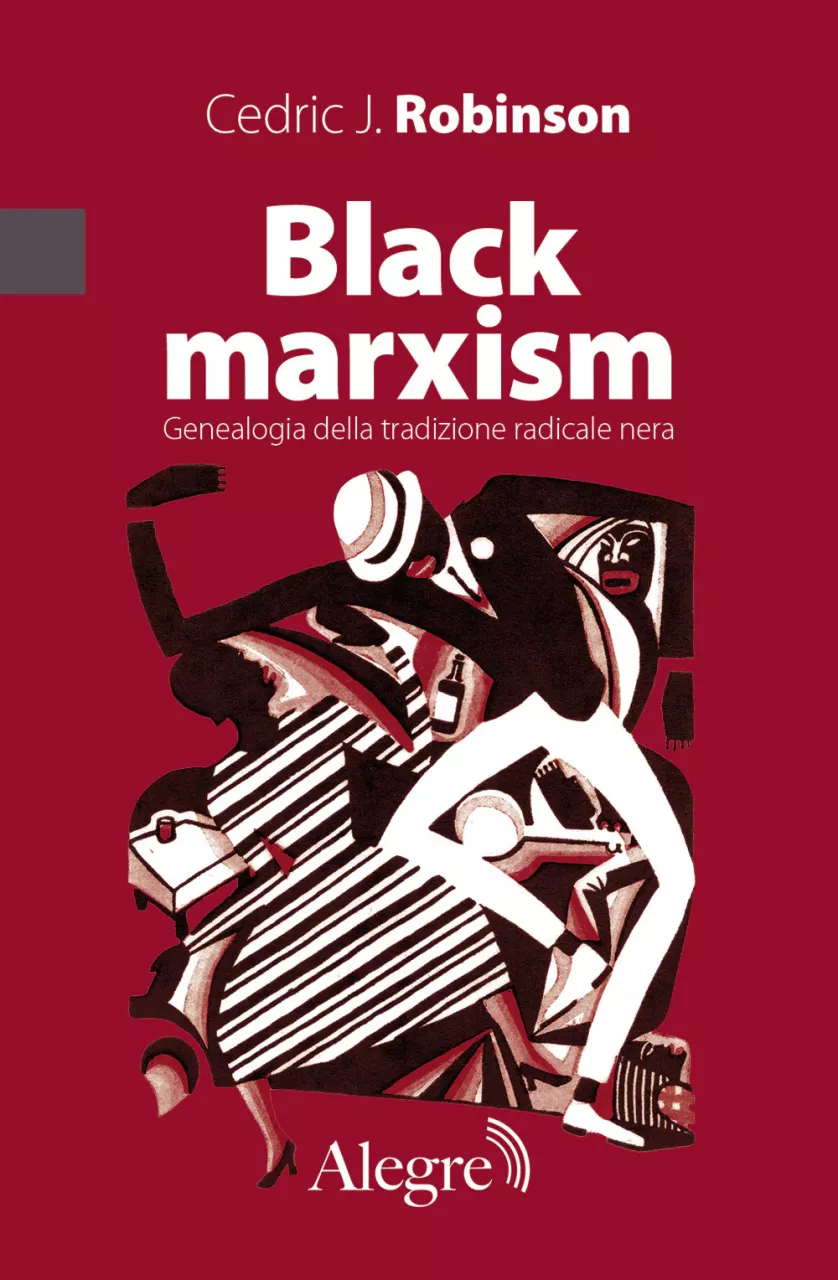































Commenti recenti