La Rete e i narcisi senza corpo
di DOPPIOZERO (Iolanda Stocchi)
Tutto è cambiato. Lo dicono in molti, pochi sembrano davvero accorgersene. Ma cosa è cambiato? Il digitale ha mutato radicalmente il nostro modo di stare al mondo ma – scrivono Riccardo Marco Scognamiglio, Simone Matteo Russo, Matteo Fumagalli, gli autori di Il narcisismo del You (Mimesis, 2024) – “vi siamo talmente immersi da non prestare più attenzione agli effetti di perfusione del Web nei nostri corpi e nelle nostre menti, oltre che nei nostri comportamenti sociali”. Questo libro si occupa con intelligenza delle conseguenze dell’abuso del digitale, passando dalle neuroscienze alla psicoanalisi, dall’antropologia alla sociologia, per non dimenticarsi della clinica, attraverso storie con le quali gli psicoanalisti si confrontano quotidianamente nel loro lavoro. Siamo entrati in una dimensione irreversibile, quella digitale, in cui l’uomo è al servizio della macchina. Questa preoccupazione è giustificata? Sì, perché sta mettendo in campo mutamenti enormi, dei quali è necessario diventare consapevoli.
Gli autori sostengono che la nascita del Web 2.0 nel 2004 ha sancito una nuova categoria fenomenologica: una percezione di noi e degli altri che – per dirla con Pasolini – ha determinato una mutazione antropologica, mantenendoci però nell’illusione che niente sia mutato.
Ci troviamo di fronte a un fenomeno che, come quello del riscaldamento globale, esiste al di là della nostra consapevolezza. Non percependone l’urto, questo è il problema, non si generano le necessarie difese: “viviamo stati dissociativi senza doverci difendere da nulla, perché il sistema digitale ha il potere di silenziare, anestetizzare e ridurre la soggettività”. Gli autori parlano di traumatismo generalizzato e traumatismo digitalmente modificato che si intrecciano nell’alleviare, e al tempo stesso cronicizzare, un sentimento centrale del nostro tempo: la rassegnazione.
La sfida allora è riconoscere il malessere di una clinica senza soggetti, questo perché il Narcisista del You in realtà chiede sì di guarire, ma per tornare a aderire alle richieste dell’algoritmo. Il problema clinico si sposta dunque dal sintomo a: come non essere You; per questo diventa fondamentale interrogarsi su quale sia la differenza tra una mente analogica e una digitale. Gli autori lo fanno anche nella forma del libro, scritto e concepito da tre menti inquiete e con una prefazione dialogo: una relazione tra menti che pensano in relazione. Menti analogiche. La scrittura di un libro – scrive Miguel Benasayag – è un modo di agire. Il libro è un’azione.
Cos’è dunque questo Narcisismo del You? “È il narcisismo a cui ti riduce l’algoritmo, che ti fa vivere come un You continuamente bisognoso di gratificazione narcisistica che però non ha niente a che fare con te, con il tuo Io”. Il tema del digitale è stato spesso trattato nella letteratura psicoanalitica nei termini di una estensione protesica del concetto di virtualità, e cioè che tutto ciò che vive nello schermo è in qualche modo proiezione del nostro mondo interno. In altre parole, secondo questa prospettiva, il mondo digitale andrebbe visto un po’ come il mondo onirico. Gli autori non sono d’accordo, e io con loro, perché oggi sta succedendo qualcos’altro: il soggetto è completamente eclissato nello specchio opaco del Web, parlato dalla lingua fondamentale dell’algoritmo e sostituito dalla volontà altra dell’algoritmo stesso. La loro tesi è che il digitale non appartenga esclusivamente a questa dimensione virtual, e che non sia sempre al suo servizio, ma che si è arrivati a un ribaltamento tra le due dimensioni. Mentre tu credi di guardare il Web, non sei più tu il soggetto che guarda, ma è il Web che ti guarda. L’Io è reso oggetto dall’investimento digitale anziché libidico del Web: lo spettatore infatti è oscurato in un rispecchiamento infinito gratificante, l’utente del Web è la scelta oggettuale della macchina.
Pensate all’effetto sui piccoli di essere guardati, ma non visti dalla macchina. Se mi guardano ma non mi vedono, anch’io alla fine – se non mi riconosco nello sguardo dell’altro – mi guardo ma non riesco più a vedermi. Forse tutto questo sta anche alle origini del bisogno che hanno oggi i giovani di farsi i selfie, come se dovessero certificare una esistenza che dubita di sé stessa. Per essere visti da chi? Da milioni di utenti più o meno sconosciuti?
Nel 2006 il Time elegge la persona dell’anno pubblicando la copertina di un computer con uno specchio al posto dello schermo, con al centro la scritta You. Tutti siamo ormai nel You: un Io, che va concepito ormai come You, un popolo di You prigioniero della Rete, che vive più nel mondo virtuale – virtureale – che nella realtà. Sembra che siamo tutti vittime di un Pifferaio magico, che ci rende piacevole vivere da ritirati, perché molti giovani dicono di sentirsi meglio in questo altro mondo. Viene quindi da domandarsi se esisterebbe il ritiro sociale senza la Rete, cioè senza la gratificazione che procura lo spazio virtuale: il ritirato non sprofonda nel vuoto della clausura bensì nel pieno di un altro digitale che lo sta aspettando e che lo riempie di stimoli immersivi dando un senso alla sua esistenza. La propria camera rassicura i genitori e soddisfa le necessità di crescita: cameretta e tecnologia diventano un incrocio ideale per sperimentare bisogni relazionali in un ambiente percepito come protetto. Comprendiamo bene che il passaggio dalla protezione all’isolamento sociale è un attimo.
Questo fenomeno ha avuto un aumento esponenziale durante la pandemia, che ha messo in risalto un fenomeno già molto presente “il mondo digitale come un habitat più confortevole e rassicurante del mondo reale e che, talvolta, si pone come alternativa ad esso, anziché come spazio virtuale transizionale nel senso di stato preparatorio all’azione.”
È importante distinguere lo spazio transizionale come lo spazio del play, inteso come il gioco del come se, in contrapposizione allo spazio virtuale – lo spazio del game – dove il confine tra dentro e fuori svanisce, e dove il corpo rimane di qua. È il prezzo da pagare, perché il corpo è un rumore di fondo da smaterializzare. Al cuore di questa esperienza c’è la trasformazione del proprio Io in Avatar. È incredibile come ci sia uno stupro delle parole, perché le origini sanscrite di questo nome rimandano all’incarnazione di una divinità sulla terra, mentre qui si tratta di una non incarnazione nel Web, in quanto il corpo rimane di qua – è il prezzo da pagare – come ha descritto magistralmente il regista Steven Spielberg in Ready Player One.
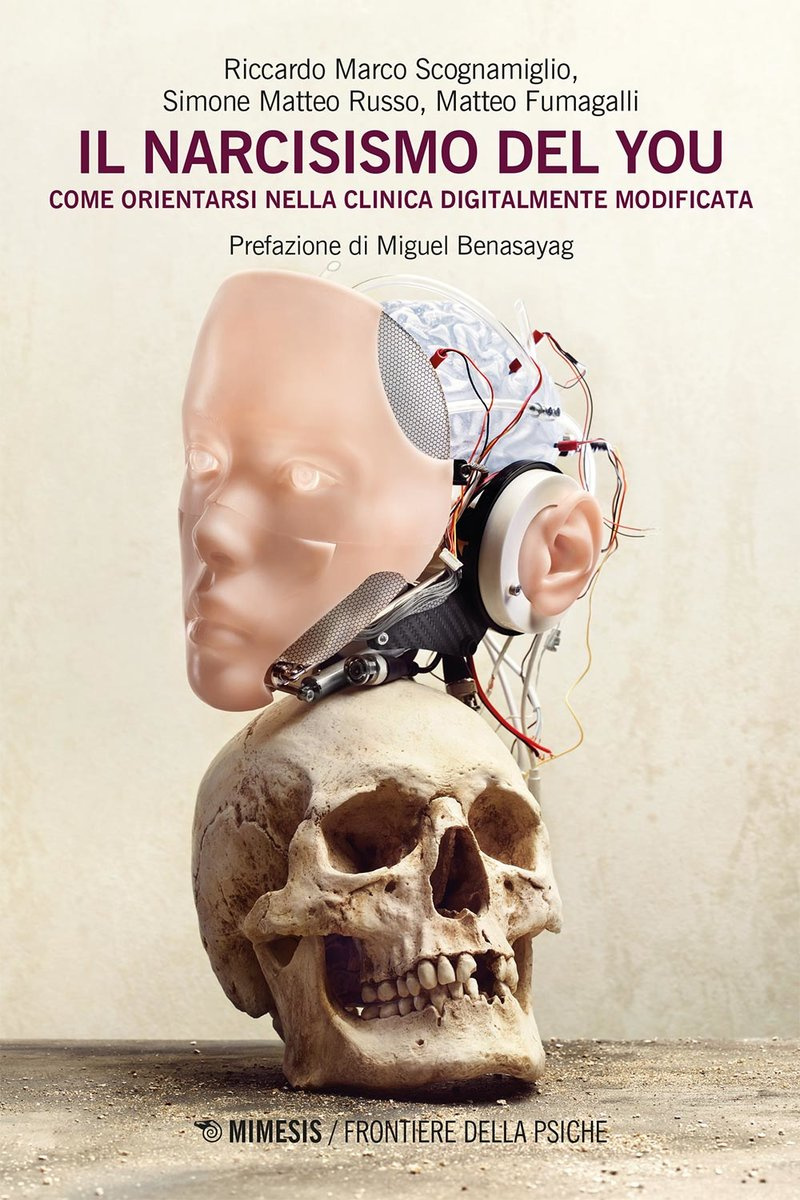
Qui non siamo più nel gioco come lo ha inteso Winnicott, come spazio transizionale che ha una funzione di passaggio e di cura, bensì nell’opposto: il virtuale disloca all’esterno, non nel mondo psichico, e non tiene insieme reale e simbolico – non è come se – il virtuale sospende e taglia i rapporti con la realtà. Nell’al di là del digitale si perde l’idea di gioco – di play – si fa sul serio, e questo accade perché nel digitale l’individuo perde i confini simbolici del gioco: reale e virtuale sono tutt’uno. Gli autori definiscono questo luogo virtureale.
Un altro punto fondamentale è che la Rete si pone oggi come un caregiver onnipotente e onnipresente, che ha preso il posto della famiglia come istituzione simbolica in un duplice senso perché, se da un lato gli adulti non sono più in grado di mantenere la verticalità della famiglia di una volta e di proteggere, da un altro lato stiamo assistendo anche al superamento dell’orizzontalità della famiglia affettiva – come hanno detto Matteo Lancini e Pietropolli Charmet – in quanto anche le funzioni di supporto e amorevolezza sono assorbite dal Web.
Nel deterioramento del tessuto simbolico, la digitalizzazione si è introdotta riempiendone i vuoti e creando nello stesso tempo un mondo protettivo comodo e di benessere immediato che ci distrae dalle angosce e dalle preoccupazioni per il futuro. Il Web come baby sitter.
La madre sufficientemente buona di Winnicott non è oggi più sufficiente a proteggere un figlio dalla presa profondamente adescatrice della rete, in quanto spesso le madri e i padri non solo non conoscono le logiche del mondo digitale, ma vi sono a loro volta immersi al punto di non cogliere l’effetto della tempesta di stimoli gratificanti prodotti dall’avere una relazione intima con il Web. Se per esempio diamo un tablet a un bambino l’iperstimolazione che il device è in grado di produrre non può competere con nessun genitore sufficientemente buono. Il coinvolgimento digitale è massivo e diretto a gratificare la sensorialità in una intensità incomparabile nel mondo reale.
Se diamo un tablet a un bambino di due anni considerandolo un oggetto buono, innocuo e stimolante, questo significa che non ne comprendiamo le conseguenze. Anche se l’impatto della tecnologia sullo sviluppo dell’infanzia rimane ancora in parte sconosciuto, e poche sono le ricerche sugli effetti dell’uso dei dispositivi nell’interazione genitore-bambino, sappiamo che i bambini che trascorrono i primi anni di vita più di un’ora al giorno davanti agli schermi hanno il 59% di probabilità in più di sviluppare problemi relazionali, e questo potrebbe avere effetti sullo sviluppo della loro capacità di socializzazione. Sembra anche che nei neonati con genitori che usano i media digitali, sia stata riscontrata una risposta emotiva molto simile a quella dei bambini con madri depresse. Chi usa il cellulare mentre allatta o interagisce col proprio bambino assume infatti comportamenti incongrui e inaspettati per il bambino, come immobilizzare il volto o cambiare espressione in relazione ai contenuti del cellulare. La risonanza della madre avverrebbe anzitutto con il cellulare – e con l’imprevedibilità del richiamo dopaminergico che proviene dai device – invece che col bambino.
Qual è la differenza tra apprendimento analogico e digitale? E quali sono le conseguenze?
Un esempio molto semplice per comprendere: la lettura di un orologio.
Se prendiamo un orologio analogico – cioè quello con una visualizzazione classica con le lancette per le ore, i minuti e secondi – sappiamo che per un bambino è complesso apprendere la lettura dell’ora in questo formato, al contrario di quanto avviene invece con l’orologio digitale, che mostra l’ora esatta. Per un bambino imparare l’ora analogica necessita l’acquisizione di un pensiero operatorio formale e di competenze metaforiche. Diversamente quando il bambino legge l’ora sull’orologio digitale il colpo d’occhio coglie subito il risultato finale, senza dover fare alcuna deduzione. Anche in un esempio come questo assistiamo alla sostituzione dei processi di comprensione metaforica di ciò che sta accadendo con meccanismi basati su schemi di azione-reazione, meccanismi utili nelle emergenze.
Già alla fine degli anni Ottanta Scognamiglio ipotizzava che l’allenamento al codice digitale poteva essere messo in correlazione con un fenomeno che stava cominciando a dilagare nelle scuole primarie: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
Per questo motivo lettura e scrittura sono molto importanti. Nella lettura viene richiesta una partecipazione intensa del lettore perché coinvolge la capacità immaginativa, e oltre la categoria del tempo nella lettura troviamo un rapporto diretto col corpo: quando leggiamo attentamente il nostro corpo si muove: “la lettura profonda di linguaggi altamente metaforici, come poesia o la narrativa, è in grado di attivare la corteccia somato-sensoriale, così come quella motoria.”
Viceversa l’intelligenza digitale è di tipo simultaneo. Le pratiche di lettura e scrittura fanno invece affidamento sull’intelligenza di tipo sequenziale.
La comunicazione del medium digitale quindi ci espone a un linguaggio percettivo che è più povero di significato, in quanto immediato e puntuale, rispetto al linguaggio concettuale. “Questa perdita di ambiguità e di astrazione nel processo di decodifica riguarda anche la capacità di leggere i processi impliciti di natura relazionale alla base per esempio dell’empatia: l’atto di assumere la prospettiva e le emozioni degli altri è uno dei contributi più intensi e meno riconosciuti dei processi di lettura profonda.”

L’empatia non è una competenza ereditata, ma in parte appresa, non dobbiamo dimenticarci del ruolo importante che può giocare la lettura nel suo sviluppo. Anche la scrittura – in particolare la scrittura in corsivo – è un potente strumento di stimolazione cerebrale, perché crea un concerto tra aree del cervello che non si ottiene con la scrittura digitale. Pensate a quanti ragazzi oggi scrivono in stampatello, o quando per aiutare chi ha problemi nell’apprendimento li consegniamo a una scrittura solo sul computer, o a quando si dice che è inutile insegnare a scrivere in corsivo. Non dimentichiamoci che le mani hanno una grossa rappresentazione nel cervello, e che l’uomo è Homo Faber perché usa le mani.
Sono questi tutti i requisiti alla base del pensiero critico: “Il codice digitale stimola maggiormente i moduli subcorticali e reticolari, cioè aree deputate alla reattività fisiologica ed emozionale.
Il codice analogico attiva moduli corticali superiori, come per esempio la corteccia prefrontale, deputata al giudizio, alla previsione del comportamento e al ragionamento.”
Le conseguenze dell’abuso del codice digitale le abbiamo davanti gli occhi.
Non possiamo non chiederci che cosa succede ai bambini di oggi che passano moltissime ore al giorno davanti ai device, e allenano il proprio cervello reattivamente e le proprie abilità senso-motorie nella direzione della digitazione?
Sebbene le ricerche siano ancora in fase iniziale, sta emergendo come l’uso eccessivo di Internet sia correlabile a una riduzione del volume della sostanza grigia nell’area neocorticale orbito-frontale sia destra che sinistra. “Questa parte del cervello, grazie alla sua connessione con l’amigdala, ha una funzione fondamentale nella regolazione dei comportamenti, nel ragionamento complesso e nei processi decisionali, ossia le cosiddette funzioni esecutive. Un danno a quest’area, infatti, può favorire una difficoltà nel controllo degli impulsi e nella gratificazione ritardata.”
La correlazione tra iper-connessione e fragilità psichica è stata sottolineata da molti studiosi e si parla ancora più provocatoriamente di demenza digitale, l’opposto quindi di una buona capacità di adattamento. Tutto questo fa disperare. Gli autori però pensano ci sia ancora una possibilità, ma al termine speranza preferiscono – citando la filosofa Donna Haraway – “rimanere lucidamente a contatto col problema”.
Gli autori ritengono che “la psicoterapia possa essere ancora un luogo di resistenza di ciò che dell’umano si sottrae all’algoritmo digitale”.
Ogni incontro con un individuo, da un punto di vista psicoterapeutico, comporta – dicono – una svolta ontologica, che significa prendere sul serio la realtà dell’altro come tale nella sua unicità.
La psicoanalisi si deve fare custode di quella dimensione profondamente umana, fatta di inciampi, tracce, deformazioni della realtà, dissociazioni, rimozioni e difese che non riusciamo ancora a immaginare possibile per la macchina. Quella che Benasayag ha chiamato la singolarità del vivente.
“Ma, se anche la macchina potesse arrivare a sognare, mancherebbe probabilmente della parte più umana del sogno: il suo “ombelico”, dove si inabissa il senso e la concatenazione logica delle rappresentazioni.” Qual è allora la sfida terapeutica? Prioritaria – secondo gli autori – è la costruzione di un’alleanza a partire dalla sintonizzazione affettiva tra i corpi. La mente del terapeuta nell’era digitale non può che essere una mente inquieta, che cerca di mantenere viva la relazione con l’altro: “l’unica via è di porci nel digitale per stabilire una relazione reale che rompa ‘il Narcisismo del You’ e ridia vita a un rapporto Io-Tu-Noi”.
In copertina, illustrazione di Marion Fayolle.

































Commenti recenti