Lessico Foucault. Ubuesco
di DOPPIOZERO (Andrea Cavalletti)
10 dicembre 1896: “Fischi? Sì! Urla furibonde e risate di scherno? Sì. Sedili pronti a volare sul palcoscenico? Sì. … E allusioni all’eterna imbecillità umana …? Sì. E il simbolo della bassezza di quell’inavvertito istinto che si fa tirannia? Sì. … Père Ubu esiste”.
Così Mendès – ci ricorda Alastair Brotchie – recensiva la prima, turbolenta messa in scena della pièce di Jarry. Quasi ottant’anni dopo, l’8 gennaio 1975, nell’aula augusta e affollata del Collège de France, risuonavano lunghe risate alla lettura di parole a loro tempo già solennemente scandite fra le mura dei tribunali. E Michel Foucault, che aveva aperto in quel modo il corso Les anormaux, poteva quindi commentare: «Non è la prima volta che il funzionamento della verità giudiziaria non soltanto costituisce un problema, ma fa ridere». Certo, il fatto che a suscitare ilarità fossero delle relazioni stilate anche dai più grandi nomi della psichiatria penale, e dotate del potere di decidere sulla libertà o la detenzione, o al limite la vita e la morte di un uomo, era decisamente degno d’attenzione. E se Foucault aveva apprestato quel canovaccio, sottoponendo gli ascoltatori a un test dall’esito prevedibile, era perché potessero riflettere sulla parte che avevano appena avuto in quella parodia. Nell’arco del ventennio precedente aveva scelto perciò due esempi opposti – uno, del 1955, relativo a un delitto grave (l’uccisione di una bambina), e uno molto recente, che rientrava invece nella routine dei ricatti a sfondo sessuale – per trarre la conclusione che «questi discorsi quotidiani di verità che uccidono e fanno ridere sono al centro della nostra istituzione giudiziaria». Iniziando quindi l’analisi di quel tratto essenzialmente grottesco, o “ubuesco”, delle perizie, aveva marcato, a scanso di equivoci, la propria distanza da Lacan: «Lasciamo che siano altri a porre la domanda sugli effetti di verità che possono essere prodotti, nel discorso, dal soggetto supposto sapere. Io cercherò piuttosto di studiare gli effetti di potere prodotti, nella realtà, da un discorso che è a sua volta statutario e squalificato».
A quale funzione corrisponde dunque questo duplice carattere? La risposta è come al solito semplice e sorprendente: consegnandosi al ridicolo, il discorso scientifico moderno si affianca a quello legale e lo duplica, facendo apparire sulla stessa scena del tribunale una serie di definizioni tipiche (“immaturità psicologia”, “personalità poco strutturata”, ma anche “manifestazione d’orgoglio pervertito”, “alcibiadismo”, “bovarismo”, “dongiovannismo”…) che sostituiscono all’atto la condotta, o meglio ne costituiscono un doppio “tautologico”, dunque all’infrazione vera e propria un bersaglio psicologico-morale. Il gioco di verità muta così e si rinnova: al problema puramente legale dell’accertamento della responsabilità subentra quello della definizione del carattere, ovvero della pericolosità di un individuo che può essere più o meno esposto alla sanzione, più o meno curabile o riadattabile. L’abbassamento grottesco del sapere medico risponde, in altre parole, a un’esigenza precisa: permette il suo innesto sul sapere giudiziario, quindi uno spostamento preliminare dell’accertamento della verità dal soggetto accusato, colpevole o no, al soggetto pericoloso, delinquente, che sarà d’ora in poi l’oggetto di una nuova e specifica tecnologia di potere.
Certo, la lunga indagine sui meccanismi tesi a «difendere la società», che Foucault stava svolgendo almeno dall’inizio degli anni ’70, raggiunge qui uno dei suoi momenti salienti, e si potrebbe anche osservare che l’aspetto grottesco risulti decisivo nel passaggio dal modello puramente disciplinare o normativo a quello regolativo della normalizzazione. Non solo: se il corso del 1976 si concluderà con l’analisi della società nazista quale sintesi del vecchio diritto sovrano di uccidere e della protezione biopolitica, illuminando nello sviluppo parossistico dei totalitarismi un «gioco iscritto effettivamente nel funzionamento di tutti gli Stati», già nel contesto apparentemente estraneo di quella prima lezione del ’75 Foucault evoca la figura dell’omuncolo dalle mani tremanti, che rinchiuso nel suo bunker berlinese impartisce infine due ordini: che tutto ciò che resta sopra di lui sia distrutto e dei dolci al cioccolato. Sovranità infame, squalificata, grottesca, e sviluppo totalitario o diffusione capillare (anche attraverso la delazione) del diritto di uccidere non sarebbero dunque, come la protezione della vita e l’esposizione alla morte, che le due facce della stessa medaglia. Attraverso l’analisi delle expertises psichiatriche Foucault restituisce, cioè, una categoria storico-politica fondamentale, iscritta anch’essa nella meccanica generale degli Stati, poiché non concerne esclusivamente il caso limite della sovranità arbitraria, ma la stessa «macchina amministrativa che, con i suoi effetti di potere inaggirabili, passa attraverso il funzionario mediocre, nullo, imbecille, superficiale, ridicolo, fallito, povero, impotente». Ubueschi sono infatti «gli elementi essenziali delle burocrazie occidentali dal XIX secolo in poi». Al mondo del sottosuolo appartengono il capo e i funzionari: «il grottesco amministrativo non è stato semplicemente quella specie di percezione visionaria dell’amministrazione che hanno potuto avere Balzac, Dostoevskij, Courteline o Kafka».

Nell’uno o nell’altro caso, o nella loro congiunzione, negli effetti collaboranti del lavorio burocratico e del delirio sovrano, l’indegnità non solo non impedisce al potere di esercitarsi, né limita i suoi effetti, come poteva accadere nei rituali ridicolizzanti delle società arcaiche. Rispetto a questi – e Foucault segna ora la propria distanza da Pierre Clastres – le liturgie ubuesche delle nostre società hanno anzi una funzione esattamente opposta: si tratta ora di «manifestare in maniera eclatante l’inaggirabilità, l’inevitabilità del potere, che può precisamente funzionare in tutto il suo rigore e al culmine della sua razionalità violenta anche quando è nelle mani di qualcuno che si trova effettivamente squalificato».
La logica è chiara, come l’importanza e l’ampiezza del tema, e si comprende che Foucault abbia deciso di non affrontarlo direttamente («Je n’ai la force, ni le courage, ni le temps…») per concentrarsi invece sul volto ridicolo della psichiatria penale. Ma cosa fare con questo problema «dell’enorme funzionamento del sovrano infame» che egli ci ha in qualche modo lasciato in eredità? Problema tanto antico – «da Nerone a Eliogabalo» in poi – quanto scottante, certo, e a sua volta incontournable. Problema del rapporto con un esercizio di potere che tanto più forte si dimostra, tanto più appare grottesco; e che d’altra parte più saprà rendersi risibile – gli esempi si affollano alla mente – e più diventerà invincibile. Abbiamo letto tutti Thomas Mann e ricordiamo la figura grottesca di Cipolla-Mussolini… Più da vicino, abbiamo tutti visto i nostri modesti Ubu e, assistendo alle stragi perpetrate da governanti infami nella più abietta abitudine all’impotenza, non possiamo pronunciare una frase che – proprio come questa – non sottintenda il suo Merdre!
Problema, dunque, della potenzialità maligna di capi dalla miseria tanto evidente quanto ambigua e traditrice e problema prima ancora nostro, esattamente foucaultiano della soggettivazione-assoggettamento, del soggetto di questo potere infame, delle auspicabili resistenze, e, infine, o prima di tutto, problema della costituzione di sé dello stesso soggetto che se lo pone e lo indaga. Problema amplissimo, potremmo aggiungere ancora, in cui dispositivi di potere e di sapere si incrociano in nuove combinazioni, ovvero in cui si produce la coppia efficiente potere-sapere. E insieme problema del modo in cui anche gli individui (chi è irriso, chi irride) si agganciano l’uno all’altro, subendo e insieme affermando questo potere, come se la macchiettistica inettitudine restasse non solo indifferente alla forza corrosiva dello scherno, ma la ripiegasse su se stessa. Problema, cioè, del tratto suggestivo della soggettivazione: chi scherza su chi (intenzionalmente o no) si espone al ridicolo e cede al suo gioco, non limita ma aumenta il suo potere, poiché sminuire, ridimensionare, significa credere all’insuperabilità di ciò che funziona malgrado (o anche attraverso) la sua stessa riduzione ai minimi termini. Problema dell’infamia come rovesciamento efficiente della gloria, o della più rovinosa perdita dell’aura come effetto a sua volta e paradossalmente auratico; inganno di chi capisce che il serpente non è che un bastone nodoso quando era proprio il primo a farsi per lui legno volgare. Ricordiamo ancora la sagoma deforme e il «viso affilato e sciupato» di Cipolla, o dai vecchi filmati il cranio del duce nuotatore spuntare dall’acqua «nei primi rigori invernali» come il torso di Starace dal cerchio di fuoco: Foucault ci spiega che la chiave della suggestione non è nello sguardo che ammalia, ma nell’aspetto dimesso o nel gesto ridicolo; ci insegna che non solo vi è un aspetto suggestivo della soggettivazione, ma l’esercizio degli apparati suggestivi – esasperato nei totalitarismi perché iscritto nel funzionamento di tutti gli Stati – è una modalità della soggettivazione fondata sulla reazione al ridicolo, sul grottesco come marchio di un potere insuperabile. E se l’automatismo (lo scatto, il salto, il gesto “atletico”, il braccio teso del dottor Stranamore) che fa somigliare la persona a una cosa viene corretto dal riso, come insegnava Bergson, la correzione, potremmo chiosare, è appunto “sociale”, normalizza, riporta tutto al meccanismo vigente… e può essere a sua volta meccanica.
Allora smettere di ridere? Rassegnarsi? Restare composti di fronte alla bassezza e alla imbecillità feroce? Siamo già sempre in troppi a farlo, si sa, e proprio questa serietà da parata è oggetto dei lazzi, più o meno mormorati, dei refrattari. Ma, soprattutto, si ricorderà a proposito una pagina di Gilles Deleuze: Foucault, il nuoveau cartographe, rideva dei meccanismi diabolici, dei discorsi cinici, degli orrori minuziosamente elaborati, poiché di fronte alla «divina commedia delle punizioni», a invenzioni tanto perverse, è un «diritto elementare essere affascinati fino al riso folle». Perciò Sorvegliare e punire è «pieno di gioia, di un giubilo che si confonde con lo splendore dello stile e la politica del contenuto» e questa, spiegava ancora Deleuze, non è una felicità ambivalente di chi è soddisfatto di odiare, ma «la gioia che vuole distruggere ciò che mutila la vita».
L’introduzione della categoria del grottesco al centro della storia dei poteri si traduce quindi nella posizione del problema non aggirabile del saper ridere, o non ridere. Problema essenzialmente politico dell’umorismo, che può essere noir o, come anche disse Breton, humour objectif. È il problema di Foucault? Ed è lo studio dei meccanismi di potere o la scrittura del saggio, che egli ha interpretato come askesis o esercizio di sé, a dischiuderne la soluzione? In ogni caso, è il problema che Foucault ci ha consegnato, ed era il problema di Ubu, o meglio di Jarry. Per risolverlo, ricorda ancora Brotchie, questi mise a punto in vista della première un piano meticoloso: «Avendo deciso che gli serviva avere tra il pubblico qualcuno che non facesse parte della sua cerchia di amici, incaricò i patrons del locale di formare una contro-claque … Jarry disse loro: “lo scandalo dev’essere più grande di quello di Fedra o di Hernani. Lo spettacolo non deve arrivare alla fine, il teatro deve esplodere”. Se la pièce fosse stata accolta bene, questa contro-claque avrebbe dovuto dare libero sfogo alle proteste e dare segni di estatica ammirazione qualora il pubblico avesse fischiato. Avrebbe provocato risse con i vicini e lanciato proiettili dalla galleria sulla gente seduta in poltrona».
Dalla battaglia che in effetti si scatenò possiamo ancora trarre una lezione: far scoppiare il teatro in questo modo non significa, infatti, che distruggere gioiosamente ciò che mutila la vita.
Certo, quando l’esibizione degli Ubu è come oggi così abituale, pervasiva, contagiosa, suscita ben poca ilarità. Proprio per questo, però, dev’essere restituita al riso, ma accompagnata da un contro-riso capace di riconoscere nel primo una resa prossima, malgrado tutto, alla silente e più ordinaria accettazione. Anche la truce serietà del fascismo può innescare infatti, e come si sa, una reazione peculiare, e a sua volta automatica (che sarà quindi oggetto di correzione). Ma proprio questa prima risposta (certo, simile a quella immediata degli uditori del Collège de France) può trasformarsi in riso finalmente e davvero lieto; ovvero: in oggetto di interrogazione (perché ridiamo? perché – chiede Foucault – il potere fa ridere?) e di indagine. Proprio quel riso può essere nello stesso tempo un contro-riso, non perché resta in fondo inquieto e serioso, ma perché coincide con l’analisi del meccanismo che lo provoca. Alla nostra soggettivazione grottesca risponde solo l’esercizio gioioso e distruttivo, il saggio, la gioia trasmessa da una pagina di Sorvegliare e punire, cioè la scrittura o l’insegnamento come «prova modificatrice di sé nel gioco della verità». Sì, père Ubu esiste, e da lungo tempo, da ben prima di quel dicembre 1896, e conosce mille metamorfosi e si aggira ovunque; soltanto, non era in cattedra l’8 gennaio 1975, in quella distruzione in cui non volarono poltrone.
In copertina, illustrazione di Silvia Polidori.
FONTE:https://www.doppiozero.com/lessico-foucault-ubuesco


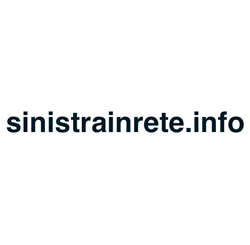





























Commenti recenti