Sia in Italia che nel resto del mondo si torna a parlare di Università. Viviamo tempi difficili, che evidentemente impongono una riflessione sui processi di formazione della gioventù. Spesso, il discorso sull’Università è in negativo, insiste cioè sui difetti dell’istituzione più che proporre una via promettente da percorrere. Non è detto, però, che le critiche non possano suggerire indirettamente delle proposte. Il punto centrale che accomuna nel seguitocritiche diverse tra loro è costituito dal ritenere che l’alta formazione dovrebbe essere basata sul merito scientifico e il rigore culturale, e che questi debbano contribuire alla formazione di un pensiero critico, mentre invece spesso così non è. In particolare, le critiche che prenderemo in considerazione, di fondo, pongono la questione dell’autonomia della sfera accademica, e delle storture che tendono a prodursi quando questa autonomia viene compressa da logiche e metodi che provengono da altri ambiti.
2. Troppa ideologia cancella il merito
Partiamo quindi dagli argomenti critici sull’Università. Il primo lo possiamo trovare in un intervento di un famoso storico, Niall Ferguson, intervento dedicato al tradimento degli intellettuali. Questo tradimento è quello che ha dato la stura alla ‘cancel culture’ e agli atteggiamenti ‘woke’ nelle maggiori Università degli Stati Uniti. Come sappiamo, questi sono cultura e atteggiamenti anti-Occidentali, in nome dell’antirazzismo, dell’antisessismo, dell’anticolonialismo e via di seguito. L’aspetto apparentemente peggiore del wokismo in questione è costituito dalla sua indole censoria. Tutto ciò contribuisce a creare un clima di intimidazione e timore che di certo non favorisce la vita accademica.
Ma -sostiene Ferguson- c’è molto di più da stigmatizzare. Il vero tradimento degli intellettuali, ai suoi occhi, consiste nel fatto di sostituire il merito scientifico con altri criteri -come quelli legati a genere, razza e sostanzialmente identità- nella selezione del personale accademico (i professori) e nel contenuto didattico. Proprio quegli intellettuali che dovrebbero avere più caro di tutti il valore e il significato del sapere finiscono così con civettare con criteri diversi. Con la conseguenza di peggiorare la qualità dell’offerta formativa, del corpo docente, del materiale didattico e alla fine degli studenti. Ma la vis polemica di Ferguson non si arresta qui. Perché, sempre a parer suo, la tendenza attuale è foriera di conseguenze politiche potenzialmente disastrose. Cancel culture e atteggiamenti woke, con i loro effetti politici, somiglierebbero infatti in maniera notevole a quanto successo nelle Università tedesche prima del Nazismo (erano allora le migliori del mondo come probabilmente ora lo sono Harvard, Princeton, Yale di cui parla Ferguson). La critica di Ferguson è rivolta principalmente alle grandi università anglosassoni, ma non è affatto priva di presa sull’università italiana. I recenti episodi di eventi accademici sulla guerra in Medioriente ‘cancellati’ a causa delle proteste, a prescindere da cosa si pensi nel merito sulla questione, ne sono un segno evidente.
Anche se il parallelo con la Germania degli anni Trenta appare assai discutibile, tuttavia le osservazioni di Ferguson, nel loro complesso, non sono prive di fondamento. La formazione di una coscienza critica non può avvenire in un clima di censura reale o di auto-censura preventiva delle idee di professori e studenti. Il rispetto reciproco, la non-violenza, e la massima libertà di espressione sono presupposti indispensabili per il funzionamento di un sistema di formazione terziaria. Nelle università si deve poter pensare liberamente anche a costo di ‘offendere’ le sensibilità di alcuni.
Allo stesso tempo va fatto notare che, sempre in ragione della loro natura progettuale, nelle università, l’intervento massivo delle forze dell’ordine per combattere fenomeni di protesta da parte degli studenti ideologicamente impegnati andrebbe fortemente limitato, se non del tutto evitato. Detto altrimenti, la logica della contrapposizione identitaria e sanzionatoria adottata da alcuni e le risposte repressive messe in campo da altri per porvi rimedio costituiscono una politicizzazione delle università nel senso deteriore del termine. In questo modo, società civili sempre più polarizzate trovano un altro luogo dove esprimere le loro divisioni politiche comprimendo di fatto l’autonomia della sfera accademica.
3. Una discutibile burocratizzazione competitiva
Una seconda critica origina invece dal modo in cui è stata progressivamente interpretata l’idea di accountability pubblica (la capacità de rendere conto) nel contesto universitario. Detto altrimenti, se l’intervento dei pubblici poteri è essenziale per mantenere viva la missione propria delle università, ci si deve certamente interrogare sul modo in cui ciò debba avvenire.
Il modello prevalente di accountability pubblica attualmente in voga è ispirato al New Public Management in Higher Education (NPM) di matrice britannica (dai tempi di Mrs. Thatcher). Lo si constata seguendo l’andamento del cosiddetto Bologna Process (dal 1999) e la creazione della European Higher Education Area (EHEA). In entrambi i casi, prevale l’apertura dell’Università alla società civile e al mercato come era stato del resto anticipato dalla Magna Charta Universitatum (1988) e dalla Lisbon Recognition Convention (1997).
Questo modello di accountability, come vedremo, pone però dei problemi sia dal punto di vista degli scopi che dei mezzi adoperati (in Italia sono note le critiche degli animatori del sito Roars). In termini generali, NPM tende a ridurre l’autonomia accademica e scientifica delle università -quella tipica dell’approccio di sociologia della cultura alla Merton- e a rendere il mondo universitario più omogeneo a quello di altri settori oggetto di politiche pubbliche come, per esempio, la sanità. Questa riduzione della specificità accademica dovrebbe avvenire attraverso l’introduzione di standard di misura quantitativi e qualitativi omogenei e sempre più indipendenti dalle valutazioni scientifiche dei professori. L’esito consiste nel trasformare un’attività formativa e culturale in un coacervo di misure, attentamente monitorate da esterni. Una conseguenza diretta di questa scelta consiste nella creazione di comitati e strutture – del tipo dell’italiana ANVUR (agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) -di solito nominati dallo Stato (tramite il Ministero) con il compito di uniformare e orientare il lavoro delle istituzioni accademiche.
Il funzionamento del sistema universitario britannico prima e dopo gli anni 1970, quelli in cui fu introdotto NPM, illustra bene la differenza tra il metodo precedente, basato sull’autonomia universitaria e sul monopolio degli esperti, e quello dopo l’avvento di NPM. Prima degli anni 1970, lo stato erogava un bilancio pubblico globale che destinava allo UGC (University Grant Committee), un comitato di professori che distribuiva le risorse in base a criteri scientifici e culturali interni al mondo accademico tradizionalmente inteso. Come si potrebbe dire, in questa versione il processo di selezione e finanziamento è tutto endogeno all’universo accademico. Dalla nascita di NPM, invece, lo stato e la politica entrano direttamente nella gestione della vicenda, con l’intenzione di dirigere e influenzare la ricerca e la didattica delle Università. Il sospetto viene gettato sui professori, e il sistema dell’alta formazione diventa più simile a quello degli altri comparti della pubblica amministrazione. In questa ottica, all’Università viene richiesto un supplemento di capacità manageriale e nel complesso un aumento di produttività. Richieste che si accompagnano alla ricerca di forme ulteriori di finanziamenti sul mercato. L’appello alla società civile, così generato, rende più ampio il numero degli stakeholdersignificativi nei processi di formazione della volontà accademica e meno indipendente il sistema dell’alta formazione nel suo complesso.
Da questo punto di vista, due questioni aperte sono evidenti nel sistema accademico. Si tratta, in primo luogo, della controversia che verte sulla natura della Università che oscilla sempre tra una concezione idealistica e culturalistica da una parte e una meramente strumentale (formare lavoratori immediatamente occupabili, rendere soddisfatti gli studenti-clienti, raccogliere fondi privati etc.) dall’altra. In secondo luogo, c’è una tensione che caratterizza il modello organizzativo in rapporto alle due concezioni di cui sopra. In questo caso, la tensione è quella tra un modello di gestione amministrativo-burocratico da una parte e un modello basato maggiormente sull’autonomia della ricerca e dell’insegnamento dall’altra. In questa prospettiva, la colpa attribuita al modello NPM è di solito quella di privilegiare eccessivamente la visione strumentale delle istituzioni accademiche, di imporre un primato dell’amministrazione sulla cultura e la ricerca all’interno delle università, e così facendo di costituire un altro importante tassello nella limitazione dell’autonomia accademica. In Italia, così la vita universitaria è costituita -come esperito da ogni professore- da un numero infinito di verbali, monitoraggi e stime, indici, relazioni astruse, linee-guida non si sa a che, ma anche di numerosissime riunioni per formulare fantomatici piani didattici, e cercare di seguire il ritmo bizzarro delle modifiche normative del Ministero, oppure a redigere “Piani strategici”, “Piani di sviluppo”, e simili più o meno incomprensibili documenti destinati a convincere le autorità istituzionali e eventuali sponsor aziendali. In altre parole, la ragionevole richiesta di accountability da parte del pubblico rischia di impedire lo scopo principale dell’Università, che è legato al riconoscimento del merito scientifico e al perseguimento degli obiettivi culturali che gli sono propri.
Lo strumento di controllo pubblico, in sostanza, finisce troppo spesso per essere a danno della qualità della docenza e dei programmi di studio, e per conseguenza della formazione dello studente. Il formalismo strumentale -favorito dal modello NPM- collocherebbe il sistema universitario nell’ambito di una burocratizzazione competitiva, ossia di una fusione fra i valori della competizione di mercato e i metodi della pubblica amministrazione. Con il
menzionato ANVUR che contribuisce coi suoi controlli non alla qualità della ricerca ma a mettere in competizione gli Atenei e i Dipartimenti tra di loro, il tutto basandosi su criteri quantitativi e/o qualitativi di dubbia utilità che servirebbero a pesare le pubblicazioni (col risultato che nessuno è invitato a leggerle), e a migliorare la qualità dell’offerta formativa, per poter aspirare a quote premiale crescenti (in termini relativi) ma sempre esigue (in termini assoluti) di risorse pubbliche.
Questa burocratizzazione competitiva ignora i problemi di fondo dell’Università, come il sottofinanziamento della ricerca (di recente evidenziato dalla Presidente Della CRUI Iannantuoni in un’intervista a Repubblica), la percentuale troppo bassa di laureati nel Paese, la questione delle aule e strutture spesso inadeguate se non fatiscenti, la scarsità delle risorse dedicate al diritto allo studio. Ma quello che è peggio in questo modo si sacrifica la cosa più importante, sarebbe a dire la formazione di un autentico pensiero critico.
In tutti i casi, sembra impossibile non interpretare alcuni degli eccessi burocratici degli ultimi quindici anni come il risultato di una forte perdita di fiducia nei confronti della serietà della classe docente e ricercatrice. In questa ottica, i professori, alla stregua di molte altre categorie del pubblico impiego, vengono delegittimati come nullafacenti ai quali viene concessa eccessiva libertà. Si aumentano quindi i controlli.
Il risultato di questo atteggiamento finisce con l’essere paradossale. Coloro che hanno abusato della loro libertà accademica troveranno certamente un modo di continuare a farlo, mentre coloro che, e sono la maggioranza, l’hanno usata responsabilmente, si sottoporranno con altrettanto senso del dovere ai nuovi adempimenti che gli vengono richiesti. Il risultato complessivo è che i primi continuano a comportarsi come prima, mentre i secondi hanno meno tempo per fare quello che hanno sempre fatto e che devono fare, e cioè studiare, pensare, scrivere, insegnare. Anche se non è esattamente un teorema, ci pare giusto ricordare che, sovente, normare un ambito della società civile partendo dall’assunto che coloro che ne fanno parte siano dei malintenzionati ha come prevedibile risultato quello di punire o quantomeno penalizzare sistematicamente solo coloro che al suo interno non lo sono.
4. Per concludere
Abbiamo detto all’inizio che il rinnovato e benvenuto interesse per l’Università prende spesso lo spunto da critiche a questo o quell’aspetto del sistema accademico. Anche perciò, per dirla con Montale, dobbiamo partire da ciò che non siamo, da ciò che non vogliamo. Non vogliamo un’Università troppo ideologica che limiti la libertà di espressione e che non consideri il merito accademico e scientifico come il punto di partenza per qualsiasi visione della alta formazione. Non siamo pronti ad accettare una visione economicistica e puramente strumentale dell’Università, in cui lo studente è considerato solo ed esclusivamente cliente e futuro lavoratore.
Nelle società contemporanee, le persone occupano più ruoli. Sono in primo luogo individui che portano con sé un bagaglio di esperienze, non ultime fra di esse, esperienze culturali. Sono poi cittadini che debbono partecipare alla vita politica del paese. Sono certamente anche lavoratori che avranno bisogno di trovare una collocazione all’interno di un sistema produttivo. La formazione terziaria non deve rinunciare al tentativo di contribuire allo sviluppo delle capacità di ognuno di occupare questi ruoli in maniera consapevole. Lo sviluppo di una coscienza critica, in questo senso, non fa tanto riferimento a un contenuto quanto piuttosto a un metodo. La sfida non consiste nello scegliere quale ‘parte’ delle persone si voglia coltivare all’interno delle università, ma nel far crescere in maniera bilanciata l’autonomia di individui che occupano ruoli diversi.
Per ottenere questi scopi, è importante che la sfera pubblica stabilisca delle regole da rispettare. Tuttavia, queste regole pubbliche non devono trasformarsi in una gabbia iper-burocratica, che nasconda i problemi reali dell’Università, primo tra tutti quello di mantenere al centro del progetto istituzionale lo studio e la riflessione. Tenere assieme accountability pubblica e indipendenza delle università è certamente un compito complesso. Il tentativo -magari astratto ma non privo di significato- dovrebbe essere quello di spostare l’attenzione dalla ricerca dell’eccellenza a quella della decenza; di non incentivare la competizione, ma di evitare abusi e storture. Intendiamoci, questo non significa che le università non debbano premiare il merito accademico, o che i ricercatori che le popolano non debbano aspirare a fare il meglio possibile con la libertà che gli viene (o quantomeno dovrebbe essere) concessa. Significa invece che il ruolo dello Stato e delle sue regole non è quello di spiegare a chi studia e lavora nelle istituzioni di alta formazione quali siano i modi migliori di perseguire le virtù che dovrebbero caratterizzare le pratiche accademiche ma bensì quello di evitare che di questa libertà si faccia un uso improprio. Che cosa vuol dire questo in concreto? Innanzitutto, attenzionare chi scientificamente non produce nulla per lunghi periodi, chi rende l’esperienza formativa degli studenti sistematicamente inaccettabile, chi non partecipa mai agli oneri della gestione dell’istituzione.
In tutti i casi, a ben vedere, c’è un aspetto in comune nelle due critiche da cui siamo partiti, aspetto che consiste nella volontà di non arrendersi a derive ideologiche e di non accontentarsi di un governo degli algoritmi amministrativi. Con la consapevolezza che l’oggetto principale dell’alta formazione consiste nel mettere il merito scientifico e la capacità culturale al centro del progetto generale. Il che ci porta non troppo lontano dagli ideali di chi, come von Humboldt, ha inventato il modello dell’Università che noi conosciamo. Un lascito che non va interpretato in termini di libertà in una torre di avorio (Freiheit und Einsamkeit), ma piuttosto come ragionevole equilibrio tra autonomia, cooperazione e rispetto di standard condivisi. La questione dell’equilibrio tra autonomia accademica, cambiamenti delle società civili, e controllo pubblico è insieme fondamentale e complessa. Non può essere risolta né nella prospettiva di un’autonomia spiritualistica della cultura né in quella di una sistematica invasione da parte di logiche provenienti da altre parti della società civile accompagnate da un disciplinamento burocratico-amministrativo da parte dello Stato.

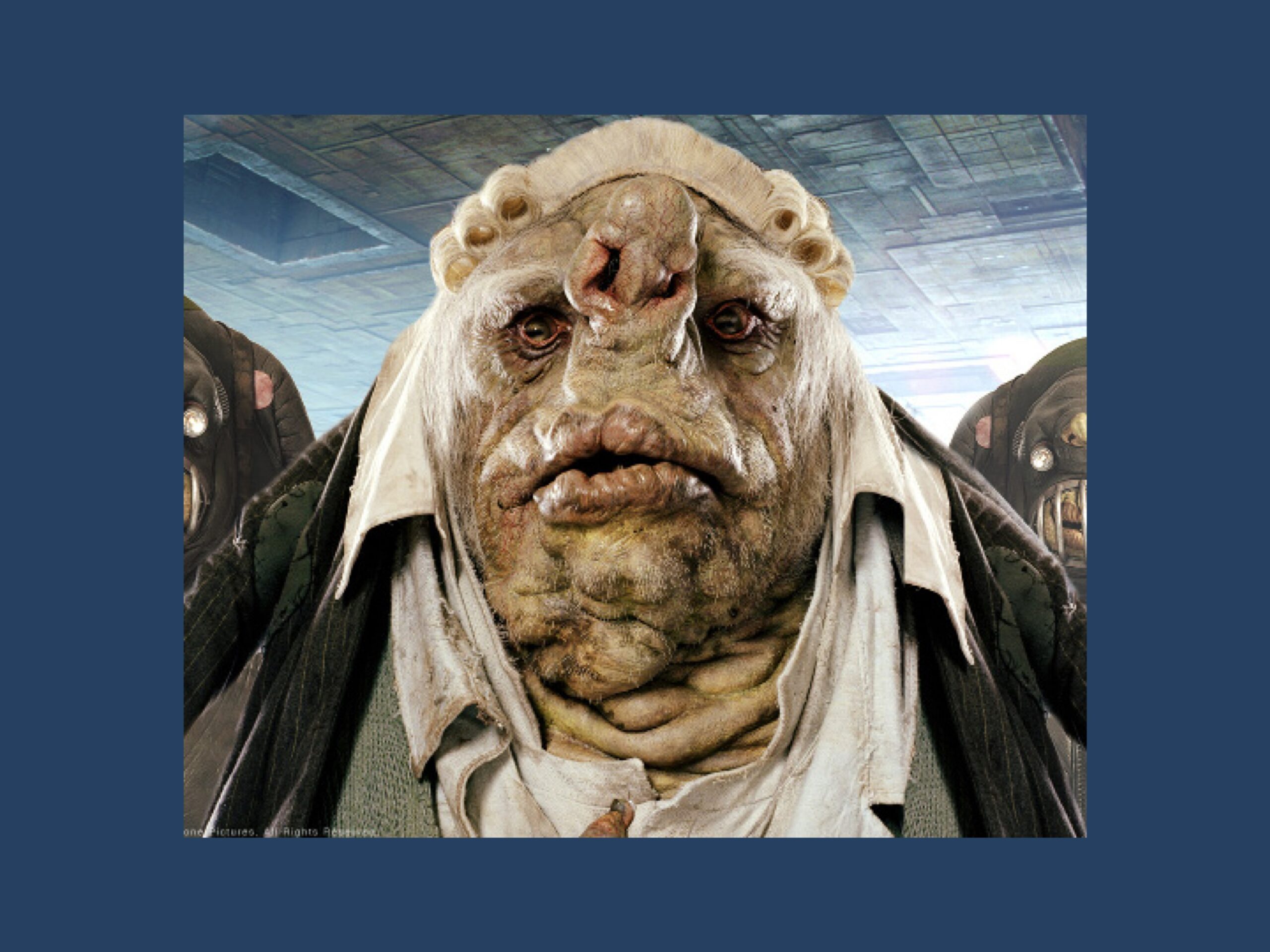































Commenti recenti