Perché sono su Instagram
di LE PAROLE E LE COSE (Francesco Pecoraro)
 (a cura di Maria Teresa Carbone)
(a cura di Maria Teresa Carbone)
[Secondo rilevazioni già obsolete – settembre 2017 – Instagram avrebbe 800 milioni di utenti nel mondo. Più donne che uomini, più urbani che rurali, più giovani che anziani. Così precisa la voce di Wikipedia, ma questi dati sono addirittura del 2014, quando la popolazione instagrammese era meno della metà di quella attuale.
In fondo, degli abitanti di Instagram, entità sovranazionale più popolosa dell’intero continente europeo, sappiamo solo che hanno un congegno per fotografare – uno smartphone, nella stragrande maggioranza dei casi – e che lo usano ogni volta che vedono un oggetto degno di attenzione: se stessi, i loro gatti e i loro cani, la torta di compleanno, il sole al tramonto, la stazione di servizio illuminata di notte, il vagone graffitato della metro…
E sappiamo che questa massa di immagini (circa cento milioni di foto caricate ogni giorno) non è neutra. Di certo sta cambiando il mondo – le facce, i vestiti, le architetture, gli arredi, oggi sono aggiustati o concepiti per essere instagrammabili al meglio. Ma forse ha un effetto anche sullo sguardo degli adepti di questa neofotografia, nella misura in cui prima lo scatto e poi il confronto con gli altri scatti costringono gli occhi a una maggiore attenzione.
(Una ricerca britannica dell’anno scorso, condotta su 1500 adolescenti, ha concluso che Instagram è massimamente ansiogeno). Nasce da qui l’idea di una piccola indagine condotta presso scrittori, fotografi e cultori a vario titolo della materia ai quali sono state poste alcune domande: Perché sei su Instagram? Come definiresti la tua galleria? Con quale strumento scatti le tue fotografie per Instagram? In base a quali criteri metti i like alle foto? Il tuo modo di fare fotografie o di concepire la fotografia è cambiato da quando sei su Instagram? Cosa pensi di Instagram come fenomeno sociale? Cosa significa secondo te?
Cominciamo oggi con le risposte in forma di articolo date da Francesco Pecoraro, la cui pagina Instagram è questa (Maria Teresa Carbone)]
**************
Sono su Instagram forse da un paio d’anni. Prima non sapevo bene di cosa si trattasse e nemmeno adesso so bene cosa sia, a cosa serva. Sulle prime credevo fosse un’applicazione per far sembrare più belle le foto e non, come poi ho scoperto, una specie di social. Su Facebook, che ho frequentato fino a due anni fa, circolavano queste immagini trattate con filtri Instagram, quindi tutte belle uguali, tutte somiglianti a fotogrammi di un film di Tony Scott: luce gialla, ombre blu, forti contrasti, cieli cangianti. Per questo e altri motivi me ne sono tenuto alla larga. La mia antica formazione modernista mi fa percepire ogni artificio come falsificante.
Quando fui saturo di Fb—ma non prima di aver litigato con un caro amico a causa di una certa sopra-elevazione romana—, ne uscii e subito dopo caddi in quella che definirei una crisi di astinenza da social. Non avendo una vita sociale nel real-mondo, senza Fb avevo perso ogni forma di attività relazionale. Non mi illudevo di recuperarla su Instagram, ma almeno lì avrei potuto mostrare a qualcuno le molte foto che avevo scattato nel corso degli anni, ottenere qualche like, inter-agire con altri produttori di immagini e insomma esistere in rete, anche se in modo del tutto marginale.
Cosa me ne importasse dei like e cosa tuttora me ne importi, non l’ho ben chiaro. Il like, il cuoricino, è considerabile come un’unità minima se non di presenza affettiva, almeno di assenso, un quantum rarefatto leggero confortante, di vicinanza amicale, di remunerazione egotica: è stata una giornata di merda, non ho combinato nulla, ma stamane una mia fotina ho preso 30 like.
Ero uscito da Facebook perché mi piaceva troppo e l’impegno che mi richiedeva stava succhiando le energie che mi servono per il mio lavoro di scrivente. Con le foto sarebbe stato diverso: avrei avuto un’esistenza digitale, ma molto meno impegnativa e soprattutto priva di parole. Sarebbe stato un po’ come scambiarsi figurine: ne avevo da parte migliaia e continuavo a scattarne.
Faccio foto principalmente con il cellulare e con una buona tascabile, che però lascio quasi sempre a casa: più lo strumento è di qualità più una foto richiede tempo ed è difficile da fare. Da anni non uso più la reflex. Troppo pesante e ingombrante per i miei scatti estemporanei: ci ho messo molto a capire che inseguendo la qualità dell’immagine sarei stato solo uno dei tanti fotografi dilettanti che non hanno né il tempo, né la competenza tecnica di usare al meglio macchine costose. Quindi, mi sono detto, la fotografia è per i professionisti, a me non resta che prendere appunti sul visibile.
Chiarito che posto i miei scatti per ottenere dei like, vengo al punto: perché scatto e cosa c’è nei miei scatti?

Alla prima domanda risponderei che lo faccio perché posso farlo, perché la tecnologia contemporanea mi fornisce uno strumento duttile e intelligente per farlo. Le chiamiamo fotografie ma tutti sanno che non hanno quasi più niente a che vedere con ciò che designa questo termine. Le difficoltà tecniche della fotografia analogica, su cui del resto si fondava la sua estetica, sono quasi del tutto scomparse. La tecnica digitale ci consente di produrre immagini e di condividerle all’istante. A seguito di un lungo percorso di costruzione di una personale sensibilità visiva (ho una formazione da architetto), il mio occhio è diventato suscettibile alla presenza luminosa e volumetrica di ciò che vedo e se vedo qualcosa di interessante scatto. Il problema risiede nel fatto che quasi tutto ciò che vedo mi sembra interessante.
Tuttavia mi sforzo di selezionare il flusso percettivo che mi investe istante per istante. Quindi alla seconda domanda risponderei che nelle mie foto ci sono in genere tre tipi di paesaggi: l’insignificanza del quotidiano, la plasticità delle lesioni delle automobili, il volto degli animali morti con cui vengo in contatto al mercato, soprattutto pesci, conigli, polli. Mentre quest’ultima categoria di soggetti ha l’intento di sommuovere e denunciare, le prime due, soprattutto la prima, cercano di rintracciare qualcosa di estetico in ciò che è del tutto comune ma che, in determinate condizioni di luce e accuratamente traguardato e inquadrato—possibilmente in modalità frontale, dunque possibilmente ritratte in vera forma (aborro la nostra condanna biologica alla deformazione prospettica)—, può acquisire, se non uno stupefatto anti-significato, la dignitas formale di gioco sapiente di volumi sotto la luce (LC).
Con questo progetto in testa, per ottenere anche un minimo risultato, occorre osservare e scattare molte immagini di roba spietatamente insignificante, soggetti non umani, formalmente nulli, cui conferire un non-significato misterioso ma comunicabile, cioè capace di arrivare all’osservatore. In questo lavorio fotografico apparentemente distratto ci entra un bel po’ di incoerenza e di concessione allo sdato, e perfino alla bellezza, come quando ho passato quasi una giornata intera a scattare foto, mai postate in rete, dei Dioscuri di Montecavallo.
Su Instagram ho modo di seguire le ricerche altrui, talvolta più o meno casualmente imparentate con la mia, o la mia con la loro. Uso la parola ricerca perché, nel loro apparente piccolo, pur sempre di ricerche si tratta. Posto più o meno tre immagini al giorno. Qualcuno mi ha fatto notare che forse sono troppe. Probabilmente è vero, ma non voglio conferire importanza allo scatto singolo rispetto al flusso di cui fa parte: sono convinto che in rete occorra liberarsi dall’idea di opera e occorra privilegiare il continuum rispetto all’unicum. Può capitare di costruire un’immagine più interessante delle altre: se accade c’è qualcosa che non va nell’atteggiamento con cui l’ho scattata. Il narcisismo mi spinge a postarla lo stesso, ma sono circostanze di solito segretamente imbarazzanti: una foto che va oltre i 30 like costituisce una discontinuità rispetto al flusso.
È il flusso che conta, non mi interessa la bellezza, inseguo la fissità dell’insignificanza in un mondo, il mio, quasi del tutto insignificante, lurido, mal fatto, convenzionale, maltenuto, pretenzioso, lesionato. Non voglio abbellirlo, voglio rendere la sua, per così dire, medietà sotto la luce. Quindi cerco di lasciare fuori dall’immagine, non sempre riuscendoci, sia la bellezza che la bruttezza conclamate.

In certi serate italiane d’inverno, dopo un pomeriggio limpidissimo invaso dalla luce bassa accecante del solstizio, quando ogni cosa, persino un’automobile ferma al semaforo, rivela una connotazione ultima e metafisica, noto che le bacheche dei miei contatti si riempiono di immagini di case e cieli, nuvole, alberi, muri assolati, e di qualsiasi altra cosa illuminata da quei momenti speciali, come se tutti noi, ciascuno vivendosi la propria giornata e le proprie specifiche vicende, ci fossimo fermati per un attimo a contemplare ciò che ci circonda, chiedendoci se per caso non fossimo finiti su Marte.
Non ho niente contro i selfie, ma quasi sempre mi annoiano, non sto su Instagram per pubblicare selfie o panorami di vacanza, bambini sulla spiaggia, gatti & piatti, foto sexy, istantanee di tavolate-incubo in trattorie di cui si intuisce il riverbero acustico. Non disprezzo questo tipo di figure. Ognuno usa i social come vuole. Il mio non è un portfolio, non un album, non un’auto-biografia, è solo un flusso, un trasferimento di immagini, trascelte e minimamente manipolate, tra le molte che scatto. Non c’è una logica, non c’è uno scopo se non quello di condividere, di scambiare materiali con contatti che mi paiono interessanti e di scoprire ricerche analoghe che mi aiutino a riflettere meglio su ciò che faccio.
Credo che la fotografia, ormai da decenni indistinguibile/indistinta dall’arte tout court, c’entri poco con i materiali presenti su Instagram, anche se alcuni artisti vi segnalano regolarmente le loro opere, anche fotografiche. Non credo che Instagram, o qualche sito analogo, possa avere una funzione accrescitiva della consapevolezza estetica di massa: chi non ha una cultura visiva non se la costruisce in rete, ma la rete aiuta a trovare materiali visivi. Il problema è che l’infinita accessibilità alle riproduzioni di opere e manufatti tende a rendere misteriosamente tutto uguale, in una sequenza, interiore e rapidissima, di mi piace/non mi piace, in cui sono coinvolte anche opere ritenute maggiori e sempiterne. È come se le nostre capacità percettive e di giudizio si siano progressivamente adattate alla modalità binaria del like.
Cerco di resistere (non riuscendoci) alla tentazione di spacciare le immagini postate come componenti di un’estetica: fingo che si tratti solo di sequenze paratattiche, elenchi di oggetti ripresi frontalmente in buone condizioni di luce. In fondo il senso dei miei scatti su Instagram è di stare-su-Instagram, cioè di darsi come materiali fruibili in un paio di secondi di attenzione, anche meno, che è grosso modo il tempo che ci mettiamo a decidere se regalare o no un like alle immagini altrui. Tempo che si allunga, ma capita raramente, quando sono bellissime.

Temo i social e la rete perché stanno rapidamente segnando le nostre menti e lo stanno facendo in una direzione imprevedibile. Ma non posso fare a meno di starci, perché mi attraggono in modo irresistibile e perché starne fuori non aiuta certamente a capirli meglio. Mi accorgo che capirli è termine improprio: la rete è incomprensibile, i social sono per ora inconoscibili, ciascuno di noi ha cognizione solo di una piccolissima porzione tribal-amicale, una capsula culturalmente omogenea creata dall’algoritmo per farci sentire a nostro agio e darci modo di confermare ogni giorno le nostre convinzioni o di farle derivare impercettibilmente.
Però sappiamo che la rete, essendo un luogo di affluenza di massa, sottostà alle grandi leggi del contagio mentale e del comportamento gregario, le stesse secondo cui hanno sempre agito/non-agito le masse. Oggi le nostre città, a parte qualche sporadico uccisore fuori di testa, sono apparentemente calme, calmissime, ma basta andare su un social e quella che ci sembra una mattinata tranquilla si rivela un oceano in tempesta percorso da ondate di odio.
Ma Instagram mi pare immune dal fenomeno degli odiatori. Forse è una percezione dovuta all’omogeneità algoritmica della sfera dei miei contatti, che è solo una porzione infinitesima dell’iconosfera che ormai avvolge il pianeta in più strati, fatta con miliardi di immagini, di video, di file sonori, che a ogni istante si accumulano uno sull’altro nei banchi di memoria della rete, dove il mio minuscolo atollo relazionale costituisce un appartato appagante infantilizzato universo.
Fonte:http://www.leparoleelecose.it/?p=31117#more-31117




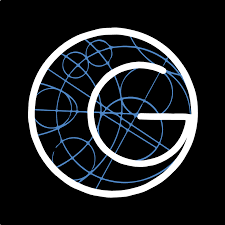



























Commenti recenti