Il lavoro ci interessa, ma pure il salario
di JACOBIN ITALIA (Teresa Battista)

In un editoriale del “Corriere della sera” Ferruccio De Bortoli sostiene che il lavoro c’è, a mancare sono i giovani talenti interessati a lavorare. Ma la realtà è un’altra e parla di precarietà, basse retribuzioni ed emigrazioni dall’Italia
Pare che i liberali del nostro paese non possano fare a meno di biasimare quotidianamente disoccupati e poveri, quali soggetti privi di ogni etica e intrinsecamente oziosi, scansafatiche. Proprio qualche giorno fa dalle pagine del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli si lancia in un’invettiva contro la classe lavoratrice precaria e disoccupata, usando come alibi il discusso e discutibile “reddito di cittadinanza” da poco approvato dal governo, quale meccanismo che disincentiverebbe i disoccupati a darsi da fare e accettare le centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili. Insomma, parafrasando il titolo dell’articolo citato, secondo lui il lavoro c’è ma non ci interessa. Figuriamoci con un po’ di reddito di sudditanza a disposizione.
Le argomentazioni adottate discendono direttamente dalla teoria neoclassica secondo cui un aumento dei sussidi ridurrebbe l’incentivo per i disoccupati a cercare lavoro perché potrebbero godere di un reddito seppur modesto, rifiutando la fatica del lavoro a cui sono costretti dalla propria condizione sociale. Tuttavia, la realtà e la ricerca scientifica smentiscono ormai da decenni questi argomenti. Il tentativo di riportare i fatti dentro il guscio ideologico del liberismo appare sempre più goffo e velleitario. Vale però la pena ricordare che il contrasto a una politica di sussidi in caso di disoccupazione e/o disagio sociale fa parte di quella corrente teorica che vede ogni protezione delle condizioni di vita dei lavoratori, e più in generale delle fasce subalterne della società, come uno spreco che inibisce il buon operare del mercato e la competitività delle imprese. Abbiamo già visto dove la pluridecennale liberalizzazione e flessibilizzazione del lavoro ci ha portati, con il mondo del lavoro come bersaglio privilegiato delle politiche di deflazione e austerità, di cui fanno parte il blocco del turnover nella pubblica amministrazione e l’esternalizzazione di ampi servizi pubblici.
Tutto questo De Bortoli non riesce a vederlo o non sa vederlo o preferisce non vederlo, facendosi cullare dalle stime e dai moniti del padronato italiano: «Confindustria ha stimato che saranno poco meno di 200 mila le posizioni più qualificate a disposizione, nel triennio 2019-21, nei settori della meccanica, Ict, alimentare, tessile, chimica, legno-arredo, ovvero le sei produzioni trainanti del Made in Italy. Ma una su tre rischia di restare vuota. Perché mancano i talenti».
Sono le previsioni dell’ufficio studi della maggiore associazione datoriale italiana, lo stesso che all’alba del referendum costituzionale dichiarava che in caso di vittoria del No avremmo perso oltre 600 mila posti di lavoro. In realtà li abbiamo guadagnati quei posti di lavoro ma erano (sono) tutti precari. E soprattutto il tanto decantato Made in Italy è una cassettiera svuotata di senso e nient’affatto in buona salute, basti considerare la svendita dei grandi marchi del lusso del tessile a imprese straniere.
Lasciandoci il passato alle spalle, è giusto fare i conti con il presente per scrivere il futuro. Bisogna allora ascoltare le parole del vice presidente di Confindustria per il capitale umano (sic!), tal Giovanni Brugnoli, che, oltre quanto riportato da De Bortoli, invita i giovani italiani a «scegliere i centri di formazione professionale, le scuole, gli Its e le università che sono più aperte al mondo del lavoro e che valorizzano il know-how e le tecnologie delle imprese». Andare a scuola insomma, ma possibilmente solo a quella dell’obbligo per diventare operai modello, o in quelle supine alle esigenze d’impresa, ai loro umori e rendite. Un’idea di scuola che potrebbe sembrare bizzarra ai più distratti ma che invece è quella che negli anni hanno disegnato attraverso le riforme del sistema scolastico, le stesse che hanno deciso che i percorsi professionali dovessero essere porto di scarico per i figli di nessuno, quelli che forse è meglio se abbandonano il ciclo di studi ancor prima di terminarlo così si riducono i costi per il già scarno bilancio pubblico destinato all’istruzione. Gli stessi che capita veder morire sotto un muletto o chissà dove in un’azienda che non ha più neppure la responsabilità di garantire la vita dei propri lavoratori.
Le parole di Brugnoli esprimono tutta la miopia delle rappresentanze padronali, quelle per cui uno studente di filosofia non è in grado di intendere e volere dal punto di vista della produzione dei profitti. E che dire degli ingegneri, degli scienziati politici, degli informatici, dei chimici, degli statistici? Il suo non è anti-intellettualismo, è disconnessione storica. Una ritrovata forma di negazionismo o terrorismo psicologico: brandendo lo spettro della piena automazione. Mansioni che invece non spariranno, come dimostra l’ultimo rapporto sul tema di Cedefop-Eurofound, e che avranno sempre più a che fare con le macchine, con le tecnologie ma che saranno sempre più routinarie e standardizzate. Trasformando i lavoratori in accessori della macchina e per questo più facilmente sostituibili da altri meno remunerati all’interno degli attuali rapporti di forza. A margine di questa discussione rimangono altre questioni di non poco conto: in un sistema in cui tutti i guadagni, tutti i meriti, tutte le rendite sono privatizzate perché mai è lo stato a dover garantire le competenze indispensabili all’accumulazione di profitti privati e non invece proprio le aziende che ne beneficiano? Perché lo stato e quindi le sue istituzioni formative è specchio dei rapporti di forza.
Per De Bortoli, «dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2018, sono 1,1 milioni i nuovi contratti a tempo indeterminato». Falso! leggendo l’allegato statistico del rapporto sulle Comunicazioni Obbligatorie citato dallo stesso De Bortoli, si nota che nei dodici mesi considerati, le attivazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono 1.559.558 a cui però corrispondono esattamente 2.011.980 cessazioni, cioè il saldo netto di rapporti di lavoro è -1.178.488. Tralasciamo anche questa eclatante imprecisione, degna delle memorabili gaffe dell’ex Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Ma sorvoliamo anche sull’algebra come opinione e torniamo ai famigerati dati sui posti di lavoro disponibili e che non interessano ai giovani.
«I ristoranti richiedono, in questo mese di gennaio, 11 mila camerieri. In 23 casi su 100 non si trovano. Se i locali fossero a Londra avrebbero la fila di ragazzi, anche laureati, italiani. E così per gli aiuti cuoco: il 42 per cento non c’è». Sono parole pesanti queste di De Bortoli e allo stesso tempo offensive. Tra il 1997 e il 2017 sono emigrati dall’Italia 1.203.719 individui (fonte Istat). È come se fosse scomparsa l’intera popolazione di Milano. Stime peraltro cospicuamente al ribasso perché includono solo coloro che hanno effettuato la registrazione anagrafica presso il paese di destinazione. Un’evasione a tutti gli effetti che non può essere banalizzata in locuzioni come la “fuga dei cervelli” o “le possibilità di movimento permesse dal Mercato Unico Europeo”. Come nota Enrico Pugliese nel suo ultimo saggio Quelli che se ne vanno (Il Mulino, 2018), se all’inizio degli anni Duemila l’emigrazione poteva essere ricondotta principalmente alla mobilità volontaria, negli ultimi anni è rappresentata da «giovani e meno giovani del Nord e del Sud in fuga dalla crisi». Lo ribadisce l’Istat nel suo rapporto annuale: «I motivi che spingono l’emigrato (italiano o straniero) a lasciare il Paese sono da ricercarsi nella scarsità di risorse, ma anche nelle diverse opportunità offerte dal mercato del lavoro, nella mancanza di innovazioni tecnologiche nei settori primario, secondario e terziario. Sono da ricercarsi, inoltre, anche nella necessità di ottenere i mezzi indispensabili per la sopravvivenza, nella volontà di seguire le proprie ambizioni, nella ricerca di migliori condizioni di vita, abitative, di istruzione e di salute». Questo vale per i laureati e per chi ha un titolo di studio inferiore.
L’emigrazione è sempre meno una scelta e sempre più una necessità, la negazione del diritto di poter scegliere in quale paese costruire la propria vita e il proprio futuro. Fare il cameriere o il lavapiatti è un lavoro faticoso, usurante e mal pagato, praticamente ovunque. Eppure in altri paesi europei, a differenza dell’Italia, si dà il caso che seppure da fame una retribuzione esista, così come un contratto di lavoro. Ma soprattutto, l’aumento del numero di laureati italiani in fila per un posto da lavapiatti in una città straniera è un dato che andrebbe preso sul serio e non dileggiato. E se è vero, come continuano a tuonare, che l’istruzione è motore della crescita non si capisce perché le responsabilità di questa generazione in fuga, la più istruita della storia d’Italia, debbano essere scaricate sulle vittime, ancora una volta derise, e non invece su quella borghesia che ha scelto la via del declino industriale del nostro paese. Mentre il fenomeno migratorio ha storicamente investito maggiormente le regioni meridionali, i dati del 2017 indicano che a partire verso l’estero sono nel 54% dei casi cittadini residenti al Nord, seguiti nel 28% dei casi dai cittadini del Mezzogiorno, Isole comprese. Insomma, neppure le regioni forti dell’economia nazionale sembrano essere in grado di garantire una vita dignitosa ai propri cittadini, che preferiscono farsi sfruttare all’estero.
Nei settori dei servizi a bassa produttività come l’alberghiero e la ristorazione, cioè quelli dove secondo De Bortoli mancano lavoratori, tra il 2009 e il terzo trimestre del 2018 si è avuto un aumento dell’occupazione pari a 442.000 unità, il 70% dell’occupazione totale netta nel periodo, cioè scontando per la riduzione registrata il settore manifatturiero e quello dell’amministrazione pubblica. Sono gli stessi settori in cui la quota di lavoratori a termine sul totale è aumentata vertiginosamente soprattutto per la fascia di età tra i 15 e i 34 anni. Nel 2008 i lavoratori a termine erano il 25%, dopo nove anni il 38%. Facile fare i moralisti con la precarietà degli altri. Considerando che dei contratti a termine fanno parte anche quelli a chiamata, e parliamo di un settore in cui il lavoro è spesso e volentieri grigio: pagato un po’ regolarmente un po’ in nero, dove i contratti collettivi nazionali con quel che rimane dei diritti sulle ore lavorate, sugli straordinari, sui turni sono solo un miraggio.
A scarseggiare non sarebbero solo i camerieri, «ma anche agenti immobiliari, promotori commerciali, che non sono lavori così umili e disagevoli». Non sappiamo quante volte De Bortoli abbia chiesto a queste figure le proprie condizioni di lavoro. Ma potrebbe scoprire senza troppa difficoltà che i promotori commerciali sono fin troppo spesso lavoratori pagati a cottimo, in base ai contratti che riescono a stipulare. La loro paga base è spesso ridotta a un misero rimborso spese, ben inferiore alle insufficienti cifre del reddito di cittadinanza, ma soprattutto inadeguata a garantire l’accesso a quelli che dovrebbero essere diritti sociali di base, come la casa, che tuttavia devono essere soddisfatti sul mercato, a prezzi crescenti. Va un po’ meglio per gli agenti immobiliari il cui inquadramento permette ancora, o quantomeno più di frequente, un ancoraggio ai contratti collettivi nazionali.
E che dire dell’affermazione secondo cui «tra i conducenti di furgoni (basta la patente) la metà non si trova»? Fattorini, autotrasportatori, sfruttati del settore della logistica, quelli assunti con contratti rumeni. Evidentemente tra gli innumerevoli scandali, questo non ha avuto eco sul giornale della buona borghesia italiana. Il presidente di una cooperativa, imprenditore del varesotto, figura mitologica dell’imprenditorialità italiana, è stato «accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, costringeva gli autisti a lavorare fino a venti ore consecutive violando, di conseguenza, la normativa sui tempi di guida e di riposo». Come dichiarato nel comunicato delle indagini, l’imprenditore costringeva gli autisti a «condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno».
Queste sono le condizioni di lavoro diffuse nei settori dove qualche lavoratore benché disoccupato non è disposto a farsi sfruttare. Scagliarsi contro di loro non fa che infiammare il disagio nel paese e aumentare la già più che legittima avversione nei confronti di un’élite che dall’agio dei propri divani pontifica e moralizza chi un divano non può permetterselo. Ma quel che stupisce è che dalla prospettiva da cui punta il dito De Bortoli è assente l’ordine di grandezza dei fenomeni sociali, come la disoccupazione che conta a fine del terzo trimestre del 2018 non i duemila camerieri che mancano nei quartieri gentrificati di Milano o Napoli, ma 2,4 milioni di persone.
Questi sono i numeri su cui discutere. Ma per farlo bisogna abbandonare la prospettiva teorica e politica dei liberisti italiani che contano i posti vacanti (pochi) e non quelli distrutti e mai creati (troppi) a causa delle politiche economiche fin qui adottate. Sono tutte le vittime del blocco del turnover (insegnanti, medici, infermieri, educatori, programmatori, ingegneri, idraulici, ecc.) nella pubblica amministrazione, quelle decine di migliaia di lavoratori che ogni anno, senza speranza per mancanza di posti, affollano i concorsi pubblici. Dati a cui i grandi quotidiani non dedicano editoriali – e col senno di poi potremmo dire che è quasi un bene! Si rimettesse al centro del dibattito politico la questione salariale, dato che non solo nel periodo di recessione ma anche tra il 2016 e il 2017, quando la ripresa era sbandierata da buona parte dei benestanti, i salari sono diminuiti mediamente dell’1,1%, mentre negli altri paesi aumentavano. E non è un caso nè una novità: l’ultimo rapporto Censis ha stimato che tra il 2000 e il 2017 i salari sono aumentati di soli 400 euro, un decimo rispetto a Francia e Germania.
È questa la catastrofe sociale che sta alla base del risentimento, di quel “sovranismo psicologico” come lo definì il Censis stesso, dell’abbraccio mortale degli elettori verso il governo giallo-verde che le parole di De Bortoli non fanno che alimentare.
*Teresa Battista, giacobina.
L’illustrazione è di Antonio Pronostico.
Fonte: https://jacobinitalia.it/il-lavoro-ci-interessa-ma-pure-il-salario/




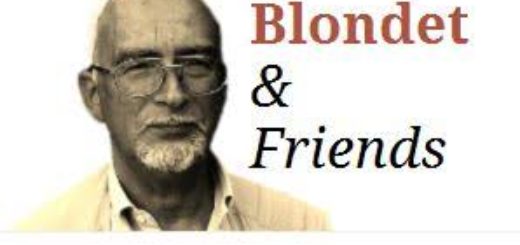



























Commenti recenti