di VOCI DALL’ESTERO (Alberto Bagnai)
Nel primo dei due capitoli scritti per L’euro est-il mort?, libro pubblicato in Francia che raccoglie i contributi di più autori coordinati dall’economista Jacques Sapir, Alberto Bagnai – ben noto ai nostri lettori per il blog Goofynomics e presidente dell’associazione a/simmetrie – analizza la crisi dell’eurozona con l’aiuto dell’esperienza italiana, particolarmente utile da due punti di vista: perché l’Italia stessa è un’unione monetaria che non è un’area valutaria ottimale e ne ha già sperimentato le conseguenze; e perché le élite italiane hanno dichiarato molto esplicitamente quali erano, dal loro punto di vista, gli obiettivi dell’unione europea: utilizzare il vincolo esterno legato alla moneta unica per orientare il processo democratico e in questo modo la distribuzione del reddito. Senza il “sogno europeo”, il “ce lo chiede l’Europa” e le crisi generate dalla moneta unica non sarebbe stato possibile realizzare il programma di “riforme strutturali” che hanno indebolito e impoverito i lavoratori e in generale le fasce di popolazione più deboli. Il vero successo dell’euro, amaramente, è stato questo.
L’euro e il declino dell’economia italiana
Adam Smith ce l’aveva ben detto, nel terzo capitolo del primo libro de «La ricchezza delle nazioni»: la divisione del lavoro è limitata dalla dimensione del mercato. Non ci si può aspettare che un produttore privo di sbocchi sul mercato sia spinto ad adottare innovazioni e quindi aumentare la produttività. A che cosa gli servirebbe produrre di più, o produrre a un costo più basso, se non ha qualcuno a cui vendere? La produttività non è una questione puramente esogena o tecnica. Nell’economia classica (Smith), come in quella keynesiana, e, ci permettiamo di aggiungere, nell’economia tout court, la produttività dipende anche dalla domanda.
Che cosa c’entra questo con l’Italia?
L’evento che più salta all’occhio nell’economia italiana degli ultimi trent’anni è senza dubbio l’improvviso arresto del tasso di crescita della produttività del lavoro, che si manifesta poco dopo la metà degli anni 90. Dal 1971 al 1996 la produttività del lavoro era aumentata a un tasso medio annuale del 2.7%, non lontano dal 3.0% della Francia e dal 2.9% della Germania. Tra il 1997 e il 2010 il tasso di crescita in Italia crolla allo 0.3%, mentre rimane all’1.4% in Francia e all’1.3% in Germania. È nel 1997 che comincia il declino dell’economia italiana, questo è un fatto così evidente che anche i sostenitori dell’euro sono costretti ad ammetterlo. In effetti il 1997 è un anno cruciale nel percorso verso la moneta unica. I paesi candidati infatti si erano impegnati ad adottare, nei due anni precedenti all’entrata in vigore dell’euro, una parità fissa rispetto all’ECU. Questo punto determinante sfugge ai più: per quello che riguarda il rapporto tra i paesi europei, l’euro in effetti ha inizio nel 1997, perché è a partire da questa data che i tassi di cambio tra i futuri paesi membri sono resi fissi (con margini di oscillazione molto ridotti).
La rigidità del tasso di cambio comporta una riduzione pressoché immediata del tasso di crescita delle esportazioni. La chiusura degli sbocchi sui mercati esteri, dove i prodotti italiani diventavano progressivamente sempre meno competitivi, produsse gli effetti che erano già chiari a Smith nel XVIII secolo, e sarebbero stati studiati più approfonditamente da Kaldor nel XIX: un circolo vizioso di caduta della produttività, che provoca una caduta della competitività, che causa una caduta delle esportazioni, che comporta un ulteriore calo della produttività. La crescita media dell’economia italiana tra il 1980 e il 1997 era stata del 2.3%. Dal 1997 alla crisi del 2009 scende all’1.3%. Se si tiene conto anche degli anni della crisi, dal 1997 al 2015 la crescita media è stata dello 0.4%. Il PIL nel 2015 era uguale a quello del 2000. L’Italia è tornata indietro di 15 anni e questa catastrofe senza precedenti nella sua storia e senza uguali oggi nell’eurozona dipende in larga misura dal fatto che la crisi ha colpito un’economia sofferente e in declino. Un declino che coincide con ciò che ne è stato la causa: l’adozione de facto dell’euro.[i]
L’Italia e l’europeismo
Forse è per questo che, quando si affronta l’argomento dell’euro in Italia, è ormai difficile trovare qualcuno disposto a sostenere che la moneta unica ci protegge dalle crisi. I fatti dimostrano che argomenti economici di questo tipo erano falsi. Chi difende il progetto ora cerca piuttosto di mettere in rilievo la sua dimensione politica, che sarebbe soprattutto quella di favorire il superamento degli Stati-nazione. Questi ultimi, ci dicono, sarebbero la causa dei conflitti. Di conseguenza, per assicurare la pace ai popoli europei, bisogna spazzare via il «nazionalismo», creando un immenso Stato federale, di cui l’euro sarebbe un simbolo. In più, questo aiuterebbe gli Stati «piccoli», come l’Italia, a difendersi meglio dai «grandi» paesi emergenti. Diversi politologi (in particolare Majone e Zielonka) sottolineano che questo implica un modo di ragionare un po’ assurdo: per combattere il nazionalismo si ricorre a un nazionalismo di ordine superiore[ii].
I grandi Stati federali, così come li conosciamo, derivano soprattutto dall’antico impero britannico (Stati Uniti, Canada, Australia, India). In realtà sono Stati-nazione, dove la lingua e le istituzioni inglesi sono dominanti (con l’eccezione dell’India, dove le differenti culture locali sono state difficili da sradicare e dove quindi la struttura federale non ha consentito di evitare numerosi conflitti). In Europa, gli Stati-nazione si affermano con i Trattati di Westfalia (1648), che misero termine alle guerre di religione. Le loro costituzioni sono uno strumento di protezione dei diritti fondamentali, a cui sarebbe pericoloso rinunciare senza sapere esattamente da che cosa sarebbero sostituite. È stata la Nato, e non l’Europa, che ci ha assicurato fino a oggi un lungo periodo di pace (o meglio, di guerra fredda), e tra le cause dell’ultima guerra mondiale c’è stato l’errore che Keynes aveva denunciato in anticipo: schiacciare la Germania sotto il suo debito di guerra.[iii] Prostrare un paese sotto il peso di un debito insostenibile: è esattamente lo stesso errore che si sta ripetendo oggi con la Grecia, e questo per salvaguardare l’euro «che porta la pace».
C’è forse del metodo, in questa follia europeista. In fondo, tutte le unioni monetarie sono, per definizione, strumenti di integrazione finanziaria, concepiti per facilitare il libero movimento dei capitali. Ora, la liberalizzazione dei movimenti dei capitali comporta una compressione dei redditi da lavoro[iv]. L’accanimento con cui le élite europee difendono la moneta unica, nonostante i suoi limiti evidenti, potrebbe quindi spiegarsi con la volontà di proteggere i profitti a spese dei salari.
Certo, si tratta di un obiettivo politicamente legittimo. Tuttavia, due cose dovrebbero metterci in guardia. Da una parte, il fatto che ormai la Banca centrale europea (BCE) si preoccupa per le conseguenze negative dei bassi salari sulla deflazione, e quindi sulla ripresa dell’economia europea.[v] Forse il bel gioco è durato troppo? Dall’altra, dovrebbe allarmarci il modo sottilmente sleale attraverso il quale il progetto europeo è stato presentato come qualcosa di cui non si poteva neppure discutere, viste le sue nobili intenzioni (garantire la pace) e le cui conseguenze economiche sarebbero andate a vantaggio delle classi sociali più deboli (perché l’euro le avrebbe «protette», e la «grande Europa politica» li avrebbe aiutati a combattere il «grande capitale internazionale»).
Nell’analisi dell’attuale vicolo cieco in cui si trova l’Europa, l’esperienza italiana può aiutarci. Nel percorso storico e politico italiano, due elementi sono a mio parere utili a questo scopo. Il primo è che l’Italia, proprio come la zona euro della quale fa parte, è essa stessa un’unione monetaria, che non è un’area valutaria ottimale, a causa delle profonde differenze strutturali tra Nord e Sud del paese. Gli italiani vivono quotidianamente i problemi che sorgono quando regioni troppo diverse si riuniscono sotto una stessa moneta, e hanno dovuto imparare ad affrontare questi problemi. Il secondo è che le élite italiane hanno dichiarato molto esplicitamente quali erano, dal loro punto di vista, gli obiettivi dell’unione europea. Si trattava, infatti, di utilizzare il vincolo esterno legato alla moneta unica per orientare il processo democratico e in questo modo la distribuzione del reddito. Se, come fa osservare Featherstone, dalla creazione – nel 1979 – del sistema monetario europeo il vincolo esterno in Europa è stato applicato un po’ dappertutto per influenzare le politiche nazionali, la sua filosofia politica non è mai stata espressa così chiaramente come dagli esponenti politici italiani (al punto che perfino nella letteratura scientifica internazionale si usa l’espressione italiana «vincolo esterno»).[vi]
L’Italia come unione monetaria
Nel 2006, uno studio della Banca d’Italia faceva osservare che 145 anni dopo l’unificazione monetaria dell’Italia (realizzata contemporaneamente all’unificazione politica), i livelli dei prezzi e i tassi d’inflazione nelle differenti regioni e province non convergevano ancora del tutto.[vii] Un fenomeno molto intrigante. Infatti, stando alla teoria economica ortodossa, a determinare il livello dei prezzi è la quantità di moneta circolante. Sarebbe dunque logico attendersi che a una moneta unica corrisponda un livello di prezzi, o almeno un’inflazione, unici. Questo studio mostra che in Italia non va affatto così. Uno studio successivo mostrò che la medesima cosa succedeva su scala europea, dove si assiste a una divisione dei paesi in tre «club d’inflazione»: i paesi del Nord (che convergono verso un’ inflazione bassa), l’Italia (con un’inflazione media), e i paesi del Sud (con un’inflazione relativamente elevata).[viii] L’esperienza delle regioni italiane suggerisce tuttavia che questo stato di fatto è destinato a persistere molto a lungo, il che significa che bisognerà attendere molto tempo perché tutti i paesi europei convergano verso il medesimo tasso di inflazione.
Da questi fatti statistici derivano due conseguenze significative.
In primo luogo, il fatto che una moneta unica conduca comunque a livelli di inflazione diversi rimette in discussione l’ingenua convinzione che sia la moneta che «causa» i livelli dei prezzi. Non si tratta di un’osservazione puramente teorica, al contrario: si tratta di una constatazione politica. L’inizio della terza globalizzazione (la globalizzazione «finanziaria») è stato caratterizzato da due importanti riforme istituzionali: la liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitali e l’affermazione del principio dell’indipendenza dai governi della Banca centrale.[ix] Quest’ultimo si traduce nella proibizione rivolta alla Banca centrale di finanziare programmi di spesa pubblica attraverso l’emissione di moneta (incluso l’acquisto di titoli di debito pubblico al momento dell’emissione).
Questo divieto, giustificato all’epoca con la necessità di contenere l’inflazione legata all’impennata del prezzo del petrolio, ha avuto come conseguenza quella di obbligare gli Stati sovrani a rivolgersi ai mercati finanziari (e dunque in misura sempre crescente agli investitori internazionali) per soddisfare i loro bisogni di finanziamento. Si partiva dal principio che questo avrebbe sottoposto i governi, potenzialmente corrotti o miopi, alla disciplina dei mercati, visto che questi si sarebbero rifiutati di finanziare governi inefficienti.
Alla base di questo approccio, c’era l’idea che, poiché è la moneta che provoca l’inflazione, lasciando la gestione della massa monetaria nelle mani dei governi, questi ne avrebbero sicuramente approfittato a fini elettorali, provocando di conseguenza un aumento dell’inflazione.
Tuttavia, il fatto che da una parte una moneta unica possa coesistere con tassi di inflazione diversi e divergenti e dall’altra che la creazione massiccia di moneta da parte della BCE non sia riuscita a rianimare l’inflazione in Europa ci permette di vedere chiaramente che il legame tra massa monetaria e inflazione non è automatico. Questo spiega perché a una moneta unica non corrisponde un’inflazione unica. L’esperienza europea (e prima di questa l’esperienza italiana) ormai ci conferma che la dinamica dei prezzi è legata ad altri elementi strutturali di un sistema economico, in particolare al mercato del lavoro: è il tasso di disoccupazione, e non quello di creazione di moneta, che regola il tasso d’inflazione.[x] Questo d’altra parte spiega perché è nel sud d’Italia, dove la disoccupazione è maggiore, che l’inflazione è più bassa. Se però la moneta non causa l’inflazione, non è più giustificabile la decisione di sottrarne la gestione ai governi per garantire la stabilità dei prezzi. Se cade questa motivazione, bisogna dunque che ci domandiamo quale sia la giustificazione per proibire il finanziamento monetario del debito pubblico. In effetti, l’idea di sottomettere gli Stati alla disciplina dei mercati o, in altri termini, di privatizzare il più possibile il circuito del risparmio e dell’investimento, sembra un po’ superata, in un periodo in cui si assiste alla crisi mondiale di questi stessi mercati.
Il fatto che una moneta unica non garantisca la convergenza dei tassi d’inflazione ha un’altra conseguenza importante. Se infatti non si produce una convergenza, la moneta unica non può garantire che il rapporto tra i prezzi dei beni prodotti all’interno di un paese e quelli prodotti all’estero, quello che si definisce il tasso di cambio «reale», sia stabile. Nei paesi dove l’inflazione è più bassa, questo rapporto avrà la tendenza a diminuire. Si assisterà così a quella che si definisce una svalutazione del tasso di cambio reale, che corrisponde a un miglioramento della competitività, e comporta un surplus commerciale, al quale dovrà necessariamente corrispondere un deficit da qualche altra parte (nei paesi dove l’inflazione è più alta). Se il paese più forte avesse la sua propria valuta, questa tendenza sarebbe compensata da una rivalutazione del suo tasso di cambio: la moneta del paese forte diventerebbe anch’essa più forte, perché tutti la richiederebbero per acquistare i beni che produce.
Ma se la moneta è unica, il paese più forte non può rivalutare, il che vale a dire che non può riallineare la sua moneta alla sua produttività. Il peso dell’aggiustamento sarà allora sostenuto dai paesi che, per svariate ragioni (storiche, tecnologiche, sociali, culturali) in quel momento sono meno produttivi.
Negli anni 80 c’era la tendenza a interpretare questi fenomeni in un’ottica moralistica. Il deficit commerciale, si diceva, spronerà i deboli a correggersi. Un eccesso persistente di importazioni crea necessariamente un debito estero (perché bisogna pagare i beni che si acquistano all’estero) e una perdita di posti di lavoro (perché le importazioni non creano lavoro nelle regioni di destinazione, ma in quelle di provenienza). I paesi deboli si troveranno dunque di fronte a un dilemma: o diventare più produttivi (in modo da poter avere prezzi meno elevati) o perdere posti di lavoro, e sceglieranno per forza di cose la strada giusta, cioè fare le riforme necessarie a diventare più produttivi.
L’idea secondo cui, una volta buttati nella piscina della moneta unica, i paesi più deboli avrebbero volenti o nolenti imparato a nuotare era di per sé piuttosto autoritaria e sorda allo spirito di «solidarietà» e «unione sempre più stretta» declamato dal progetto europeo. In più, era smentita dall’esperienza italiana, e anche dalla più recente esperienza tedesca, che dimostrava che le regioni più deboli non riescono a recuperare facilmente il loro ritardo, quando sono schiacciate dal peso di una moneta troppo forte.[xi]
Infine, questa idea era un po’ ingenua, nel senso che è ingenuo illudersi che, in mancanza di una rivalutazione della valuta del paese forte, la riduzione dei prezzi nel paese debole possa sistemare le cose. Certo, in linea di principio per far scendere i prezzi basta essere più produttivi: se lo stesso lavoratore produce il doppio dei beni, i beni possono essere venduti a metà prezzo. Ma un aumento della produttività non si ottiene dall’oggi al domani. Questo meccanismo non è compatibile con l’urgenza generata dalle crisi finanziarie.
Quando scoppia la crisi, è piuttosto la disoccupazione (o la chiusura delle aziende) che assicura la moderazione dei prezzi. Se però la disoccupazione persiste, i lavoratori si trasferiscono. Per gli economisti «ortodossi» è un bene: il tasso di disoccupazione scende, perché, dopo che i disoccupati se ne sono andati, non ci sono più disoccupati. Pangloss non saprebbe dirlo meglio!
Gli economisti keynesiani hanno invece il buon senso di rendersi conto che questi disoccupati sono anche clienti delle aziende locali: la loro uscita di scena provoca quindi una crisi di domanda, che fa sprofondare le regioni deboli nella trappola del sottosviluppo. Se calano gli acquirenti locali, bisogna andare a caccia di mercati all’estero, e per farlo è necessario tagliare ancora maggiormente il costo del lavoro, ovvero i redditi dei lavoratori, spingendo ulteriormente a calare la domanda interna, in una spirale senza fine.
Del resto, è proprio questo che spiega la mancata convergenza dei prezzi tra le regioni italiane. La svalutazione «interna» (vale a dire la contrazione dei salari) è un meccanismo molto più lento e inerziale della svalutazione «esterna» (abbassamento del tasso di cambio della valuta nazionale). Una volta che il processo di aggiustamento è avviato, è difficile interromperlo al momento giusto, soprattutto se per favorirlo si sono messe in atto riforme strutturali (come il «jobs act» italiano o la «loi travail» francese). Il rischio è quindi di ritrovarsi intrappolati in una spirale deflazionistica. È quello a cui abbiamo assistito per decenni in Italia ed è quello da cui ci mette in guardia oggi la BCE a livello europeo.
Ci sono studi che dimostrano che la rigidità del tasso di cambio si accompagna a una crescita più debole.[xii] Non c’è da stupirsene: quando il meccanismo di aggiustamento si basa sulla diminuzione dei salari, è necessario che aumenti la disoccupazione (perché in caso contrario i lavoratori non accetterebbero la riduzione dei loro redditi). Ma è il lavoro che crea il valore. Un sistema economico che si riequilibra attraverso la disoccupazione è dunque destinato a creare meno valore.
L’esperienza italiana ci mostra che in questo gioco nessuno è vincitore. Se le regioni del Nord per un certo periodo hanno potuto sfruttare quelle del Sud come fonte di manodopera a basso costo, e allo stesso tempo come mercato per i prodotti delle loro industrie, a lungo termine la divergenza tra le due parti del paese risulta un rischio per la crescita, che compromette la stabilità finanziaria e finisce col creare tensioni secessioniste (rappresentate in Italia dalla Lega Nord). Lo stesso scenario si presenta oggi su scala europea.
Unione monetaria e «vincolo esterno» tra economia e politica
Quanto detto finora non è una novità. Nel 1996, Rudiger Dornbusch (MIT) già sosteneva che «la critica più seria che si può rivolgere a un’unione monetaria è che abbandonando gli aggiustamenti ottenuti attraverso il tasso di cambio è destinata a trasferire al mercato del lavoro il compito di regolare la competitività e i prezzi relativi… Le perdite di prodotti e di lavoro finiranno col prevalere…».[xiii] Due anni più tardi, Paul Krugman segnalava che «il pericolo più evidente e più immediato è che l’Europa diventi giapponese: che scivoli inesorabilmente nella deflazione, e che nel momento in cui i banchieri centrali decidono di mollare la presa, sia troppo tardi».[xiv] Ben prima, nel 1971, Nicholas Kaldor (Cambridge) aveva stabilito un punto: «Sarebbe un errore pericoloso credere che l’unione economica e monetaria possa venire prima dell’unione politica, perché se la creazione dell’unione monetaria e il controllo della Comunità sulle finanze nazionali provocano tensioni che portano al crollo del sistema, l’unione monetaria avrà impedito lo sviluppo di una unione politica, invece di favorirlo».[xv]
Oggi sta accadendo proprio quello che gli economisti più autorevoli avevano previsto: siamo in deflazione, perché gli aggiustamenti agli shock esterni (come la crisi dei «subprimes») si sono trasferiti sul mercato del lavoro (e quindi sui salari, attraverso l’aumento della disoccupazione), cosa che ha messo sotto pressione le economie nazionali e ha allontanato le prospettive fondate di una unione politica.
Da questo punto di vista, si può dunque affermare che l’euro è uno dei più grandi successi della scienza economica: tutto quello che questa aveva previsto si è realizzato, ed esattamente nel modo in cui la scienza economica l’aveva previsto.[xvi] Si sarebbe tentati di concludere che l’unione monetaria è stata al contrario una grande sconfitta della politica: dopo avere ignorato gli avvertimenti degli economisti, i politici non hanno raggiunto nessuno degli obiettivi che ostentavano (prosperità, stabilità, pace) e ci si può chiedere se mai li raggiungeranno. Tuttavia il dibattito politico italiano ci offre una visione più sfumata, che cercherò di descrivere partendo dalle dichiarazioni di tre dei nostri uomini politici che hanno ricoperto ruoli di responsabilità in Europa.
Nel 2001, Romano Prodi (all’epoca presidente della Commissione Europea) affermò: «Sono sicuro che l’euro ci obbligherà a introdurre nuovi strumenti di politica economica. È politicamente impossibile proporli adesso, ma un giorno ci sarà una crisi e si creeranno questi nuovi strumenti ».[xvii]
Quali erano questi strumenti che si ritenevano necessari, ma non erano proponibili politicamente? Ovviamente, tutto ciò che poteva portare a una maggior flessibilità verso il basso dei salari. A questo riguardo si può citare Tommaso Padoa-Schioppa (allora membro del comitato esecutivo della BCE, e in seguito ministro nel governo Prodi): «Nell’ Europa continentale, un programma completo di riforme strutturali deve oggi spaziare nei campi delle pensioni, della sanità, del mercato del lavoro, della scuola e in altri ancora. Ma dev’essere guidato da un unico principio: attenuare quel diaframma di protezioni che nel corso del Ventesimo secolo hanno progressivamente allontanato l’individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o il premio ai suoi difetti o qualità».[xviii]
Chiaramente, l’idea di essere riavvicinati bruscamente alla durezza del vivere non poteva sorridere agli elettori. Questa durezza, in particolare la disoccupazione, è stata usata per assicurare la flessibilità dei salari verso il basso: il meccanismo di aggiustamento ritenuto essenziale alla sopravvivenza della moneta unica, e che oggi è in fase di accartocciarsi su se stesso in una crisi deflazionistica (come Krugman aveva previsto). Ma se anche questo meccanismo potesse funzionare, tuttavia, resterebbe un piccolo problema: i salari, in una economia capitalistica, costituiscono il reddito della maggioranza dei cittadini. Questo rende di per sé poco politicamente sostenibile un sistema economico che a ogni crisi esige di ridurli. A questo proposito, nel 1998, Mario Monti (allora Commissario europeo per il mercato interno) aveva dichiarato: «Tutto sommato, alle istituzioni europee interessava che i Paesi facessero politiche di risanamento. E hanno accettato l’onere dell’impopolarità essendo più lontane, più al riparo, dal processo elettorale».[xix]
L’esperienza italiana ci offre quindi una nuova griglia analitica, coerente con le dichiarazioni dei politici italiani: a quanto pare, le élite dei paesi dell’UE periferici, come l’Italia, volevano smantellare e privatizzare lo stato sociale (Padoa Schioppa), sotto la pressione di una situazione di emergenza causata da crisi economiche (Prodi), utilizzando l’UE come capro espiatorio (Monti). Si tratta di una dinamica politica che è stata teorizzata e analizzata da molti autori, tra cui Featherstone.
L’adesione all’euro, e in precedenza al Sistema monetario europeo, ha creato un “vincolo esterno” il cui scopo era quello di garantire la sostenibilità politica del progetto, a molti livelli: in primo luogo, perché le crisi che il processo di integrazione monetaria rende inevitabili, aprono finestre di opportunità per l’avanzamento del progetto di unione politica. È la teoria di Jean Monnet, secondo il quale «l’Europa sarà costruita attraverso le crisi e sarà la somma delle soluzioni apportate a queste crisi».[xx] Inoltre, le crisi finanziarie permettono di proporre ai cittadini, come misure di emergenza, tagli di bilancio i cui effetti sulla distribuzione del reddito saranno permanenti.[xxi]
Ancora, perché ciò consente di attribuire a un ente “terzo”, “indipendente” e soprattutto sottratto al controllo diretto degli elettori, vale a dire “l’Europa”, la responsabilità delle politiche regressive che gli stessi elettori avrebbero respinto se fossero state proposte dai governi nazionali. È qui che le parole di Monti sono coerenti con l’analisi di Featherstone del “vincolo esterno”: dato che la moneta unica non è compatibile con il modello europeo di tutela del lavoro, quest’ultimo deve cedere il passo alla prima.
Per garantire il successo di questo progetto politico, che era, in sostanza, un progetto di redistribuzione del reddito, bisognava presentarlo come il risultato inevitabile di fenomeni incontrollabili (come ad esempio la globalizzazione) ed errori del passato (la prodigalità dei governi). La realtà era un po’ diversa: lo smantellamento dello stato sociale e del sistema di protezioni del lavoro non mirava al consolidamento dei bilanci pubblici, che non ne avevano bisogno,[xxii] quanto piuttosto a promuovere l’aggiustamento verso il basso dei salari, meccanismo essenziale in un regime di moneta unica.
Da questo punto di vista, l’euro è stato senza alcun dubbio un grande successo. Ormai in Italia più o meno tutti ammettono che lo spauracchio del debito pubblico non giustificava le riforme realizzate negli ultimi cinque anni (dalla riforma delle pensioni, a quella della scuola, a quella del codice del lavoro, come suggerito da Padoa Schioppa). L’insorgere della crisi bancaria ha mostrato a tutti che il problema era altrove, vale a dire nel circuito finanziario privato, e non in quello pubblico.[xxiii] Impoverire un intero paese con politiche di imposte più alte e tagli alle prestazioni sociali ha peggiorato la situazione, ma cancellare i risultati di questi errori non sarà facile.
[i][i] Bagnai, A. 2016. Italy’s decline and the balance-of-payments constraint: a multicountry analysis. International Review of Applied Economics, 20, 1-26.
[ii] Giandomenico Majone (2014) Rethinking the union of Europe post-crisis – Has integration gone too far?, Cambridge: Cambridge University Press; Jan Zielonka (2014) Is the EU doomed?, Cambridge: Polity Press.
[iii] John Maynard Keynes (1931) Essays in persuasion, London: MacMillan.
[iv] Su questo ultimo punto, Davide Furceri et Prakash Loungani (2015) « Capital Account Liberalization and Inequality »,
IMF Working Papers 15/243, International Monetary Fund.
[v] Banca Centrale Europea (2016) « Economic Bulletin », n. 3 (marzo).
[vi] Kevin Featherstone K. (2001) “The political dynamics of the vincolo esterno: the emergence of EMU and the challenge to the European social model”, Queen’s Papers on Europeanisation, 6, Belfast: Queens University.
[vii] Fabio Busetti, Silvia Fabiani, Andrew Harvey (2006) “Convergences of prices and rates of inflation,” Temi di discussione (Economic working papers) 575, Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area.
[viii] Fabio Busetti, Lorenzo Forni, Andrew Harvey, Fabrizio Venditti (2007) “Inflation Convergence and Divergence within the European Monetary Union,” International Journal of Central Banking, vol. 3(2), pp. 95-121, giugno.
[ix] Carmen M. Reinhart, Belen Sbrancia (2011) “The liquidation of government debt”, BIS Working Papers, n. 363, novembre
[x] Questo approccio è ormai condiviso dalla Banca Centrale Europea (op. cit.).
[xi] L’esperienza tedesca è descritta da Vladimiro Giacché (2013) Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa. Reggio Emilia: Imprimatur Editore.
[xii] Eduardo Levy-Yeyati, Federico Sturzenegger (2003) “To Float or to Fix: Evidence on the Impact of Exchange Rate Regimes on Growth,” American Economic Review, vol. 93(4), pp. 1173-1193; Martin T. Bohl, PhilipMichaelis, Pierre L. Siklos (2016) “Austerity and recovery: Exchange rate regime choice, economic growth, and financial crises”, Economic Modelling, vol. 53, pp. 195-207
[xiii] Rudiger Dornbusch (1996) “Euro fantasies”, Foreign Affairs, vol. 75, n. 5 (la traduzione è nostra).
[xiv] Paul Krugman (1998) “The euro: beware of what you wish for”, Fortune, dicembre (la traduzione è nostra).
[xv] Nicholas Kaldor (1971) “The Dynamic Effects of The Common Market”, The New Statesman, 12 marzo.
[xvi] Restano da spiegare le complesse ragioni che hanno portato la maggior parte degli economisti a difendere, al momento della sua crisi, il medesimo progetto del quale avevano preannunciato il faIlimento.
[xvii] Romano Prodi (2001) “Prodi pledges to make role more visible after attacks on leadership”, intervista sul Financial Times, 5 dicembre 2001, p. 1 (edizione di Londra).
[xviii] Tommaso Padoa Schioppa (2003) “Berlino e Parigi: ritorno alla realtà”, Il Corriere della Sera, 26 agosto 2003.
[xix] Federico Rampini (1998), Intervista sull’Italia in Europa, Roma, Bari: Laterza.
[xx] Jean Monnet (1976) Mémoires, Paris: Fayard.
[xxi] Ishac Diwan (2001) “Debt as Sweat: Labor, financial crises, and the globalization of capital”, mimeo, World Bank.
[xxii] Commission Européenne (2012), “Fiscal sustainability report”, settembre.
[xxiii] Richard Baldwin, Francesco Giavazzi (2015) The Eurozone crisis: a consensus view of the causes and a few possible solutions, Londre: CEPR Press-
fonte: http://vocidallestero.it/2016/11/23/unione-monetaria-un-punto-di-vista-italiano/



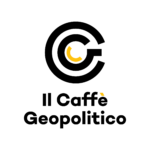




























Commenti recenti