Amministrazione Trump ai blocchi di partenza: chi e perché gioisce
di FEDERICO DEZZANI
Il 20 gennaio Donald Trump si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca con la nuova squadra di governo. Molti si pongono un legittimo quesito: perché il prossimo presidente si avvale di numerosi ex-banchieri di Goldman Sachs, se rappresenta davvero un cambiamento rispetto al passato? E quale ruolo riveste l’influente genero Jared Kushner? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump è stata anche un lotta tra due anime dello stesso sistema: ne è emersa vincente quella più nazionalista e conservatrice, spalleggiata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha garantito l’accesso di Trump alla stanza dei bottoni. All’orizzonte si profila un’inedita alleanza tra Washington, Tel Aviv e Mosca ai danni dell’establishemnt liberal: per i populismi europei è un’occasione unica per riappropriarsi della sovranità politica ed economica, svincolandosi dall’Unione Europea.
Una faida dentro all’establishment? Comunque, un’imperdibile occasione
Il 20 gennaio, a distanza di più di due mesi dalle presidenziali americane che hanno sorpreso il mondo (ma non noi), si insedierà la nuova amministrazione di Donald Trump. Per l’ordine internazionale sarà una rivoluzione copernicana che impatterà qualsiasi aspetto delle relazioni tra Stati Uniti ed il resto del mondo: l’assetto internazionale post-1945, basato sul predominio angloamericano, sul binomio NATO/CEE-UE e su dosi crescenti di globalizzazione, tramonterà definitivamente, causa sfinimento del sistema stesso. Per la prima volta dagli anni ’30, siederà alla Casa Bianca un presidente “isolazionista”. Gli Stati Uniti, in sostanza, abdicheranno al loro ruolo di potenza egemone, concetto implicito “nell’America first” di Trump, condannando a morte certa le vecchie istituzioni figlie di quest’epoca.
Avendo caricato di simili aspettative la presidenza di Trump ed incombendo ormai il suo ingresso alla Casa Bianca, è quindi ora di rispondere ai dubbi che attanagliano molti osservatori, specialmente dopo la formazione della nuova squadra presidenziale dove compaiono diversi ex-banchieri di Goldman Sachs. Parecchi, sconcertati dal divario tra la retorica “populista” di Trump ed i nomi scelti per occupare i posti chiave della prossima amministrazione, si sono posti domande più che giustificate: Donald Trump rappresenta davvero un cambiamento rispetto al passato? Non sarà anche lui l’ennesimo fantoccio di Wall Street? Esaurite le aspettative iniziali, non si rivelerà un altro bluff, adagiandosi sulla solita politica di Bush e Obama?
Sono interrogativi più che legittimi. Bisogna però evitare a qualsiasi costo l’idea paralizzante (perché renderebbe inutile qualsiasi azione) che “il Potere” sia monolitico, infallibile, onnipotente ed eterno e, anno dopo anno, elezione dopo elezione, si riproduca sempre uguale: nascondendosi dietro Bill Clinton nel 1993, dietro George Bush nel 2001, dietro Barack Obama nel 2008, dietro Donald Trump nel 2017, e così via, ad aeternum.
Il “Potere”, che in Occidente alberga nelle piazze finanziarie di Londra e Wall Street, non è monolitico, ma si divide al suo interno in cordate e fazioni. Non è infallibile, perché anch’esso si basa su calcoli e previsioni che spesso si rivelano, ex-post, errati. Non è onnipotente, perché il mondo è troppo articolato, ampio e variegato, perché possa essere controllato “a tavolino”. Non è eterno, perché come ogni organizzazione umana, non sfugge al ciclo di nascita, crescita, maturità e morte. Il “Potere”, alias la finanza cosmopolita, è fallibile, divisa in correnti e spesso impotente di fronte a dinamiche che sfuggono al suo controllo. Benché abbia mostrato da sempre forti capacità di adattamento, sta poi dando evidenti segnali di affaticamento: la sua presa sul mondo si affievolisce, giorno dopo giorno.
Il caso di Donald Trump, il candidato “populista” eletto contro ogni qualsiasi pronostico, rientra senza alcun dubbio nella saga del “Potere” atlantico: una fazione dell’establishment, in aperta lotta con la rivale, si è raccolta attorno alla sua candidatura e gli ha spianato l’accesso alla Casa Bianca, altrimenti impensabile per un candidato totalmente estraneo al sistema. Ne sono derivate, di conseguenza, le nomine dei banchieri di Goldman Sachs nei ruoli chiave della nuova amministrazione e un po’ di sconcerto tra chi sperava in un radicale rinnovamento.
Perché, allora, abbiamo salutato con favore la vittoria di Donald Trump e abbiamo riposto così tante speranze nel suo mandato, se è anch’esso un’espressione del solito establishment? E perché, se anche Trump è un fantoccio del “Potere”, la campagna elettorale è stata così spietata ed i rischi di una rivoluzione colorata negli Stati Uniti sono tutt’altro che remoti?
Le riposte sono molteplici:
- Trump è la reazione ad un sistema internazionale logoro e fallimentare ed è quanto di meglio potessero oggi offrire gli Stati Uniti;
- Trump è l’espressione di una fazione minoritaria dell’establishment, quella più nazionalista, conservatrice, realpolitiker e ostile alla rivoluzione mondiale permanente dell’establishment liberal. Ci riferiamo alle attività in cui eccelle George Soros che, non a caso, sosteneva la candidatura di Hillary Clinton: destabilizzazioni, cambi di regime, interventi “umanitari”, terrorismo, ondate migratorie, etc. etc.;
- Trump introduce nel sistema internazionale un notevole dinamismo che, sfruttato adeguatamente, può consentire, soprattutto in Europa, di “rimpatriare” massicce dosi di sovranità politica ed economica ai danni delle vecchie istituzioni atlantiche.
Sono questi i motivi per cui abbiamo accolto con favore la sua elezione e per cui siamo certi che incontrerà forti resistenze fuori e dentro gli Stati Uniti.
Alle elezioni dell’8 novembre, il “Potere”, ossia la finanza cosmopolita, si divide in due cordate: la parte maggioritaria (quella liberal e dei neocon, delle grandi corazzate dell’informazione, dei paladini del riscaldamento globale, della New Economy, della globalizzazione, dell’Unione Europea, dell’immigrazione indiscriminata, del terrorismo islamico, del contenimento ad ogni costo della Russia) si coagula attorno ad Hillary Clinton, una parte minoritaria (quella, in sostanza, che si sentiva reclusa dalla prima: destra americana nazionalista e identitaria, falchi israeliani, petrolieri, Old Economy e fautori di una realpolitik in politica estera) si dirige verso Donald Trump.
La lotta tra le due fazioni, va sottolineato, è reale ed il voto dell’8 novembre non è una semplice farsa che proclamerà il candidato scelto prima a tavolino: gli obiettivi delle due cordate sono profondamente divergenti e la posta in gioco è altissima, considerato che sono in ballo interessi consolidati da decenni.
Il “Potere”, in un certo senso, vincerà comunque: Goldam Sachs ha in Hillary Clinton una fedele alleata1 ma, allo stesso tempo, presta a Donald Trump il regista della sua campagna elettorale, l’ex-banchiere Steve Bannon, fondatore del sito Breibart, ed il suo futuro segretario del Tesoro, l’ex-banchiere Steven Mnuchin. Ma è un “Potere” è attraversato da violente lotte intestine, come si evince dalla durezza dello scontro tra le due differenti fazioni: la tensione è così alta che la parte sconfitta, quella dei liberal e di George Soros, difficilmente si rassegnerà allo smacco subito e tenterà in ogni modo di spodestare Trump prima della fine del mandato (rivoluzione colorata, campagne infamanti, procedure di impeachment, etc. etc.). Si respira, insomma, aria da “guerra civile”, evidente segnale di un impero che si sta accartocciando su se stesso.
Sono senza dubbio soddisfatti della vittoria di Trump, coloro che gli hanno aperto le porte di Goldman Sachs: il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la destra israeliana più oltranzista: il Likud non aveva digerito i tentativi di Barack Obama di effettuare un cambio di regime “morbido” in Israele ai danni di Netanyahu, né le aperture all’Iran in chiave “divide et impera” fatte dall’amministrazione democratica, né l’ostilità all’espansionismo israeliano sui territori palestinesi. È tutt’altro che casuale che una delle ultime mosse di Barack Obama sia stata la clamorosa astensione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, astensione che ha permesso l’approvazione di una risoluzione contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme Est: l’amministrazione uscente ha così sferrato un colpo di coda a Tel Aviv, per vendicarsi del supporto fornito a Donald Trump in campagna elettorale.
A partire dal 20 gennaio, attraverso il genero del presidente, il giovane ed influente Jared Kushner, il Likud israeliano e Bibi Netanyahu avranno così un canale diretto e preferenziale con il nuovo inquilino della Casa Bianca: “Israel’s right celebrates Donald Trump’s victory” titolava la CNN il 14 novembre, descrivendo la soddisfazione della destra israeliana per la vittoria di Trump e l’archiviazione della deludente era Obama.
Lo Stato d’Israele, il più sensibile ai cambiamenti di forza in Medio Oriente, è peraltro da anni in avvicinamento alla Russia: la nomina a ministro della Difesa del russofono Avigdor Lieberman ha suggellato l’avvicinamento di Tel Aviv e Mosca, sempre più influente nella regione e imprescindibile per il futuro dello Stato ebraico. Al contrario, i rapporti tra Israele ed Unione Europea, un prodotto dell’establishment liberal, sono burrascosi quasi quanto quelli tra Netanyahu ed Obama: si ricordi, ad esempio, la recente crisi diplomatica dopo la decisione di Bruxelles di contrassegnare le merci provenienti dai territori palestinesi occupati2. Il Likud ha quindi una chiara agenda, distensione dei rapporti tra Stati Uniti e Russia e parallela rottura delle relazioni tra Washington e Bruxelles, e confida di poterla attuare attraverso il nuovo inquilino della Casa Bianca.
Non avrebbe potuto Benjamin Netanyahu ottenere lo stesso risultato investendo su Hillary Clinton? No, perché la priorità della candidata democratica, in quanto esponente dell’establishment liberal, sarebbe stata l’eliminazione della Russia come centro di potere alternativo a quello atlantico, anche a costo di una guerra con Mosca. Allo stesso tempo, la Clinton si sarebbe prodigata per salvare l’Unione Europea, il risvolto politico della NATO ed il principale strumento per contenere l’influenza della Russia sul Vecchio Continente.
Arriviamo così al secondo, grande, vincente delle elezioni dell’8 novembre, dopo Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin: scongiurato uno scenario di guerra nel caso in cui Hillary Clinton, vinte le elezioni, avesse deciso di intervenire militarmente in Siria, il presidente russo si sarà certamente rallegrato leggendo le ultime interviste di Donald Trump a due giornali europei, l’inglese The Times ed il tedesco Bild.
Il futuro inquilino della Casa Bianca ha confermato le sue visioni su Unione Europea e NATO, già anticipate in campagna elettorale: il Regno Unito ha fatto la scelta giusta abbondando l’Unione Europea e siglerà presto un proficuo accordo commerciale con gli Stati Uniti, altri Paesi europei seguiranno la sua strada, la cancelliera Angela Merkel (“the Liberal West’s Last Defender”3 per i liberal del New York Times) ha commesso un catastrofico errore spalancando le porte agli immigrati, la NATO è “obsoleta” e difettosa,“perché è stata concepita tanti e tanti anni fa”. Il futuro presidente degli Stati, isolazionista e realpolitiker, non quindi ha remore nell’attaccare i due pilatri su cui da 70 anni si base l’egemonia atlantica in Europa, in vista di una spartizione del Continente in zone d’influenza, a tutto vantaggio della Russia.
Facciamo la prova del nove: esiste un qualche prova dell’intesa tra i due presunti registi occulti dell’elezione di Trump, Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin? Frequenti e solidi rapporti si sono instaurati negli ultimi 18 mesi tra i due politici, accomunati dall’odio verso Obama, ed alla stampa più solerte non è sfuggito lo strano attivismo russo-israeliano che ha preceduto e seguito l’elezione di Trump (“Netanyahu’s Sweet Temptation Is to Seal the Trump-Putin Deal”, How Putin and Netanyahu are exploiting the transition”)
Chi credeva in un immediato miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Russia, è forse rimasto stupito dalle recenti parole pronunciate dal futuro Segretario di Stato, l’ex-amministratore di Exxon Mobil Rex Tillerson (“la Russia rappresenta un pericolo e gli alleati della Nato sono giustamente preoccupati”), dal prossimo capo della CIA, Mike Pompeo (“Dopo il gruppo dello Stato islamico, la Siria e l’Iran, la Russia rappresenta la principale minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti”) e dal segretario della Difesa, il generale Michael Flynn (“La Russia è la principale minaccia alla sicurezza nazionale e vuole spaccare la NATO”) ma occorre inquadrare le esternazioni nel dovuto contesto: le audizioni davanti alle commissioni del Congresso, che si profila come il principale freno all’azione di Trump in politica estera nei prossimi anni. Il nuovo corso degli Stati Uniti sarà opera di un solo uomo al comando, che seguirà lo spartito “suggerito” da israeliani e russi.
In un’ultima analisi, l’insediamento della prossima amministrazione democratica sancirà la nascita di un’inedita triangolazione tra Washington, Tel Aviv e Mosca ai danni dell’establishment liberal: Trump otterrà di ritirarsi in buon ordine dal Medio Oriente e dall’Europa (sdebitandosi, allo stesso tempo, dell’appoggio ricevuto per l’elezione alla Casa Bianca), Netanyahu avrà un alleato comprensivo alla Casa Bianca ed un nuovo garante della sicurezza di Israele al Cremlino, Putin sarà compensato con lo smantellamento dell’Unione Europea ed il ridimensionato della NATO. È un patto a tre, che decreterà la definitiva archiviazione dell’ordine mondiale “liberale”, con la sola eccezione di Israele che sfuggirà al declino americano riparandosi sotto l’ombrello di Mosca, alleato di ferro anche di Siria, Iran e Turchia e garante di una “pax russa” nella regione.
L’Unione Europea è, in questo nuovo contesto, condannata a morte certa: per Trump è il retaggio di un’epoca archiviata, per Netanyahu è un fastidioso strumento in mano ai liberal, per Putin è un freno al dinamismo russo verso ovest.
Dopotutto, si può chiudere un occhio se dietro la vittoria di Trump si celano anche la solita Goldman Sachs e la destra israeliana: l’occasione offerta ai populismi europei di liberarsi dal giogo della UE/NATO è imperdibile. Il “Potere”, logoro e diviso, perde pezzi: sarebbe un peccato non approfittarsene.
1https://www.nytimes.com/2016/09/25/us/politics/bill-hillary-clinton-goldman-sachs.html
2http://www.panorama.it/news/esteri/etichette-sui-prodotti-delle-colonie-israele-si-infuria-con-la-ue/
3https://www.nytimes.com/2016/11/13/world/europe/germany-merkel-trump-election.html
fonte: http://federicodezzani.altervista.org/amministrazione-trump-ai-blocchi-partenza-perche-gioisce/

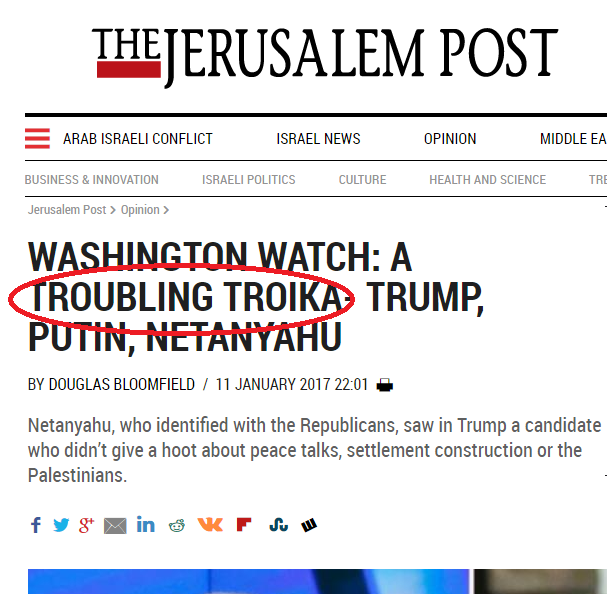































Commenti recenti