Ideologia del dato. Ermeneutica e pandemia
di LE PAROLE E LE COSE (Agostino Cera)

1.
Il primo obiettivo che si pongono queste pagine, volutamente sospese tra «metafisica e giornalismo»[1], è non contribuire a quell’inflazione di pensieri (o sedicenti tali, in non rari casi) che rappresenta non uno dei primi, ma senza dubbio un ulteriore, accessorio disagio di questi giorni pandemici. Dribblare le innumerevoli – e non richieste – profferte dei molti che, in genere da un qualche pulpito mediatico, intendono svelarci in tempo reale – bontà loro! – qualcosa di essenziale circa il “momento che stiamo vivendo” è, volenti o nolenti, una delle incombenze quotidiane delle nostre quarantene. Dal canto mio, vorrei soffermarmi brevemente su una evidenza che mi si è imposta quasi mio malgrado durante queste settimane. Un’evidenza poco considerata, ma a mio parere degna di essere portata all’attenzione e che perciò ho deciso di provare a comunicare, assumendomi il rischio di finire nel girone dei “disvelatori seriali della realtà”.
In molti hanno fatto giustamente notare come l’infausta esperienza della pandemia da covid-19 e della segregazione collettiva che ne è seguita abbia avuto, tra i suoi pochissimi meriti, quello di produrre un’inversione di tendenza, presso l’opinione pubblica, rispetto all’allarmante deriva antiscientifica (etero-razionale o semplicemente ir-razionale) degli ultimi anni. Una diffidenza tignosa, rancorosa, non di rado aggressiva, corroborata da generose iniezioni di complottismo, che ha prodotto un ostracismo a priori nei confronti del sapere ufficiale e degli “esperti”, dei competenti mainstream, tacciati di essere poco o per nulla credibili in quanto corrotti da incestuosi, inconfessabili rapporti intrattenuti con potentati politico-economici dei quali fungerebbero da strumento di propaganda. E di fatturato. Una “euristica della malafede” – la si potrebbe definire, parafrasando Hans Jonas – che è stata il minimo comune denominatore alla base di una serie di vicende assurte agli onori della cronaca in anni recenti (dal “metodo Di Bella” al “protocollo stamina”) e delle quali il cosiddetto “movimento no vax” incarna il caso più lampante. A fronte di tutto ciò, la parentesi pandemica avrebbe sancito una significativa inversione di tendenza, una letteralmente salutare rivalutazione, riabilitazione delle competenze. In particolare, delle competenze scientifiche. Le quali ultime – come peraltro accade sempre nel contesto del villaggio globale, frattanto assurto al rango di network society (secondo la definizione del sociologo Manuel Castells)[2] – hanno già trovato i propri paladini mediatici, i quali si contendono a suon di “ospitate” lo scettro di “esperto degli esperti” presso il pubblico televisivo.
Come negare una simile evidenza? Come, e in fin dei conti perché, mettere in questione gli effetti benefici, balsamici per il nostro vivere comune innescati da un tale contromovimento neo-illuminista? Da una tale ritrovata fiducia nella ragione e nelle sue possibilità? Ovviamente, in nessun modo. Va da sé, infatti, che un simile merito non possa venir intaccato da alcuna critica. Tuttavia, al netto di questo positivo scenario complessivo, c’è qualcosa, come direbbe Walter Benjamin, che «merita di essere ripresa dal dialettico»[3]. Un aspetto meno evidente, un effetto carsico generato da questa meritoria inversione di tendenza. Ne faccio cenno, proponendolo come spunto di riflessione, allo scopo di scongiurare un effetto collaterale, potenzialmente dannoso, di questo benefico recupero di credibilità dei saperi e delle competenze. Il rischio sul quale vorrei porre l’attenzione è che la fiducia possa trasformarsi in fede, degenerare in un feticismo della expertise basato a sua volta sulla inconsapevole assunzione di un presupposto dogmatico. Vorrei evidenziare, in altri termini, il rischio rappresentato dal possibile imporsi di una nuova idolatria/ideologia strisciante: quella che Yuval Noah Harari, nel suo best-seller Homo Deus, chiama «datismo». Si tratta del culto del dato – della «religione dei dati», secondo le parole di Harari[4] – ovvero della persuasione che i dati, i dati numerici cioè, si producano e ancor più parlino da sé. E che come tali, in quanto tali, essi rappresentino ipso facto una sentenza inappellabile, una verità non contestabile. Ciò posto, l’avvento del datismo corrisponderebbe a una sorta di neue Sachlichkeit aletica, nel senso della versione più aggiornata del mito senza tempo (della chimera) di una verità: oggettiva, definitiva, assoluta. Una simile fede viene resa icasticamente dall’equazione ontologica sulla quale si fonda l’intera epoca della tecnica ovvero ciò che oggi, in ossequio a un lessico più à la page, andrebbe definito «infosfera». Una tale equazione recita: «esse est computari» (prendo a prestito una formula di Rafael Capurro, pioniere della riflessione filosofica sul digitale)[5]. Qui e ora la manifestazione fondamentale delle cose, la modalità attraverso la quale esse si mostrano e si danno a vedere/conoscere noumenicamente (in se stesse, per come sono), è quella numerica, ossia: quantitativa, misurabile, computabile. Va da sé che a questa fiducia cieca nella potenza autoevidente del dato computabile corrisponda un sistematico declassamento ontologico di tutto quanto si dimostra refrattario a una traslazione computazionale, una svalutazione di principio di tutto quanto non si presti a venir espresso in dati. Ma questa, ancorché una storia importante, è un’altra storia. Incompatibile con l’intento perseguito da queste pagine.
Tornando al quale, riporterò ora, a sostegno della tesi dell’esistenza di una incipiente ideologia/idolatria del datismo (allo scopo di renderla più concreta e quindi più comprensibile), una considerazione di natura del tutto empirica. Si tratta di una riflessione maturata da spettatore – spettatore televisivo, per giunta – nel corso della liturgia quotidiana che ha scandito questo ultimo mese di passione, del rituale che ha cadenzato la nostra quaresima-quarantena. Mi riferisco alla conferenza stampa giornaliera della protezione civile delle ore 18, pensata per comunicare alla popolazione i numeri e con essi l’andamento complessivo della pandemia. Per informarla, cioè, in modo “completo e oggettivo”, senza omissioni. Trasparente. Malgrado le intenzioni dei promotori dell’iniziativa (della cui bontà non v’è ragione di dubitare), mi è parso che l’elemento – il “dato” – più evidente di un tale rituale sia stato una involontaria riabilitazione della (onni)potenza dell’ermeneutica ovvero una attestazione della malleabilità del numero quale entità ontologica: qualcosa che rivela una consistenza molto meno solida e definitiva, molto meno oggettiva e incontrovertibile di quanto si immagini. O meglio: di quanto si voglia credere.
Per risultare meno vago, propongo un paio di esempi. Anzitutto, quello relativo al numero dei contagi. Il quale possiede un valore e produce un effetto molto diversi, a seconda che venga comunicato anche il numero delle persone testate. Dei cosiddetti “tamponati”. Ad esempio, 1.500 può essere un numero irrisorio, a fronte di 1.000.000 di tamponi, e un numero enorme, se invece i tamponi sono stati 3.000. Senza considerare, poi, la scelta preliminare su chi praticare i tamponi: cercare malati tra potenziali contagiati (persone delle quali si sa per certo che sono state a diretto contatto con dei malati conclamati) è molto diverso dall’inseguirli del tutto a caso. La stessa differenza che corre tra il modus operandi di un investigatore e quello di un rabdomante. Laddove si opti – come peraltro è inevitabile che sia – per una metodologia piuttosto che per un’altra, ma soprattutto laddove si scelga (perché si tratta, è bene tenerlo presente, di una scelta) di omettere o sottacere questi dati di contorno e di supporto all’atto della comunicazione pubblica… ebbene, a quel punto il numero abbandonato a se stesso, la nuda cifra si dimostra ben altra da quella entità auto-trasparente e incontrovertibile celebrata dal datismo. Essa si rivela, piuttosto, un ostaggio inerme alla mercé della forza straripante – che significa libertà, ma anche, potenzialmente, arbitrio – dell’interpretazione, la quale può farlo oscillare a proprio piacimento lungo uno spettro semantico molto ampio. A seconda di come venga incorniciata ermeneuticamente (presentata, comunicata, veicolata…), una stessa cifra, uno stesso dato numerico è in grado di produrre effetti conoscitivi, e ancor più emotivi, molto diversi in coloro che la/lo recepiscono.
Identico discorso vale per il numero dei morti, con l’aggiunta della scelta di se appurare o meno, ex post, la reale natura dei moltissimi “casi sospetti”. Ove si scelga di non farlo, si otterranno numeri diversi, persino molto diversi, rispetto alla opzione contraria. Che i vari stati nazionali abbiano adoperato, anche per motivi propagandistici, strategie differenti a tale riguardo, appare un dato di fatto (appunto!) ormai difficilmente contestabile. Come difficilmente contestabile è il fatto che la lettura di questi dati incida e inciderà non poco sul giudizio politico nei confronti dei vari governi da parte delle rispettive opinioni pubbliche, nonché sulle annesse valutazioni (altrettanto oggettive: da AAA+ a D; promossi o bocciati, sommersi o salvati), a opera di istituzioni “terze”, riguardanti i ratings di affidabilità economica dei singoli stati. Detto per inciso, rebus sic stantibus la produzione di cifre, la creazione di entità numeriche si annuncia come uno dei fronti più avanzati e più preoccupanti della propaganda. Politica, ma non solo.
Ci si chiederà a questo punto: qual è la morale della favola? Cosa dovrebbe insegnarci questo ennesimo, non richiesto tassello funzionale alla composizione del mosaico pandemico? Un tassello da porre, mi preme ripeterlo, a integrazione e non in contrasto con la salutare riabilitazione delle competenze presso l’opinione pubblica, che sta avendo luogo nelle ultime settimane.
Come succede spesso, la morale non è granché. È molto meno di quanto la favola sembrava promettere. In questo caso specifico, essa si limita a dire o a ribadire, banalmente, qualcosa che in verità ogni frequentatore dei sentieri della conoscenza (al di là del fronte epistemico – umanistico o “naturale” – nel quale milita) dovrebbe già sempre sapere e che forse, al giorno d’oggi, sta emergendo come un armamentario – un “DPI immateriale” – di cui neppure l’opinione pubblica può più fare a meno. Vale a dire: che la conoscenza esige fiducia, ma respinge, ripudia la fede. Che essa è allergica a qualsiasi pulsione feticistica, idolatrica. Che ogni ideologia consiste sempre in una rappresentazione semplificata e strumentale della realtà, in un “così voglio che sia” incompatibile con quel “così è o così appare” a cui dovrebbe tendere, pur nella consapevolezza di non poterlo mai davvero raggiungere, qualsiasi onesto sforzo conoscitivo.
La morale di questa favola è che, ora come sempre, lo scetticismo rappresenta lo habitus più accorto e più adeguato di un ethos autenticamente scientifico. Monito, quest’ultimo, che qui e ora deve valere a beneficio non solo di chi fa scienza/conoscenza, ma anche di chi la “consuma”. Come affermava nel 1966 il biologo inglese Alan Sterling Parkes: «la scienza può essere seria senza essere sacrosanta»[6]. A queste parole aggiungerei, kantianamente, che “può esserlo” perché “deve esserlo”, dal momento che dove c’è fede, lì non può esserci sapere.
Forse è vero che i numeri parlano, ma forse è ancora più vero che i numeri “dialogano” ovvero che non parlano da sé e in regime di soliloquio o di monologo, a mo’ di vaticinio, aspettando poi di essere semplicemente uditi e recepiti. Assunti e implementati. Essi sono sempre anche espressione di coloro che “li fanno parlare”, della loro complessa (fortunatamente) umanità, alla quale compete il “come farli parlare”. Sicché il loro parlare rispecchia anche sempre il modo in cui diamo loro la parola, il nostro (nel bene e nel male) interpretarli. Non solo in uscita, da ricettori dell’informazione numerica, ma anche in entrata, da “produttori” della stessa.
D’altra parte, giova ricordarlo, sin dalla sua origine – e dunque molto prima di accreditarsi come la «possibile koiné filosofica del pensiero occidentale» (secondo una nota formula di Gianni Vattimo)[7] – l’ermeneutica è una techne. Dunque una tecnica, una abilità, una expertise ma al tempo stesso un’arte dell’interpretazione. Un gioco più sottile della mera ricezione, trasmissione o veicolazione. Come tutto ciò che è peculiarmente umano, anche quest’arte tradisce una costituzione ancipite, ambigua. Essa non è soltanto fragile, sottile, ma anche subdola, melliflua. Consapevoli di questo, meglio perciò maneggiarla con la dovuta cautela.
2.
Dalle considerazioni svolte nelle pagine precedenti ci separa ormai quasi un mese. Nel frattempo qualcosa di sostanziale è cambiato: ci ritroviamo in una “fase 2” dai contorni sì ancora indefiniti, tuttavia legittimata da una certezza decisiva: che il virus abbia sensibilmente diminuito la sua carica di aggressività. A integrazione e consuntivo di quanto già argomentato, vorrei aggiungere alcune considerazioni. Dei “ripensamenti post-pandemici”, per così dire, maturati dalla decantazione dei precedenti “pensieri pandemici”.
Il primo di questi ripensamenti muove dalla spiacevole constatazione che, diversamente dal covid-19, la guerra (politico-propagandistica) dei numeri e dei dati non è regredita quanto a virulenza. Al contrario. D’altra parte, in fondo anche questo è un segno del fatto che stiamo lentamente tornando alla “normalità”. Ad ogni modo, risale a questi ultimi giorni l’accusa, si vedrà poi quanto fondata, che la regione Lombardia – la più colpita dall’evento pandemico – possa aver manipolato i dati relativi al contagio sul proprio territorio. Sulla scorta di quanto ho argomentato in precedenza, ovvero che dati e numeri non si manifestano mai se non all’interno di una cornice ermeneutica e pertanto sono, alla lettera, sempre oggetto di una qualche manipolazione; anzi, che il pericolo più grande (il decisivo avallo per il datismo in quanto ideologia) sta proprio nell’ostinarsi a credere al mito dell’autoevidenza del dato… ebbene, sulla scorta di tali osservazioni non posso che esprimere, ora, una certa perplessità nei confronti di una generica, indiscriminata accusa di manipolazione. A mio avviso si tratterebbe, piuttosto, di chiarire in che senso quella (eventuale) operata dai vertici della regione Lombardia andrebbe considerata una manipolazione indebita. Ossia, al di là del caso di specie: stante la irrinunciabilità per il dato numerico del medium ermeneutico, si tratterebbe di provare a chiarire, a beneficio di tutti, dove (a che punto) una tale inevitabile mediazione rischierebbe di rivelarsi soltanto dannosa. Pertanto, l’auspicio è che questa circostanza non si esaurisca nelle logiche asfittiche della speculazione e della propaganda, dal momento che una adeguata trattazione di essa potrebbe rappresentare un’importante occasione pedagogica collettiva. Un esempio di divulgazione: scientifica culturale, civica… nel senso più nobile del termine.
Ulteriore parto della fase 2 è stata la polemica relativa alla gestione delle “zone rosse”, che vede di nuovo protagoniste, loro malgrado, le istituzioni regionali lombarde. Faccio riferimento a questa vicenda soltanto a mo’ di “reagente teoretico”, allo scopo cioè di evidenziare una implicazione più strettamente filosofica di non trascurabile interesse. Detto reagente, infatti, mi pare in grado di far emergere una piccola crepa nell’impianto del celebre principio responsabilità di Hans Jonas ovvero in riferimento a uno dei principali, forse il principale, standard etici adottati dalla nostra «civiltà tecnologica». Com’è noto, nel suo capolavoro del 1979 Jonas formula il «principio responsabilità» quale culmine di una catena argomentativa la quale prende le mosse da una «euristica della paura», per combinarsi poi a un principio di precauzione e sfociare, appunto, nell’assunzione di una decisione responsabile. Il caso di scuola jonasiano è grossomodo il seguente: il timore concreto (avallato da qualche tragico “incidente di percorso”) che il nostro prometeismo tecnico possa consegnare alle generazioni future un pianeta non più abitabile, ci mette sull’avviso imponendoci «in forza di un dovere primario verso l’essere contro il nulla»[8] di agire cautelativamente, assumendoci la responsabilità di limitare qui e ora il nostro impatto sull’ambiente.
Ciò che Jonas non aveva considerato – e che, nel suo piccolo, il caso della gestione delle zone rosse in Lombardia mi pare consenta di porre in rilievo – è l’esistenza di una fattispecie particolare dell’euristica della paura, definibile come euristica del terrore o del timor panico, all’interno della quale possiamo senz’altro annoverare la paura di perdere il proprio consenso elettorale. A partire da un tale timore e sempre per il tramite di un principio di precauzione e di sopravvivenza (in questo caso, la propria), a emergere è stavolta un principio ir-responsabilità, vale a dire l’esatto opposto di quanto previsto dall’argomentazione jonasiana. L’euristica del terrore fa sì che ci si rifiuti di assumersi la responsabilità di una decisione (nella quale compare sempre, per quanto limitato, un elemento di azzardo e di rischio. Diversamente, si tratterebbe della mera esecuzione di una procedura e per quella non c’è bisogno di scomodare la responsabilità) oppure che si cerchi di scaricarla su qualcun altro, nel caso in cui la decisione sia già stata presa. Insomma, in questa specifica circostanza la somma degli addendi “paura” e “precauzione” non fa “responsabilità”, bensì il suo contrario.
Rispetto al reagente teoretico qui impiegato, appare ulteriormente singolare che ad appellarsi a questo principio ir-responsabilità – sostenendo che a decidere sulle zone rosse sia stato e poteva essere il solo governo nazionale – siano gli stessi attori politici che nel 2017 hanno promosso i referendum consultivi sulle autonomie regionali, cavalcandone poi il previsto esito. Coloro che delle piccole e piccolissime patrie, con l’annesso decisionismo localistico, hanno fatto il proprio core business politico. Chi ha lottato per avere il diritto di “prendersi la responsabilità”, per sottrarsi finalmente al giogo di una etero-determinazione dall’alto, scopre così, suo malgrado, quanto disagevole possa rivelarsi la posizione di chi deve esercitare una simile responsabilità in concreto. È banale, ma dati i tempi forse non inutile, ricordare che “prendersi la responsabilità” significa non solo accollarsi la decisione, ma anche assumersene le conseguenze. Tutte le conseguenze, quali che siano.
Un’ultima osservazione a chiudere queste pagine. Prendendo in esame il caso della conferenza stampa giornaliera della protezione civile durante la prima fase pandemica ho inteso riferirmi alla versione naif, per così dire (ma proprio per questo assai lampante), di un fenomeno di più ampia portata: a ciò che, in generale, sono diventati i numeri e le statistiche negli ultimi anni, al modo in cui scandiscono il nostro vivere comune. Meglio ancora: a ciò che li abbiamo fatti diventare, a scopo di propaganda. Penso, in particolare, ai dati del PIL, a quelli dell’Istat, dell’OCSE, della disoccupazione… i quali si sono gradualmente trasformati in dei significanti così scissi, così “esonerati” (in senso gehleniano) dai rispettivi significati, al punto che ormai potremmo tranquillamente trovarci al cospetto di un tasso di disoccupazione prossimo allo zero senza che un simile dato implicasse un effettivo miglioramento della vita concreta delle persone. Verosimilmente, neppure ce ne stupiremmo troppo. Tutto questo perché nel frattempo – mi limito a elencare uno tra i moltissimi esempi possibili – sono nati (abbiamo permesso che nascessero) cose come i poor jobs, con il risultato che ha smesso di valere l’equazione, apparentemente naturale in un contesto democratico, tra l’avere un lavoro e il ricavarne il necessario per vivere dignitosamente. Ma di un simile cambio di paradigma semantico i dati numerici, cioè chi li produce e li maneggia, stentano a rendersi conto, sicché economia e politica continuano a inseguire quelle cifre e quei dati in cerca di una legittimazione e di una guida che questi, nel frattempo, non sono più in grado di fornire.
Sulla scorta di una tale constatazione, devo parzialmente rettificare quanto ho scritto in precedenza, ossia che i dati numerici «non parlano da sé e in regime di soliloquio o di monologo». Al contrario, questo è un classico caso in cui i numeri parlano davvero da soli, ma lo fanno nel senso che non si pongono più neppure il problema di rimandare a qualcosa che sia altro da loro. Il regime discorsivo aritmetico si fa qui puro solipsismo, autismo compiuto. Ne segue la presa d’atto di un’evidenza paradossale ma difficile da contestare: che il proliferare dei numeri e dei dati, il loro sistematico raffinamento coincida con la loro graduale perdita di intelligibilità. In una formula: più sono, meno significano e non certo, come vorrebbero i pasdaran del datismo, per sole ragioni di aumento di complessità. La finanziarizzazione dell’economia incarna l’esemplificazione più evidente di un simile processo. Da un punto di vista ontologico, quella finanziaria è una “aritmosfera”: un cosmo di entità numeriche, di puri significanti che esistono del tutto separati dalla realtà (l’economia reale), ma allorché, malauguratamente, la intersecano rischiano di annientarla. La crisi del 2008 con i suoi strascichi sta ancora lì a dimostrarlo. Insomma, visto da quaggiù l’iperuranio degli enti aritmetici ideali appare molto diverso dall’Eden vagheggiato dal Platone degli ultimi dialoghi (il Filebo su tutti).
p.s. Un amico che, insieme ad altri, ha avuto la bontà di revisionare queste pagine prima che diventassero irrimediabilmente pubbliche, e ai quali esprimo anche qui la mia gratitudine, mi ha informato che in Germania il governo ha istituito dei comitati di gestione dell’emergenza pandemica (delle task force) nei quali sono presenti esponenti delle «due culture»: non solo scienziati, dunque, ma anche “umanisti”, filosofi compresi. In linea di principio, si tratta di una notizia che non posso non accogliere con favore, anche se sarei molto curioso di capire come procedono in concreto queste jam sessions tra saperi ovvero: chi dirige l’orchestra, chi suona il primo violino e a chi viene affidato il triangolo.
Note
[1] Così Günther Anders caratterizza la sua «filosofia d’occasione», posta a base dei due volumi de L’uomo è antiquato (cfr. G. Anders, L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’era della seconda rivoluzione industriale [1956], tr. it. L. Dallapiccola, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 17).
[2] Questa la definizione di Castells: «Con network society ci riferiamo a quella struttura sociale risultante dall’interazione tra organizzazione sociale, cambiamento sociale e paradigma tecnico costituito a sua volta da informazione digitale e tecnologie della comunicazione» (M. Castells (Ed.), The Network Society: A Cross-cultural Perspective, Edward Elgar, Cheltenham / Northampton 204, p. XVII).
[3] W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [1936], in: Id., Opere complete VI. Scritti 1934-1937, tr. it. a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2004, pp. 271-303 (citazione p. 302).
[4] «Il datismo sostiene che l’universo consiste di flussi di dati e che il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all’elaborazione dei dati» (Y. N. Harari, Homo deus. Breve storia del futuro [2015], tr. it. M. Piani, Bompiani Milano 2018, cap. 11).
[5] Sul tema si può vedere: R. Capurro, Einführung in die digitale Ontologie, in: G. Banse, A. Grunwald (Hrsg.): Technik und Kultur, KIT, Karlsruhe 2010, pp. 217-228.
[6] Riprendo questa citazione da James Lovelock, il padre dell’ipotesi Gaia (cfr. J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia [1979], tr. it. V. Bassan Landucci, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 10).
[7] G. Vattimo, Introduzione a H.-G. Gadamer, Verità e metodo [1960], tr. it. G. Vattimo, Bompiani, Milano 20043, p. LIX.
[8] H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica [1979], tr. it. P. P. Portinaro, Einaudi, Torino 2009, p. 48.
Fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=38531


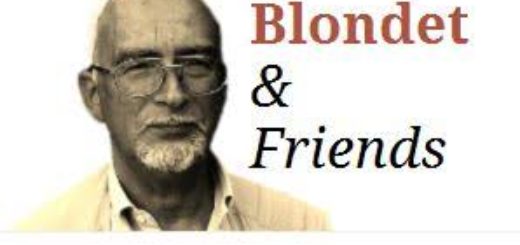





























Commenti recenti