Tipi di atto e voto elettorale: l’ennesima ragione per cui senza partiti popolari non c’è democrazia
di MARCO DI CROCE (FSI-Riconquistare l’Italia Roma)
Dall’articolo di Oreste Massari per “Democrazia e diritto” (n. 3-4, 2009) ricaviamo le seguenti informazioni: negli anni ’50 il 10% circa degli elettori italiani era iscritto a uno dei principali partiti in parlamento, il tasso più alto di tutti i maggiori paesi europei, 4 milioni di persone. La popolazione totale era di circa 48 milioni; negli anni ’90 la cifra assoluta si dimezza: scendiamo a 2 milioni di iscritti a un partito, con una popolazione che è salita a 56 milioni circa. Parliamo, dunque, di circa il 4% dell’elettorato attivo, che nel 2003 sale timidamente al 5% (il processo è lo stesso negli altri maggiori paesi europei, e l’Italia rimane dunque in testa alla classifica).
Riporto questo passaggio interessante:
«Sul versante del partito nel territorio, è interessante notare come gli anni dopo il crollo siano stati anni di tentativi di innovazioni organizzative nelle strutture di base. Un po’ tutti i partiti rigettano il modello della sezione territoriale, legata al modello del partito di massa, adottando la formula assai più leggera dei club, dei circoli (persino RC!), delle aggregazioni tematiche o legate a gruppi di interesse. Ma non pare che questi tentativi siano stati soddisfacenti, basati com’erano sulla pura contingenza e talvolta improvvisazione. Se i partiti al centro sono svuotati, non sono più strutture di partecipazione effettiva, basata su una catena di organizzazioni collettive e di organi collegiali, non sono più capaci di costituire i terminali di processi rappresentativi e decisionali che partono dal basso, anche alla base gli effetti non possono che essere quelli di un attivismo velleitario e vuoto di prospettiva. Insomma, il partito sul territorio cessa di essere negli anni della transizione il fulcro dell’organizzazione partitica. Il centro di gravità dei poteri interni appare ancorato da una parte al partito centrale e dall’altro al partito degli eletti».
I numeri di oggi non sono certi. Il PD conta circa 400.000 iscritti, il M5S 135.000, della Lega non sono disponibili dati se non un affermazione del feb. 2020 che parlava di boom di iscrizioni al nuovo partito (Lega-Salvini Premier) con 50.000 iscrizioni e altre 50.000 tessere in stampa (li considereremo 100.00 per i nostri calcoli), FI ne conta circa 105.000 nel 2015, di FdI non sono disponibili dati. Sono questi i partiti politici più importanti, per un totale da prendere con le pinze di circa 740.000 iscritti. Aggiungiamo un generoso e ipotetico numero, 100.000 iscritti FdI e siamo a 840.000. Arrotondiamo, per generosità, a 1 milione di iscritti ai principali partiti politici italiani (considerate che +Europa ha 2.596 iscritti, comunicati nel loro sito per “trasparenza”, e che il PC non ha più di 5000 iscritti, quindi sono numeri che contano poco in questi calcoli).
Possiamo dire con un certo grado di certezza che il numero di iscritti ai principali partiti politici si è ulteriormente dimezzato dagli anni ’90 a questa parte.
DEFINIZIONE DI DUE TIPI DI ATTO
Veniamo a noi e alla distinzione tra atto politico e atto economico. Cosa distingue l’atto economico da quello politico?
1- Per dare una definizione positiva minima di atto economico possiamo dire questo: l’atto economico si svolge in un rapporto di disuguaglianza qualitativa tra chi svolge l’azione e colui a cui l’azione è diretta. Questa disuguaglianza è quella che c’è tra l’acquirente-utente-consumatore e l’offerente-produttore-venditore. Se l’azione è legata concettualmente a questo inquadramento dei soggetti e non potrebbe esistere al di fuori di questo inquadramento schematico, allora l’atto è economico. Indipendentemente dal fatto, certamente possibile, e anzi frequente, che l’azione economica sia il precipitato di un fine politico o di una fede morale, la quale precipita e in un atto economico e in un atto politico, e indipendentemente dal fatto, che segue da quanto detto, che una azione economica possa avere “valore politico”, cioè possa essere fatta con un’intenzione politica che si *aggiunge* a quella economica, non sostituendola, e che questo valore non sia necessariamente accessibile solo a chi fa la cosa ma possa esserlo anche a chi gli sta attorno ed è in grado di capirla.
2- La definizione positiva di atto politico, in questa occasione, non interessa. Se sopra abbiamo dato una condizione “sufficiente” a identificare un atto economico, qui, per quello che segue, ci basta identificare una condizione “necessaria” dell’atto politico, tale per cui potremo dire che, qualora questa caratteristica non sia presente, l’atto non è politico. Forse si potrebbe anche sostenere che la caratteristica che indicherò sia anche sufficiente, ma la cosa in questa occasione non ci interessa. Per dare una definizione negativa minima di atto politico, potremmo dire qualcosa del genere: l’atto politico si svolge in un rapporto di eguaglianza qualitativa tra chi svolge l’azione e colui a cui l’azione è diretta (azioni linguistiche rientrano nel concetto di azione chiaramente).
Se questo è vero, allora l’azione politica ha la peculiarità di essere un’azione intrinsecamente bidirezionale, cioè non ci sono un agente e un paziente. Dunque si potrebbe chiamare il rapporto tra i soggetti che agiscono politicamente una forma di vita o una comunità di vita, ma su questo ci torniamo dopo.
Da notare che anche l’astensione è una azione e può ricadere in una delle categorie di sopra, infatti una cosa è “non fare x”, un’altra è “fare non x”.
SCOLIO E ALCUNI ESEMPI
Dalle definizioni 1 e 2 segue che un’azione politica non è economica e che un’azione economica non è politica. Come coniugare questa conclusione con quanto detto nella def. 1, cioè che un’azione economica può avere un valore politico? Mi sembra che la soluzione migliore al problema sia considerare quei casi che rientrano in questa categoria come azioni complesse, cioè come due azioni legate contingentemente a scopo simbolico.
Presento qualche esempio che si legge in fretta ma che si può saltare.
Poniamo che Luca decida di non comprare smartphone dopo essere venuto a conoscenza del “modello di lavoro” dietro l’estrazione del Coltan, minerale indispensabile per la produzione di smartphone estratto per l’80% in Congo in condizioni di schiavitù. Cosa sta facendo Luca? Forse Luca non vuole partecipare al peccato, non vuole finanziare lo sfruttamento di esseri umani. Forse Luca vuole punire, nel suo piccolo, chi ha messo in piedi questa operazione e chi ne è complice, non finanziandolo. Questo è un atto economico: Luca ha deciso di astenersi dall’acquistare uno smartphone. Ma probabilmente Luca ne ha parlato con i suoi amici quando ha scoperto del coltan, e ha spiegato l’orrore legato all’estrazione di questo minerale provando a comunicare quanto sia sbagliato che esista qualcosa di simile nel mondo e che ogni rapporto di lavoro dovrebbe essere regolato da un contratto giusto. Gli amici forse hanno detto che è terribile e che non dovrebbe accadere e che se una cosa del genere accadesse in Italia bisognerebbe fare qualcosa, ma che accadendo in Congo c’è poco da fare, non c’è modo di intervenire. Luca potrebbe rispondere che comunque bisognerebbe non partecipare del misfatto, astenendosi dal comprare questi cellulari, oppure potrebbe essere sostanzialmente d’accordo e tuttavia astenersi, perché la sua coscienza gli impone di farlo. Essendo il fatto in questione fuori dalla giurisdizione del potere legislativo di cui Luca è partecipe, questo esempio porta complicazioni che è meglio evitare.
Cambiamo un po’ l’esempio. Luca scopre cosa sono il contratto da stagista e il contratto a tempo determinato e viene a sapere che il personale di una azienda di lampade vicino casa sua è composto per lo più di stagisti che lavorano anziché imparare e di lavoratori a tempo determinato. Secondo Luca il contratto di stage è una presa in giro e il contratto a tempo determinato è un modo di esercitare pressione sui lavoratori, con la tacita minaccia che “se rompi li cojoni non ti rinnovo il contratto”. Luca smette di comprare lampade lì: è un atto economico. In più, Luca parla dell’ingiustizia dei contratti di lavoro a tempo determinato come forma tipica del contratto di lavoro con molti suoi amici e conoscenti. Luca prova a spiegare loro che bisognerebbe rendere il contratto di lavoro a tempo indeterminato la forma tipica di lavoro, che è giusto che sia così. Quando parla di queste cose con qualcuno, costui gli risponde approvando o provando a convincerlo del contrario: i ruoli di ascoltatore e parlante sono invertiti in continuazione perché Luca sta dialogando. Questo non è un atto economico ed è almeno candidato a essere un atto politico: il tentativo di Luca di rendere maggioritaria la sua proposta di ordinamento del contratto di lavoro è fatto di conversazioni con suoi eguali.
Si tratta, dunque di due azioni diverse: l’atto economico e l’atto politico. Ma in che senso l’atto economico ha valore politico? Luca ha una ragazza che si trasferisce a casa sua. Luca e la sua ragazza cercano una lampada per casa e la trovano a 50€. La sua ragazza dice di averla vista a 30€ in un negozio vicino casa ma Luca diventa molto serio e dice che lui lì non compra niente e che i 20€ in più li può mettere lui, se per lei è un problema. La ragazza, un po’ sorpresa, chiede perché. Luca spiega che non compra lì perché è un’azienda che ha quasi esclusivamente lavoratori a tempo determinato e stagisti, e non gli importa che sia legale: è ingiusto. La ragazza è colpita. Sapeva già che secondo Luca il contratto di stage e quello a tempo determinato sono strumenti di ingiustizia, ma nel vedere che questa convinzione ha conseguenze nel modo in cui Luca agisce, capisce che è una cosa importante per lui. Ne deduce un maggiore grado di probabilità che Luca ritenga onestamente che sia un’ingiustizia, perché se fosse un pensiero espresso durante le conversazioni a cena, ma che non vede mai la luce del sole, potrebbe anche essere una cosa secondaria. Invece Luca, evidentemente, ci tiene.
In questo caso, quello di Luca è un atto complesso. Luca sta facendo due cose contemporaneamente: un atto economico di astensione dal comprare una lampada, un atto, almeno candidato a essere politico, di egemonia sulla propria ragazza. Luca sta, in effetti, usando il suo atto economico per fare un atto politico: porta come argomento a favore della sua tesi politica un fatto, che esiste almeno una persona (lui) sufficientemente convinta della verità della sua tesi da modificare la sua vita privata. Non è un argomento dimostrativo, certo, ma aiuta chi ascolta a valutare la questione in termini di azione. È come se Luca dicesse: si può cambiare. Ma solo a livello simbolico, perché in realtà l’azione di Luca non dimostra affatto che si può cambiare. L’unico cambiamento che Luca produce con il suo atto economico è la diminuzione del fatturato di una azienda di lampade, non certo la legislazione sul lavoro. Ma Luca, prendendo una posizione attiva, seppure su un piano completamente diverso da quello politico, comunica la possibilità dell’attività in generale. Ci sono due azioni diverse, dunque: quella economica e quella politica, e quella economica, in quanto è una azione, può essere usata simbolicamente per sollecitare nell’ascoltatore il modo di ragionare di chi è in grado di agire.
VOTARE È UN ATTO ECONOMICO
Bene, ora un altra domanda: cosa è votare? Che azione è, quella che facciamo quando depositiamo il nostro voto in un’urna?
Nell’immaginario democratico liberale il momento del voto è quello in cui tutti fanno qualcosa di politico, il motivo è ovvio. Certamente il voto ha conseguenze politiche, nell’accezione comune, o almeno può averle nella misura in cui i partiti che possono essere votati hanno fini diversi. Eppure, l’atto del voto è legato a uno schema economico: il votante e il votato rientrano comodamente nello schema del rapporto tra soggetti che si dà quando una azione è economica. Il votante dà il voto al partito e, in cambio, il partito fornisce, o promette di fornire (come fa qualunque venditore) qualcosa in cambio (una riforma per esempio). I partiti hanno un’offerta, ognuno propone una cosa diversa, e il votante si informa sulle diverse offerte presenti sul mercato, sceglie quella che preferisce, facendo un calcolo dei rischi che l’offerta votata non raggiunga il numero di voti necessario a diventare reale, e la vota. Si tratta dunque, a tutti gli effetti, di un atto economico. Non si usa denaro corrente, ogni persona ha la stessa quantità di valuta (1 voto) ma l’atto rimane di per sé economico.
Ora, quel che è interessante non è il valore politico che questo atto può avere, ma il fatto che questo atto sia economico. Sembrerebbe, infatti, essere l’unico atto propriamente democratico istituzionalmente strutturato, fatta eccezione per alcune procedure possibili come le raccolte firme per presentare leggi o riforme di iniziativa popolare. Insomma, l’unico atto che distingue una democrazia da un’oligarchia sia un atto economico che permette di scegliere i capi. In fondo, Kelsen, quando dava una definizione realista della democrazia, diceva qualcosa di questo tipo: la democrazia rappresentativa è il sistema in cui si sceglie il capo. È proprio così, è tutto qui? Qualcuno potrebbe rispondere che no, ci si può anche candidare, e va bene, ma comunque si viene o meno scelti. Il popolo non può essere scelto tutto intero, dunque il problema non è affatto eliminato dalla possibilità di far parte dell’offerta: il problema non è che non tutti hanno la possibilità formale di essere decisori (ce l’hanno), il problema è che non tutti sono decisori.
SOLUZIONE DEL PROBLEMA: COME FARE ENTRARE TUTTI IN PARLAMENTO
Se gli unici dispositivi di comunicazione col parlamento fossero la conversazione personale (atto politico possibile in qualunque sistema politico), il voto (atto economico) e la candidatura (atto economico), saremmo nella strana condizione di avere un sistema politico, la democrazia rappresentativa, che si distingue dagli altri per la possibilità di due atti economici. Chi sostiene che la democrazia sia effettivamente così, non la pone in questi termini, chiaramente. Ma posta la questione in questi termini, cosa bisogna aggiungere per ottenere la democrazia rappresentativa?
Se il problema è quello di far partecipare tutti politicamente al processo decisionale, la soluzione c’è: l’iscrizione e la partecipazione alla vita di un partito popolare, cioè una associazione di persone che assieme svolgono le seguenti attività:
1) discutono, studiano, e provano a cooptare nuovi membri perché più persone studino, discutano e si formino, al fine di elaborare proposte di legge, di società, di modelli di organizzazione;
2) formano e selezionano, tra le loro fila, una classe dirigente, cioè dei candidati per le elezioni e cooptano nuovi membri al fine di formare più persone al ruolo di dirigente.
Tutti gli atti, a parte le votazioni, che avvengono all’interno di un partito sono atti non economici e, almeno potenzialmente, politici: la discussione su come agire, la formazione reciproca, la discussione di proposte, riforme e modelli di società. Ma se nell’atto politico i soggetti sono qualitativamente uguali, allora in questi atti non c’è un agente e un paziente: c’è, piuttosto, tra i soggetti, una comunità o forma di vita. Se si riesce nella formazione di un partito, allora, i membri che questo partito candida sono quanto di più vicino vi sia alla candidatura di tutti i militanti del partito, perché sono tutti membra della stessa cosa.
Voi direte, non è ancora democrazia diretta, ed è ovvio, ma è la differenza sostanziale con qualunque altro modello politico: la possibilità per tutti di associarsi in comunità di vita per progettare la società, progetti che possono effettivamente essere proposti e valutati e approvati da tutti. Qui, e non in cabina, è la democrazia.



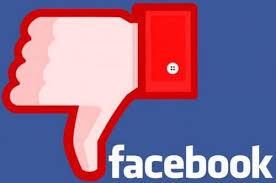



























Commenti recenti