Volere è economia
Giacomo Gabbuti 404 Segue un commento e la risposta dell'autore, tratti dalla fonte.
[…] il problema è, c’è posto per tutti sulla macchina? E siamo in grado di nutrire una bocca in più?” Senza voltare la testa, ripeté la domanda: “Mamma, siamo in grado?”
La mamma si schiarì la gola. “Quanto a ‘essere in grado’, siamo in grado di niente; né partire per la California, né niente. La questione è di sapere se ‘vogliamo’ prenderlo con noi, o no. […]
In quello che dovrebbe essere considerato un testo cardine dell’Economia Politica, John Steinbeck spiega – nel modo più rigoroso con cui si possano descrivere le passioni alla base dei comportamenti, umani prima che economici – la scelta razionale degli individui, quanto agiscano non da atomi (come li descrive la “moderna” microeconomia) ma da esseri sociali.
È una lezione importante, quella di Furore: perché da mesi, quotidianamente, siamo bombardati da un altro tipo di messaggio. Quando si parla dello Stato come di una famiglia, in cui “non bisogna spendere più di quanto si guadagna”, in virtù di una presunta moralità del debita sunt servanda, in realtà si allude a una diversa idea dei rapporti che fondano le società umane:
si rappresenta la comunità come una barca che sta per affondare, in cui i naviganti debbano razionalmente scegliere chi sacrificare per il bene comune. Una di quelle scelte assurde e paradossali su cui, come ben spiega l’antropologo David Graeber, si basa la moderna economia neoclassica: eppure, anche se posti in una situazione così estrema, in un contesto così alienante, siamo davvero sicuri che risponderemmo tutti, inequivocabilmente, come la teoria ci imporrebbe? Siamo tutti sicuri che selezioneremmo gli individui più deboli – pardon, meno meritevoli –, chi meno è in grado di contribuire alla causa comune, per gettarli – o convincerli con argomenti moderati a tuffarsi giù, virtuosamente – via dalla barca?
Capite bene che, così in astratto, questa domanda sembri priva di senso.
In primo luogo, dovremmo chiarire chi sono gli altri membri dell’equipaggio. Siamo sicuri che la risposta sia infatti la stessa, se per il ruolo di vittima sacrificale assoldassimo, uno alla volta, l’amore della nostra vita, nostro nonno, una sorella piccola? Siamo sicuri che li lasceremmo in mare? O che tutti i nostri simili lo farebbero? Siamo sicuri di credere, come sintetizza un lettore di Sylos Labini, di doverci procurare da soli la bistecca di mammut?
Eppure, quella del cacciatore paleolitico è esattamente la teoria sociale che ci propone chi – con la presunzione di sancire verità incontrovertibili – pontifica illustrandoci la propria, personale interpretazione di “insostenibile”. Quella di chi continua a spiegarci come non possiamo più permetterci la spesa sanitaria (sia essa in Italia o negli Stati Uniti) senza curarsi di informarci del fatto che la sua entità sia perfettamente paragonabile, per fare un esempio a caso, alla spesa per armamenti, o ancora peggio, nettamente inferiore a quella per gli interessi sul debito (è il caso della Spagna).
Quanto a ‘essere in grado’, siamo in grado di niente; né Medicare, né Iraq. La questione è di sapere cosa ‘vogliamo’. Questo, solo questo dovremmo aspettarci di sentire da un tecnico, che insegni a Chicago come Zingales o sia chiamato ad incarichi istituzionali come Monti. L’argomentare di Steinbeck è ragionevole, moderato, concreto: il loro, semplicemente disumano.
Sempre in Furore, di fronte alla scelta risoluta del nonno di non abbandonare la propria terra natia per migrare in California, i figli e i nipoti decidono, razionalmente, di ubriacarlo e trasportarlo via con l’inganno.
In un momento di lucido isolamento, il vecchio aveva deciso di non voler sopportare l’umiliazione di separarsi dal suo terreno, dal destino dei suoi avi. Ma la sua scelta libera, ottimale rispetto al suo punto di vista di “uomo d’onore” (se si passa il termine), non tiene conto della sua funzione sociale di capofamiglia: ed è in virtù di quella sua funzione che il suo clan non può permettergli la scelta libera e razionale. Prima che un uomo dall’orgoglio ferito, il nonno è il capotribù, e come tale va forzato a seguire la famiglia nel viaggio della speranza verso la California: eppure quanto razionale sarebbe stato non dover sfamare una bocca di più!
Si badi bene: qua non si vuol fare del sentimentalismo spicciolo. Non si intende contrapporre un familismo amorale al freddo calcolo scientifico: si vuole invece, in modo forse naïf ma a nostro giudizio cruciale, costringere tutti noi, per un momento, a sostanziare le scelte economiche, ricondurle, da una pretesa astrazione e naturalità nella quale le estrania la teoria dominante, ad un contesto più reale e comprensivo, in cui la sfera economica è solo una delle tante, sovrapposte sfere di attività umana.
Dobbiamo prevenire qui due critiche prevedibili. La prima, quella del “non tecnico”, di chi si chiede cosa ci spinga a baloccarci con simili ovvietà. Critica cui è purtroppo elementare rispondere, poiché è su questo tipo di assunzioni che si fonda la moderna “tecnica”; in relazione a questo prototipo di individuo, che nessuno di voi ambirebbe frequentare (figuriamoci imitare), è modellato il vostro comportamento, la vostra risposta razionale agli stimoli di natura fiscale o altra messi in campo dal governo.
Ciò ci conduce naturalmente alla seconda obiezione, quella dell’economista: che cioè questo sia un sacrificio necessario; che come argomenta lo stesso Krugman, i modelli sono perfettibili ma rispondono ad un superiore intento scientifico, che non ammette inversioni di rotta.
L’economista, nel descrivere la realtà, non dovrebbe cedere alla tentazione della metafora, ma rimanere al dato, crudo e asciutto. Non siamo d’accordo, e ci appelliamo a un grande scienziato sociale come Marc Bloch per confutare questa obiezione:
“Non c’è minor bellezza in una equazione esatta che in una frase ben formulata. Ma ogni scienza ha un’estetica del linguaggio, che le è propria. I fatti umani sono, per essenza, fenomeni assai delicati, e molti di essi sfuggono al calcolo matematico. Per tradurli bene, e quindi per penetrarli a fondo (giacché si comprende mai perfettamente ciò che non si sa dire?), sono necessari una grande finezza di linguaggio [un giusto colore nell’espressione verbale]. Laddove è impossibile calcolare, occorre suggerire.”
Anche perché, a vedere bene, i dati con cui, nel trambusto del dibattito scientifico e poi politico, vengono messe a tacere le metafore (o presunte tali) – siano esse keynesiane o più generalmente umaniste – sono sempre più scollegati. Non solo dalla realtà, nel momento in cui, con l’astrazione del PIL, continuano a rappresentare le aspirazioni e i desideri di una società – quella della crescita esponenziale, del consumo come misura del benessere – che, se esiste ancora, va declinando, perlomeno della sua versione occidentale, assediata dagli spettri delle nuove povertà e dal bisogno di un nuovo “patto sociale” che riveda al ribasso le aspettative di felicità dei suoi giovani abitanti.
Il punto è che i loro dati sono sempre più scollegati dalla stessa realtà di carta, quella che si raccontano, tra di loro, gli addetti ai lavori, per convincersi che stanno facendo la cosa giusta. Le cifre, in primo luogo, sono sempre più spesso diverse da quelle che si prevedevano, e sulla base delle quali si erano fatte e disfatte proiezioni, costringendo ogni giorno alla patetica, sistematica revisione delle prospettive di (non) crescita (avviene in Italia come in Portogallo). Ma alla radice del problema c’è l’angoscia crescente che emerge nel rendersi conto, ogni giorno che passa, della completa assenza di un quadro concettuale in cui inserirli, quei numeri, per dargli senso. Perché nessun dato ha senso di per sé – e qui parliamo di stime, di elaborazioni: non di chili, volt o mele, ma di valore. È una teoria di riferimento a dare motivo alla misurazione; è in virtù di una teoria che si raccolgono i dati, e a quella teoria i dati danno risposta affermativa o negativa, non ad altre.
Come lo scrittore-Quinn/aspirante-ispettore-Auster, osservando gli appunti sul taccuino rosso rimaniamo profondamente delusi.
Aveva sempre immaginato che la chiave di un buon lavoro investigativo fosse l’osservazione ravvicinata dei particolari. Più accurato il rilevamento, più positivi i risultati. La premessa era che il comportamento umano si possa comprendere, che dietro l’infinita facciata di gesti, tic e silenzi ci siano una coerenza, un ordine, un movente.
La sorprendente confessione di Olivier Blanchard sembra in effetti dirci questo: non soltanto non riusciamo più a prevedere con precisione ciò che ci prefiggiamo di misurare e pilotare; non abbiamo più un’idea chiara del perché, di cosa stiamo osservando.
Dopo aver lottato per afferrare tutti questi effetti di superficie, Quinn non si sentiva più vicino a Stillman di quando gli si era messo alle calcagna.
E pensare che uno dei grandi patriarchi della tradizione neoclassica, “nonno” Lucas, aveva condotto la riscossa anti-keynesiana sulla base di una semplice, ma allora sconvolgente affermazione. La sua critica della politica economica allora mainstream, basata sulla elaborazione di complessi modelli macro-econometrici, era tutta centrata su un’idea cardine: che i parametri fondamentali dell’economia non siano immutabili. Non esistono “tassi di risparmio” fissi, immutabili nel tempo, indipendenti dallo spazio e dal tempo. Questi sono il risultato delle scelte, più o meno consapevoli, degli individui che compongono il sistema economico. Se è vero che molti dei comportamenti sono istintivi, abitudinari e regolari, almeno una parte è intrapresa consapevolmente, elaborando gli stimoli che riceviamo dall’ambiente circostante. L’intuizione di Lucas è proprio questa: leggendo il giornale, ognuno di noi adatta le proprie scelte su quelle che sono le decisioni di chi ci governa. E allora i parametri – quelli stimati dai tecnici, prima, e sulla base dei quali si decidono, poi, le politiche pubbliche – non sono indipendenti da quelle stesse scelte: e il politico (o l’economista che lo suggerisce) devono ideare politiche pubbliche che siano coerenti con la reazione che inducono nei cittadini.
I nipotini di Lucas, oggi, confessano errori estremamente più banali: hanno basato le scelte di domani sui dati di ieri, quando erano perfettamente consapevoli che, tra la notte di ieri e la mattina di oggi, il mondo era cambiato. La crisi dei mutui subprime ha mandato gambe per aria colossi della finanza mondiale; Stati ieri sovrani sono oggi costretti a genuflettersi di fronte al giudizio dei “mercati”; persino il debito pubblico statunitense, un tempo sinonimo di “investimento sicuro”, ha perso la tripla A;. Eppure, per i tecnici cresciuti all’ombra del Washington consensus, nulla sembrava essere davvero cambiato: non c’è nulla che renda necessario aggiornare i dati, i modelli sulla base dei quali si descrive l’andamento dell’economia.
Ma evidentemente non era così: i numeri su cui si basano le prescrizioni della Troika sono d’improvviso lettere bizantine; continuano a descrivere Imperi là dove esistono solo macerie; ordinano la ritirata a divisioni già spazzate via.
È qui che il tecnico si trova spiazzato, braccato, chiuso in un angolo: i dati vecchi sono inservibili, ma non può sostituirli con dati nuovi. C’è bisogno di tempo per raccoglierne, e in questo caso, probabilmente, c’è anche da sedersi a un tavolo per ripensare, decidere insieme cosa si vuole misurare, cosa merita di esser tenuto di conto nel prossimo futuro.
Eppure (s’ode da ogni parte) occorre sbrigarsi, le decisioni vanno prese: ce lo chiedono l’Europa, i Mercati – persino i cittadini, talvolta. E allora, se non è possibile calcolare, serve l’economista – non il tecnico! – a suggerire, proprio come spiegava Bloch.
“Tra l’espressione delle realtà del mondo fisico e quella delle realtà dello spirito umano, il contrasto è, insomma, lo stesso che fra l’opera del fresatore e quella del liutaio: tutti e due lavorano al millimetro; ma il fresatore usa strumenti meccanici di precisione; il liutaio si orienta, prima di tutto, con la sensibilità dell’orecchio e delle dita. Non sarebbe bene né che il fresatore si contentasse dell’empirismo del liutaio, né che il liutaio avesse la pretesa di scimmiottare il fresatore. Si negherà che vi sia un ‘tatto’ delle parole, come ve n’è uno della mano?”
COMMENTO TRATTO DALLA FONTE
DAVIDE:
"Commento l’articolo che mi ha consigliato un’amica.
Le critiche all’economia politica (descritta qui con la ‘p’ minuscola) partono da un vago viaggio storico e da una opinione: la crisi degli economisti in quanto tali.
La presunta crisi degli economisti, io non la vedo. Mai il dibattito è stato così acceso e fervente, mai ho visto posizioni più contrapposte e vessilli e bandiere portate avanti da più valorosi cavalieri. La crisi del 2007 è stata una straordinaria fucina per ravvivare il dibattito. Prima ancora, nell’epoca del debito pubblico moltiplicatore e moltiplicato a dismisura, (prendendo come pretesto alcune parole di Keynes, estrapolate e scollegate dall’ambito in cui erano state dette, classico esempio della politica della peggior specie) hanno fatto crescere il dibattito sull’efficienza o meno dell’intervento statale. Ancora più moderni gli istituzionalisti a ricordarci che esistono fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato ed occorrono regolatori ed altre istituzioni per un giusto funzionamento. Rigorosi e puntigliosi i turbo-liberisti, affascinanti argomentatori e molti intelligenti nelle loro autocritiche come Zingales con il Salvare il capitalismo dai capitalisti o il Blanchard già citato (è da stupidi non cambiare mai idea). Un po’ esoterici quelli che avevano previsto tutto come Roubini. Il campo insomma è vasto e pieno di rigorosi argomentatori.
La crisi è declino non prosperare di dibattito ed opinioni.
L’equivoco sull’economia è dimenticare che le teorie ed i modelli economici devono essere spiegati e rilegati con ben definite ipotesi, tesi, verifiche empiriche o dimostrazioni logiche, al pari di qualsiasi altra scienza (o meglio dire arte). Senza queste necessarie condizioni non si può fare l’economista politico, qualsiasi altro che ci provi diversamente è solamente un “chiacchieratore da bar”. Purtroppo da non addetto ai lavori mi limito a difendere la categoria e non pretendo di rappresentarla, ma l’Economia Politica è necessariamente con la P maiuscola, perchè è nobile arte che cerca di capire il funzionamento delle società umane, per quanto complesse siano e in base a questo cerca di migliorarne il funzionamento. Tutto il resto dell’articolo è politica (questa merita una p maiuscola) ed è altra cosa".
RISPOSTA DELL'AUTORE
GIACOMO GIBBUTI:
"Caro Davide, ti ringrazio del commento.
Evidentemente non è un testo “argomentativo”, né pretendo di fare una “critica” dell’Economia Politica: alla base in fondo non c’è neanche un “vago viaggio storico”, sono solo appunti (suggestioni ho scritto nel titolo), coagulate da uno studente di Economia.
Non credo ti convincerò, ma la mia percezione é che il dibattito non sia così radicale come lo descrivi te: per citare Messori, se il ’29 ha prodotto Keynes, dopo il 2007 i macroeconomisti non hanno messo in soffitta nessun modello, al più han battagliato sulla rilevazione di alcuni parametri. Qualche testa è volata, ma in fondo sono tutti ancora là, e tutti ancora propongono cose non così diverse da quelle che proponevano nel 2007.
Come argomentano qui: http://blogs.hbr.org/fox/2013/01/the-end-of-economists-imper.html, nonostante iniziative meritevoli come l’INET, ad oggi molto poco sembra esser cambiato nell’impostazione di un Graduate Program: eppure sembra chiaro a molti che la macro come si insegnava prima della crisi – senza il sostegno della storia economica, senza l’abitudine a considerarla, come tu dici, arte e non scienza (non è così che te la insegnano l’economia, oggigiorno! Ché Fornero si sente un’artista?), e a vagliare diverse ipotesi ed assunzioni. E quando parlo di assunzioni, non parlo della scorza, non parlo delle “frizioni” di un modello neokeynesiano che di fatto assume tutto quello che assume un neoclassico: ma riguardo la polpa, la radice, l’impostazione stessa delle questioni. Nei curriculum di sempre più facoltà non esiste più il corso di storia del PENSIERO economico, e sempre più studenti non hanno la percezione del fatto che esso sia emerso in modo dialettico, lungo un arco di tempo lungo. Se avessi voluto argomentare questo, sarei stato molto banale, citando pedissequamente Sen e Stiglitz, perché non invento niente: dalla tribuna di 404, che non è economica, come (giustamente) mi fai notare, mi limito a renderlo da una prospettiva diversa, più “sentimentale” se vuoi.
Gli economisti come sono ora – e anche qui non penso di esprimere nulla di originale – sembrano sempre meno in grado di dare teorie comprensive, e come diceva già Joan Robinson decenni fa, finiscono a parlare di Family Economics o di rette universitarie perché spiegano sempre meno i grandi processi sottostanti la loro stessa disciplina: se ci pensi lo stesso grande filone di ricerca sull’income inequality, che personalmente mi affascina, sembra affastellare dati, ma non riesce a produrre grandi afflati teorici, come era uso della grande Economia Politica del secolo scorso: i modelli sulla base dei quali raccogli dati nuovi (come Keynes “ispirò” la raccolta di dati sulla disoccupazione, che prima non si misurava perché era ritenuta irrilevante: qui continuiamo a parlare degli stessi dati, o di cose come lo “spread”).
E questo, anche qui senza molta fantasia, lo ritengo frutto di una sclerosi, dell’essersi assuefatti ai modelli matematici che, lungi dall’esser inutili, sono però limitanti per tanti aspetti: lo dimostra l’esperienza dei “tecnici”, che quando si trovano di fronte a dei lavoratori reali sembrano spaesati.
Tanto dell’argomentare di un Keynes (che non usa grafici né quasi equazioni) verrebbe oggi deriso in un aula di economia, eppure – lungi dallo “spiegare tutto”, come vorrebbe qualcuno: anche solo perché è l’economia (intesa non come disciplina ma come le relazioni economiche sottostanti) ad esser cambiata nel mentre – quegli argomenti colgono cose che i nostri raffinati modelli non dicono, e l’economista è sempre più a disagio nell’avventurarsi oltre (oppure “vola come vola un tacchino”, e penso al video di Zingales che tanto gira in questi giorni sull’Italia destinata al turismo).
Non nego che ci siano, come non si vedevano da tempo, degni e interessanti alfieri in giro a duellare: ma mi sembra che, se poi vai a stringere, davvero a loro rimanga poco se non la politica per motivare questo o quello, perché le “evidenze” son sempre più condizionate dalle ipotesi di partenza – che si son rivelate spesso errate. E vale tanto per gli Zingales qui da noi, che per gli Stiglitz, i Galbraith Jr. o altri oltreoceano: in fondo nessuno c’ha ancora dato una Teoria, una spiegazione. E di questo non si dibatte in pubblico: al più se ne parla tra scuole, tra sette, tra piccoli cenacoli.
E allora secondo me – e questo era un po’ il senso del mio articolo, che ovviamente non pretende di spiegare né confutare l’Economia Politica – bisogna sospendere un attimo, fare un passo indietro, scendere dal piedistallo (in cui ci “siamo” auto-collocati) di “scienza dura” (pensa alla polemica di Sylos Labini sul “Nobel” per l’Economia), e ricominciare ad osservare il mondo, senza timore di farci contaminare dalle altre scienze sociali da cui indubbiamente ci si è allontanati troppo: perché se è vero che i “top economist” che vediamo in tv non sono poi così ignoranti delle altre discipline, l’esercito di economisti sfornati dall’accademia (nei quali mi colloco senza vergogna), che spesso occupano posizioni di rilievo in istituzioni di mezzo mondo, lo sono, e i danni li vediamo davanti a noi – perché se Blanchard cambia idea, noi siamo ancora lì a proporre di “rafforzare” il Fiscal Compact".



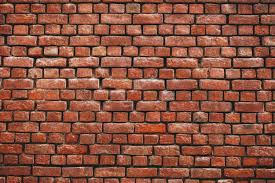



























bell' articolo che però dice cose da cui si dovrebbero trarre indicazioni un pò più radicali:
non è che l'economia (intesa sia come scienza sociale che come summa della prassi sociale) è in crisi: al contrario è il suo stesso strapotere, il suo essere l'essenza stessa dell' essere sociale che la pone nel bilico di una fondamentale inaccettabilità da parte della natura umana.
La semisfera politica di quel intero che è l'economia-politica non è affatto l'autorità umanistica che si impone e controlla il meccanismo economico, ma ne è costitutivamente l'ancella: la società civile, mossa dagli antagonismi dei diversi interessi nella competizione per il profitto, si ricompone (o si divide, che è lo stesso) attorno al suo stesso interesse generale. Interesse generale che si chiama Stato di diritto (di proprietà). Dal mio punto di vista ogni lamentazione e ogni richiamo alla preminenza della politica sull' economia suona stonato.
Eppure nell' articolo è detta una parola che per me è una parola chiave: disumanità dell' economia (meglio: disumanità della prassi sociale). Quello che l'autore non coglie è l'estraneità che la stessa prassi socio-economica impone agli individui che ogni giorno la riproducono semplicemente continuando a fare le cose quotidiane. L' atomismo sociale, qui appena accennato, non può essere ben compreso se lo si coglie dal verso di una pratica individualistica da stigmatizzare: esso è un comando alienato e alienante che ha genesi sociale . La sua disumanità consiste nell'impedire il dispiegarsi di una umanità sempre da conquistarsi.
Che sarebbe questa umanità che volete conquistare?
ho buttato la palla troppo in là, fai conto che l'ultima frase non l' abbia scritta
Concordo sul fatto che il sistema va in rovina nella misura in cui dà realizzazione alla sua fictio dell’homo oeconomicus, l’individuo sradicato mosso da pulsioni egoistiche. Mano a mano che i pregiudizi aggregativi di ordine familiare, politico o religioso si indeboliscono la società divene un arraffa arraffa di banksters reali o aspiranti tali che ambiscono solo a fregarsi l’uno coll’altro.
Non concordo invece col tuo concetto di alienazione, di evidente ispirazione marxista. Non esiste una natura umana primigenia alienata dal comando sociale. Esiste solamente un numero sconfinato di culture (plessi di parametri restrittivi e condizionanti) – tutte ugualmente fraudolente e arbitrarie se esposte al tribunale della ragion critica – entro cui la natura gregaria dell’essere umano trova il proprio ambito di sviluppo.
Il problema odierno è che le enormi potenzialità espansive del capitalismo per un verso hanno elevato all’ennesima potenza la complessità della struttura sociale, per altro hanno indotto un’accentuazione patologica delle componenti atomistiche.
"Non esiste una natura umana primigenia alienata dal comando sociale"
Concordo, del concetto di alienazione marxiana viene spesso data questa lettura elementare, geometrica, di provenienza religiosa (con tutto il rispetto) , lettura alimentata, hai ragione, anche da molti marxisti che a Marx hanno fatto dire tutto e il contrario di tutto.
Senza addentrarci troppo nel concetto marxiano di natura umana, concetto ben presente, ben radicato e in accordo con la consustanzale concezione storica dell' essere umano, l' estraneamento non si contrappone alla perduta pienezza originaria dello stato di natura, al contrario contrappone una potenziale libera individualità (sempre avvertita e mai attualizzata stabilmente) al dominio reificato del sociale, ovvero del politico ovvero dell' economico.
Le tradizioni materiali e culturali testimoniano sia questa potenzialità per lo più inespressa sia, per forza di cose, la potenza sociale a cui esse sono state subordinate, la cui trama si alimenta con l' estraneare sempre più dai soggetti produttori il frutto del proprio operare materiale e spirituale.
Io stesso mi ritengo un tradizionalista (sulla scorta soprattutto di Marx) ma non un passatista, se nella tradizione si coglie la maturazione storica di antichi pensieri e aspirazioni, e proprio in virtù di questo ritengo che le possibilità non si siano affatto esaurite con questa modernità fatta di capitale, stato, mercato, merce, denaro ecc
Per quel poco che capisco di marxismo l'interpretazione che tu chiami elementare è anche quella filologicamente corretta.
E comunque, tutti questi aneliti liberatori sono fantasie per animi religiosi. Aveva ragione Freud quando scorgeva nell'infelicità umana la controparte ineludibile dell'allontanamento dallo stadio animale; l'alienazione è il destino di "un'epoca che ha mangiato del frutto proibito che pende dall'albero della conoscenza" (M. Weber).
no, errato: insisti a pensare l'alienazione come peccato originale. invece l'opposizione alienazione/disalienazione è una delle forze profonde del divenire storico