Exit Dieter Kopp (1939-2022)
di QUOD LIBET, BLOG UNA VOCE (Giorgio Agamben)
Villa Balestra, via Benaglia 10, via di Grotta Pinta 10, via della Penitenza, via del Governo vecchio 115, via Arenula 21, via Paolo II 1 (l’ultimo) – questi gli indirizzi che ricordo, fra i tanti che ha abitato peregrinando a Roma – troppi per mettere, come pure si dovrebbe, una lapide, come quella in via del Mascherone nella casa in cui ha vissuto Wilhelm Waiblinger, il biografo di Hölderlin, «qui finalmente felice». Perché felice Dieter è stato in qualche modo sempre, senza curarsi della povertà o del denaro (quando capitava), del successo (quando capitava) o del disconoscimento.
Laura, la figlia con cui abitava quando l’ho conosciuto e ancora per molti anni dopo, non aveva giocattoli. Un giorno, quasi volesse svelarmi il mistero del gioco della vita e dell’arte, mi disse: «facciamo finta che quest’acqua vera sia finta».
Era venuto dall’alta Baviera prima a Firenze e poi dal 1966 a Roma, che non lasciò mai, salvo per un periodo – per molti aspetti decisivo – fra il 1972 e il 1974 , passato con Laura nell’isola di Paros. Fra quanti ho conosciuto, lui solo veramente romano, anche se non si era mai messo in regola col permesso di soggiorno o con la residenza. Era, la sua, una vita abitante, che per questo sempre più si allontanava, come nel tardo verso di Hölderlin: «quando lontano va la vita abitante degli uomini…». Lontano, in die Ferne, dove «la natura compie l’immagine del tempo, / che essa si ferma e quelli subito trascorrono / è per la perfezione…». Lontano – per lui, che voleva «rappresentare le cose come sono, o come sarebbero, se io non ci fossi», per lui che diceva che nell’arte l’unico tempo che esiste è l’assenza di tempo.
Il periodo trascorso a Paros coincide con l’avvento impetuoso del colore, con gli allucinati paesaggi intravisti dalla finestra spalancata dello studio e soprattutto col quadro che non riesco a dimenticare: un paesaggio quasi senza cielo, soltanto raso la terra rossa cosparsa di sassi e muschio.
«L’altezza del cielo risplende / per l’uomo, come alberi incoronati di fiori». Così finisce la poesia di Hölderlin. A Roma era stato un albero, uno snello, alto pino a suggerirgli «il principio di una nuova maniera», dopo i primi «quadri nebulosi che solo pian piano andavano acquistando parvenze concrete».
I colori di Paros riaffiorano senza tempo nei grandi nudi romani dei primi anni Ottanta. Riconosco nell’estatico nudo sdraiato del 1981 il volto severo di Bettina, la ragazza che gli faceva da modella, che incontravo spesso con lui. Nella Roma ancora incantata e reticente di quegli anni ci vedevamo quasi ogni giorno al bar della porta Settimiana, che aveva ancora una sala di biliardo, che da anni non esiste più. Sento ancora il rintocco delle bocce nelle partite giocate insieme nel primo pomeriggio, prima di tornare lui a dipingere e io a scrivere.
Ho conosciuto Dieter per via dell’altro pensiero dominante, insieme alla pittura, nella sua vita. Nella primavera del 1968 eravamo seduti al bar Navona con Ginevra e Elsa Morante nella piazza semideserta che avevamo eletto a nostro luogo d’incontro, quando si avvicinò un giovane alto, elegante nel suo doppiopetto un po’ logoro, e con una sorta di schiva disinvoltura chiese a Ginevra se gli permetteva di rivolgerle la parola. Da allora diventammo amici e quasi sodali e ho conosciuto uno dopo l’altra le donne della sua vita, nell’isola di Circe dove passavamo l’estate o sui monti Cimini, dove in quegli anni avevamo condiviso una capanna accanto a una scuderia. Di notte si sentivano pestare gli zoccoli dei cavalli e i loro alti, affranti nitriti.
La pittura è una questione di gesti. La mano del pittore non rappresenta gli oggetti, ne afferra piuttosto la forma, «non la realtà raggiunta, ma la realtà da raggiungere». Per questo il gesto di Dieter è, insieme, perentorio e sfumato (flou, effacé, ha scritto Jean Clair). Una volta afferrata la forma, sembra che la sua mano esiti lenta fino a mollare a poco a poco la presa, fino a lasciarsela sfuggire fra le dita.
Da ragazzo, Dieter era stato iscritto dal padre nella Hofkunstanstalt di Monaco, come apprendista mosaicista. «Avevo paura di fallire il test dei colori, fondamentale per un lavoro del genere». Qualcosa del mosaico si è impresso nel suo gesto, la minuziosa frammentazione dei colori che a chi guarda dalla giusta distanza sfuma in una impagabile integrità.
Non credo che Dieter desse troppa importanza alle polemiche che gli piaceva provocare. Certo non ha avuto il riconoscimento che gli spettava. Credo tuttavia che l’apprezzamento di Balthus e di Jean Clair e la precoce nomina a accademico di S. Luca gli fossero più che sufficienti. Faceva infinitamente più attenzione alla qualità dei cornetti per la sua colazione che alla sua carriera.
Amava, come ogni vero pittore, il pastello. I lungoteveri romani all’alba e al tramonto del 2000 sono un vertice di questa tecnica, dove il gesto ostinatamente insegue una indeterminazione che tende all’aureola e alla gloria. Pastelli sono anche a partire dalla fine degli anni Novanta le ciotole sulla tovaglia a quadretti, una delle quali mi accompagna e non cessa di stupirmi da anni: la ciotola bruna, quasi lavorata al tornio, campeggia su un acceso rosso pompeiano, mentre in primo piano la quadrettatura della tovaglia scandisce un contrappunto inconfondibilmente musicale.
Exit Dieter. Ma qualunque sia il destino delle sue opere nei tempi oscuri che stiamo vivendo, quand’anche gli archivi sciagurati della cultura ne smarrissero la memoria, il gesto della sua pittura resta indimenticabile. Non esige di essere ricordato, ma di restare per sempre indimenticabile.
Giorgio Agamben



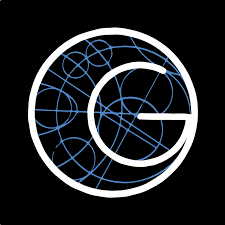




























Commenti recenti