
Luigi Luccarini è avvocato cassazionista titolare di studio legale in Perugia
Si è concluso ieri il travagliato, chiacchierato, per quanto poco analizzato aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena, durante il quale è stato comunicato che nel periodo di offerta in opzione delle 1.249.665.648 azioni ordinarie di nuova emissione sono stati esercitati 7.409.022 diritti per la sottoscrizione di 923.658.076 nuove azioni, pari al 74% del totale. Di quelli non esercitati si faranno carico investitori terzi in forza di precedenti impegni di sub-underwriting per un ammontare pari a complessivi 475 milioni di euro, corrispondenti al 19% dell’aumento di capitale.
Il tempo dirà se sarà stato un successo o meno sul piano finanziario.
Quel che è certo è che a guadgnarci non sarà lo Stato, principale azionista della Banca, che continua a iniettare denaro pubblico nell’ennesima operazione di “salvataggio”. Operazione che, a conti fatti, appare antieconomica e soprattutto ingiusta, perché conferma che in Italia continuano a sopravvivere aziende e cittadini di serie A e serie B. Superfluo aggiungere che alla prima categoria appartengono certamente il Monte e suoi funzionari e dipendenti.
In più, nonostante il tanto strombazzare della nostra classe dirigente sul “siamo Europei”, il comportamento poi tenuto da quegli stessi maggiorenti si rivela, nei fatti, ancora in grado di sollecitare attenzioni e reprimende delle istituzioni comunitarie.
Ma andiamo con ordine.
L’aumento di capitale, deliberato per rafforzare il patrimonio della banca eroso da una crisi di risultati operativi costante nel tempo è di 2,5 miliardi di Euro. Di questi, 1,6 miliardi sono stati garantiti dal Tesoro italiano, in ragione della quota di azioni già possedute (64,23%). Al mercato erano stati dunque richiesti 900 milioni di Euro, ma nessun grande investitore ha manifestato interesse concreto a partecipare all’operazione. A parte gli alleati storici AXA, che distribuisce polizze assicurative tramite gli sportelli MPS, e ANIMA, che ha in corso un accordo con la banca senese sul risparmio gestito e che insieme coprirebbero un po’ meno della metà del fabbisogno (400 milioni circa).
L’amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, aveva quindi ingaggiato un consorzio bancario di garanzia composto da Algebris, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca, i quali si sarebbero comunque fatti carico dell’eventuale sottoscrizione del residuo “inoptato” – ovvero delle azioni di nuova sottoscrizione, che restano liberate per effetto della rinuncia al diritto di opzione riservato agli azionisti.

Il fatto è che, per occuparsene, gli istituti consorziati avrebbero preteso commissioni per 125 milioni di Euro, un importo giudicato da tutti gli osservatori “eccezionale e fuori mercato”, che ha già suscitato proteste soprattutto all’estero, con l’Antitrust Ue già sollecitata ad intervenire, visto che secondo un suo (anonimo) funzionario «lo Stato può partecipare solo se tutti gli investitori, pubblici e privati, sono soggetti alle stesse condizioni» e non «se ad una qualsiasi delle parti che sostengono l’emissione di diritti sia stato offerto un trattamento più vantaggioso rispetto ai contribuenti italiani che non ricevono alcuna offerta di riduzione del rischio o altri incentivi».
Dunque, quella che potrebbe rappresentarsi come un’operazione di mercato rischia di essere censurata dall’organismo europeo che si occupa degli aiuti di Stato, oltre a pesare notevolmente nuovamente sulle spalle del contribuente italiano.
Un peso che ci portiamo tutti sulle spalle da lungo tempo.
MPS venne infatti “salvata” nel 2017 dal Tesoro, con una robusta iniezione di capitale, rientrando in borsa a fine ottobre di quell’anno con un valore di 4,28 Euro per azione. Poiché, però, lo Stato per diventarne azionista aveva pagato 6,49 Euro per azione e, dunque, a quei prezzi da subito la quota sottoscritta dal MEF con 3,85 miliardi di euro di soldi pubblici valeva 2,84 miliardi, si era generata una minusvalenza sul capitale investito di 1 miliardo di Euro già ai blocchi di partenza.
Con la condizione peggiorativa data dal fatto che il Tesoro si accollava anche il costo dell’perazione del cosiddetto burden sharing offerto agli investitori retail, che erano diventati titolari delle azioni ordinarie della Banca per conversione di obbligazioni subordinate in loro possesso.
Costoro, infatti, potevano consegnare le proprie azioni al prezzo di 8,65 Euro al Tesoro in cambio di bond senior emessi da MPS e finanziati dallo Stato, che aveva messo a disposizione per l’operazione 1,5 miliardi di Euro.
Lo sviluppo del valore/azione da quel momento si rappresenta in questo grafico (al 28 ottobre):

In realtà, il grafico neppure rende completamente l’idea della perdita. Infatti, il punto di partenza era un valore di 484 Euro (a settembre di quest’anno infatti c’è stato un raggruppamento azionario nell’ordine di 1 per ogni 100)
Possiamo, quindi, tranquillamente affermare che l’investimento iniziale del Tesoro si è pressoché azzerato. Come quello dei piccoli azionisti che si fidarono del piano elaborato da Padoan, approvato dalla Verstagen, ed elogiato da Dombrovskis, in base al presupposto secondo cui avrebbe ridotto l’onere a carico dei contribuenti.
Come si siano poi realizzati i reboanti proclami di allora, lo si vede oggi. Senza peraltro sapere dove siano andati a finire i soldi pubblici investiti in MPS. Domanda a cui dovrebbe rispondere il suo management, che in questo periodo è stato oggetto di notevoli cambiamenti.
Con Marco Morelli che è rimasto Amministratore Delegato fino a maggio 2020, dimettendosi dopo che il bilancio 2019 della banca segnalava la bellezza di 1 miliardo di Euro di perdite. Con il suo successore Guido Bastianini, ex vicedirettore generale di Capitalia e presidente di Banca Profilo e, quindi, alla guida di Banca Carige, indicato dal M5S, caduto in disgrazia all’inizio di quest’anno, quando il MEF lo sfiducia ed inizia a spingere per le sue dimissioni. Non ottenendole, nel CDA immediatamente successivo gli revoca tutte le deleghe, nominando al suo posto Luigi Lovaglio, uomo della galassia Unicredit, ex AD di Credito Valtellinese, presso la quale si era distinto per essersi fatto pagare da quella banca 3.036.979 di euro nel 2020, tra stipendio, premi e compensi di altro genere, anche se al Monte esiste un “salary cup” (pari al salario medio dei dipendenti moltiplicato per dieci) e dovrà adesso accontentarsi di un assegno annuale di 466.294 Euro.
È lui il maker dell’operazione di aumento del capitale, che, se sul lato della raccolta è apparsa più che deludente, obbligando lo Stato a rifinanziare la Banca per il solito 64% dei fondi necessari, si è invece risolta in una vera manna per i suoi dipendenti.
Saranno infatti in 4.084 a lasciare l’istituto, un numero superiore alle previsioni, visto che l’accordo con i sindacati era per 3.500 uscite.
Ed il perché di questa entusiastica adesione è presto detto.
L’intesa si regge sui prepensionamenti gestiti con il Fondo di solidarietà, l’ammortizzatore creato dal Decreto Legislativo 148/2015, che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS sostitutiva della retribuzione dei lavoratori “esodati” per stati di crisi aziendali e che vengono ricompensati con un c.d. assegno straordinario, di importo pari alla pensione virtuale che avrebbero percepito entro 5 anni.
Nel caso di MPS, però, il limite è esteso a 7 anni, come previsto da un emendamento all’ultimo “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) e, mediante l’intesa sindacale raggiunta, l’assegno è pari al 85% della retribuzione.
Nel caso, con l’azienda che versa all’INPS i contributi figurativi da accreditare sulla posizione pensionistica del lavoratore in modo da consentirne poi il ricalcolo comprendendo anche il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.
Nel caso dei dipendenti MPS, però, il limite risulta esteso a 7 anni, come previsto da un emendamento all’ultimo “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021), che lo ha innalzato per il solo 2022 per le cessazioni dei rapporti di lavoro che avverranno entro il 30 novembre; ed inoltre, grazie all’intesa raggiunta con i sindacati, l’assegno sarà pari al 85% della retribuzione.
Quindi, quei dipendenti che hanno aderito a questo “scivolo” ottengono un prepensionamento dorato che consente loro di lasciare il lavoro a 60 anni e percepire quasi tutto lo stipendio fino al compimento del 67° anno di età, confidando anche sul fatto che l’azienda verserà all’INPS i contributi figurativi da accreditare sulla posizione pensionistica del lavoratore in modo da consentirne poi il ricalcolo comprendendovi anche il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Si dirà che in fondo è la Banca che poi ripaga l’INPS di quanto versato da quest’ultima ai dipendenti. Ma si può anche obiettare che MPS è controllata quasi per il 65% dal Tesoro e, che, pertanto, quei soldi saranno comunque a carico dei contribuenti, cioè tutti noi.
Che la pensione ce la sogniamo. Figuriamoci stare a casa pagati come se fossimo ancora al lavoro…
FONTE:https://giubberosse.news/2022/11/01/aumento-di-capitale-mps-qualche-considerazione/



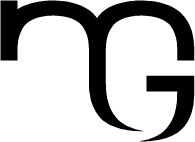




























Commenti recenti