Quantità
di Simone Garilli
Il Pil è una misura del tutto insufficiente per comprendere la potenza relativa degli Stati in reciproca competizione: va dunque rivisto, affiancato, almeno in parte emarginato. Per la verità, un filone di “riformisti del Pil” si può ad oggi ritenere consolidato, e il risultato è un indicatore senz’altro più ambizioso del Prodotto Interno Lordo, conosciuto con l’acronimo Bes (che sta per Benessere equo e sostenibile). Il Bes tenta di misurare il lato qualitativo della produzione nazionale concentrandosi sulle diseguaglianze e sulla cosiddetta sostenibilità ambientale. Non solo quanto si produce, dunque, ma per chi e con quali riflessi sull’ambiente che ci circonda.
Al netto delle aporie insite nel dubbio concetto di sostenibilità e in un ambientalismo spesso ingenuo, si tratta di una strada da percorrere. In tutta evidenza, però, non basta. La guerra d’Ucraina sta avendo il grande merito di riportare anche noi italiani, in ottima compagnia europea, dal lungo sonno a una parvenza di ragione, vedremo quanto profonda: la Storia non è mai finita, la potenza conta, e senza non è possibile nemmeno la democrazia, che si prepara innanzitutto ritagliandosi uno spazio di autonomia nell’agone internazionale.
È la storia stessa, d’altra parte, ad insegnarci come potenza e qualità della vita siano non di rado correlate in senso inverso. Sembra evidente, per limitarci ad un esempio oggi di moda, che una popolazione mediamente anziana, che è diventata tale non solo per la riduzione delle nascite, ma anche per la flessione delle morti dovuta a un ampio stato sociale, sia meno propensa alla guerra, e che quest’ultima possa essere strumento necessario per difendere la suddetta autonomia nazionale, in determinati frangenti storici. Essere preparati alla guerra difensiva è, in altri termini, componente basilare della democrazia sostanziale.
Mantenere la popolazione giovane, tuttavia, non sempre può essere obiettivo alla portata attraverso la semplice manipolazione della demografia degli autoctoni, anche perché una politica economica espansiva talvolta non è disponibile nella misura necessaria a stimolare le nascite, e in ogni caso richiede tempi lunghi per invertire la curva demografica, influenzata, oltre che da fattori materiali, anche dai costumi. Ecco allora che l’opzione dell’immigrazione potrebbe rendersi necessaria a preparare la guerra. Importare giovani è una via più rapida per modificare l’età media e, forse, anche la propensione alla violenza, che andrà tuttavia rivolta il più possibile verso l’esterno. Crudo? Senz’altro, ma è né più né meno il modello americano e, almeno in parte, francese. Gli americani, come noto, aggiungono all’immigrazione di massa lo stato sociale minimo e la proliferazione di armi ad uso e consumo privato, dando vita a una società abituata quotidianamente alla violenza nelle strade, psicologica (per la sopravvivenza economica) e reale (come dimostrano le non rare stragi autoinflitte da giovani e meno giovani americani “impazziti”). L’immigrazione di massa, da parte sua, non è un pranzo di gala. Se milioni di stranieri arrivano o nascono sul territorio nazionale, occorre assimilarli, nutrirli della cultura nazionale per non esserne travolti. E assimilare non significa integrare. L’integrazione è tolleranza, e la tolleranza in una società a forte immigrazione, ossia multiculturale, coincide con la perdita di identità nazionale, un estremo relativismo di valori, e dunque una grave perdita di coesione sociale, politica e di capacità strategica. L’assimilazione, al contrario, è violenta, si realizza tramite la discriminazione e l’indottrinamento, praticati con coerenza e costanza. Tutto ciò rende, per la verità, anche l’immigrazione di massa un canale non immediato verso una maggiore propensione media alla violenza produttiva di sovranità, la sola di cui vi è bisogno. Per assimilare servono anni, decenni, generazioni, fino a quando gli eredi dei primi immigrati avranno occultato le loro origini culturali, e si sentiranno pienamente immersi nella cultura nazionale1. Non si improvvisa.
Si diceva allora che occorrerà sacrificare una parte della nostra invidiabile qualità della vita, peraltro già in declino con il dispiegarsi in purezza del modello neoliberale, se vorremo non farci trovare totalmente impreparati di fronte all’emergente scenario internazionale. Si precisa tuttavia che in un Paese come l’Italia, che non ha necessità di farsi impero globale e ha una sua storia nobilissima di cooperazione e di stato sociale, non sarebbe desiderabile né utile importare di netto il modello francese o, peggio, quello americano, né ottenere i nostri obiettivi assecondando il suddetto modello neoliberale, che produce al contrario insensatezza, individualismo e grave fiacchezza di spirito. Ritornare a concepire la guerra come strumento per difendere il nostro peculiare modello democratico non significa nemmeno spenderci in velleitarie politiche neocoloniali, che nella storia ci hanno condotto piuttosto alla catastrofe che a un rango di potenza superiore, ma invertire la ripugnante dinamica psico-antropologica che ha svuotato di ogni senso, per le vecchie e le nuove generazioni, il decisivo articolo 52 della nostra Costituzione antifascista e socialdemocratica: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Lo Stato sociale, in definitiva, non deve essere messo in discussione, ma occorre elevare a problemi nazionali prioritari quello demografico e quello educativo, trovando il giusto equilibrio per affrontarli con il minimo costo sociale possibile, che tuttavia vi sarà e dovrà essere ben più psicologico che materiale (rialzarsi dalla depressione e dal relativismo estremo in cui siamo caduti come nazione richiederà immensa fatica, senza dubbio, ma lo richiede qualsiasi rinascita, individuale o collettiva che sia). Per riuscire nell’impresa, sia detto per inciso, è decisivo riacquisire margini ampi di sovranità economica. Il problema dei vincoli europei rimane, e non può essere aggirato.
Torniamo dunque al Pil e ai suoi concorrenti. Se è importante misurare qualitativamente la ricchezza prodotta, ciò non deve distogliere dal fatto che la quantità non solo continua a contare, ma conta oggi più che mai. Semplicemente, la quantità misurata dal Pil ci interessa ben poco e rischia di fuorviarci. La guerra d’Ucraina sia d’esempio. Il conflitto iniziato nel febbraio 2022 può essere interpretato in vario modo: chi parla di un successo strategico americano e occidentale, chi al contrario di un punto a favore dell’asse russo-cinese, ma ciò che è certo è che la Russia, perdente o meno sul lungo periodo, sta vincendo tatticamente sul terreno, o perlomeno ha resistito alle difficoltà iniziali ed è ora in netto vantaggio militare, tanto che sempre più insistentemente si parla di escalation o di trattative, senza vie di mezzo. Ciò significa che una parte sta vincendo, ed è la russa, tanto che gli occidentali si trovano di fronte al bivio: intervenire direttamente o trattare alle condizioni del Cremlino. La domanda che arrovella gli ambienti accademici soprattutto europei, abituati a trattare la potenza in termini economicistici, è sempre la stessa: come è possibile che una economia relativamente piccola in termini di Pil come quella russa abbia saputo più che controbilanciare non solo l’esercito ucraino, ma la coalizione di decine di Stati avanzati che hanno fornito per anni, già da prima del conflitto, aiuti economici, mezzi e persino uomini sul terreno?
La risposta, in questo senso, è molto più semplice: la Russia ha vinto la guerra della produzione militare. Come intitola un articolo di Deborah Haynes, redattrice per la politica estera di Sky News “Russia is producing artillery shells around three times faster than Ukraine’s Western allies and for about a quarter of the cost”.
L’analista indipendente Roberto Iannuzzi sintetizza così:
“Si prevede che le fabbriche russe sforneranno quest’anno circa 4,5 milioni di proiettili d’artiglieria, a fronte di una produzione complessiva di USA ed Europa pari a circa 1,3 milioni” e, del resto, la superiorità non è solo strettamente quantitativa, ma in alcuni campi anche tecnologica, se è vero che “Nel frattempo, molte armi occidentali ad alta precisione si sono scontrate con le superiori capacità russe di guerra elettronica, che rendono tali armi del tutto inaccurate”.
Ecco allora che confrontare i 2.200 miliardi di Pil russo con la somma dei Pil occidentali impegnati a fornire sostegno all’Ucraina, spiegherebbe ben poco dell’esito materiale del conflitto. Nemmeno si potrebbe sciogliere il nodo riparandosi dietro l’elevata spesa militare russa rispetto al Pil perché, se essa è superiore a quella dei principali Stati europei, è enormemente inferiore a quella americana, che pure arranca di fronte alle crescenti e disperate richieste ucraine di armamenti e sostegno logistico.
Dunque, quale produzione conta ai fini della potenza (militare e in senso lato nazionale)? Non certo quella del tutto fittizia dei servizi finanziari o della produzione a basso valore aggiunto o alla produzione finalizzata alle esportazioni, né, nel caso americano, l’abnorme spesa pubblica sanitaria, gonfiata dagli oligopoli farmaceutici e in grado solo di restituire un sistema della salute noto per i suoi pessimi risultati in termini di morti evitabili e di aspettativa di vita. A contare è esclusivamente la produzione strategica, che non significa soltanto produzione strettamente militare, ma anche una serie di altre spese propedeutiche alla potenza e parzialmente variabili a seconda del modello sociale ed economico che ci si intende dare: le spese in ricerca e sviluppo, nel sistema d’istruzione inferiore, superiore e universitario, in un servizio sanitario nazionale che alimenti salute invece di cronicità delle patologie e morti evitabili, in una politica economica che garantisca stabilità occupazionale e dunque maggiori consumi, investimenti delle imprese e produttività, guidata dallo sviluppo tecnologico, in una politica industriale, infine, che si fondi sulla programmazione e sul controllo pubblico formale e sostanziale delle imprese di rilevanza nazionale, ivi inclusi i principali istituti di credito.
In conclusione, possiamo ridurre l’intero ragionamento a poco più che uno slogan: siamo entrati, contro ogni pronostico occidentalistico, nell’era della quantità. Se questo dato di realtà contribuirà a spezzare materialmente e retoricamente la globalizzazione americana, e con essa l’illusione soprattutto europea di poter delocalizzare la quantità e le capacità tecniche e industriali diffuse campando di qualità settoriali e bolle finanziarie, non potremo che giovarne, nonostante la durezza del ritorno alla realtà che tutto ciò necessariamente implicherà.
——————————————————————————————————————————–
1 Del tutto evidente in questo passaggio dell’articolo il debito che ho contratto con la divulgazione e i saggi di Dario Fabbri, autore di un recente libro riepilogativo del suo metodo di analisi, intitolato “Geopolitica Umana”. Fabbri ha il difetto della semplificazione eccessiva di alcuni processi e fenomeni, ma il pregio, strettamente collegato, di avviare all’ABC del ragionamento strategico un pubblico, come quello italiano, totalmente disabituato a farlo. Si tratta dunque di una vera e propria opera pedagogica che può fare storcere il naso a qualche intellettuale, ma che è di rilevanza pratica assoluta, ancor più che teorica.



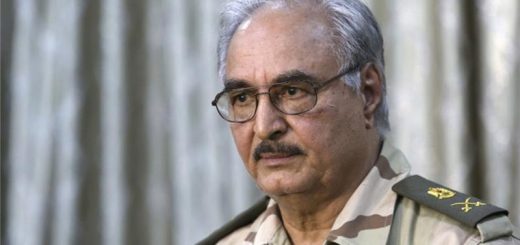



























Non solo la finanza ma anche il turismo va sottratto al PIL quando si ragiona di potenza.
Sì, vero