Giustizia interna, giustizia internazionale: le esigenze del "mai più"
di Gerardo Pisarello, professore di Diritto Costituzionale nell'Università di Barcellona e membro del Consiglio di redazione di SinPermiso; e Jaume Asens, membro della Commissione di Difesa del Collegio degli Avvocati di Barcellona
fonte SinPermiso tradotto per appelloalpopolo da Cinzia Bernardini
Le violazioni dei diritti umani costituiscono una stigmate immorale nella storia dell’umanità, soprattutto quando coinvolgono crimini che, per la loro crudeltà, la offendono e la lesionano gravemente. Per superarla, le società hanno cercato di disegnare meccanismi che evitino l'impunità e che permettano di dare alle vittime, e ad i loro familiari, una tutela adeguata. Gli intenti sono stati numerosi ed hanno avuto esiti diversi.
Frequentemente si sono esauriti con fracassi e grossolana imposizione di quella che, almeno da Trasimaco, si conosce come la “legge del più forte”. Altre volte si sono conseguite vittorie parziali, e la lotta delle vittime ha oscurato meccanismi di controllo, prevenzione e sanzione, che esprimono ciò che L. Ferrajoli ha denominato, precisamente, “la legge del più debole”. Il dibattito intorno ai mezzi che permettono di stabilire la responsabilità per questi crimini, ostacolato dalla restrittiva riforma sulla giurisdizione universale promossa dal Governo spagnolo, è un riflesso di questo contraddittorio cammino.
I tentativi per fissare un “mai più” ai crimini di lesa umanità hanno una lunga storia. Già i Tribunali di Norimberga, dietro la tragica esperienza del nazismo, stabilirono il principio che ci sono crimini che non si prescrivono e che non ammettono la immunità, indipendentemente da chi ne siano gli autori e da dove li abbiano commessi. Ciò interessava particolarmente alcuni famigerati gerarchi militari e politici del regime nazista, ma anche i principali gruppi economici che lo avevano appoggiato traendone beneficio, così come coloro che avevano legami con le famiglie Thyssen, Flick o Krupp. Posteriormente, la decisione di non ripetere gli errori del passato, ispirò documenti come la Carta della ONU o la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, che convertiva i diritti civili, politici, sociali e culturali in limite e contropotere di fronte ai poteri arbitrari di qualsiasi tipo, tanto pubblici che privati.
Per disgrazia, molto presto fu chiaro che questi principi non avrebbero vincolato ugualmente coloro che erano risultati vincitori rispetto a coloro che erano stati sconfitti. Dopo l’esperienza nazista e fascista, altri crimini di Stato spregevoli, come i bombardamenti di Hiroshima, Nagasaki o Dresda, le successive purghe staliniane, o le sopraffazioni commesse dalla dittatura franchista, furono tollerati. Malgrado la Convenzione contro il Genocidio, quelle di Ginevra sul diritto alla guerra o la Convenzione contro la Tortura mantennero in piedi la promessa del “mai più”, il doppio metro di valutazione imperante durante la Guerra Fredda la infranse una e più volte.
Solo quando si ebbe il crollo del Muro di Berlino alcune voci ottimiste vaticinarono una nuova tappa per il diritto e la giustizia internazionali, liberi dall’opportunismo e dalle doppie misure delle decadi anteriori. Senza dubbio, le pretese egemoniche degli Stati Uniti e dei loro alleati avrebbero condotto ad una radicale ridefinizione delle relazioni internazionali, caratterizzata da una ferrea volontà di domino militare, politico, economico e culturale. La riabilitazione della guerra come strumento di intervento nell’ambito esterno, e l’attacco frontale a diritti e libertà nell’ambito interno, avrebbero costituito l’espressione più compiuta della declinazione militarista e politica della mondializzazione capitalista.
Come conseguenza di ciò, i tribunali sovrastatali, creati per la persecuzione dei crimini derivanti da guerre o dittature, sarebbero rimasti condizionati dalle relazioni del potere nell’ambito internazionale e da ciò che D. Zolo ha chiamato “la giustizia dei vincitori”. Così, mentre alcuni crimini, quelli dei “vinti”, sarebbero stati ipersensibilizzati, altri, quelli dei “vincitori”, sarebbero rimasti frequentemente taciuti e ridotti, o semmai qualificati come “danni collaterali” di operazioni “umanitarie”. I tribunali dell’ONU per la ex Yugoslavia e Ruanda, o quelli misti di Sierra Leone o Libano, danno conto proprio di ciò.
Sicuramente, l’intento più audace di configurare un tribunale imparziale nell’ambito universale è stato quello inerente alla Corte Penale Internazionale (CPI). La sua reale operatività, però, lascia molto a desiderare. Tra i 108 membri che fanno parte del trattato istitutivo del suo statuto, ci sono significative assenze come quella degli Stati Uniti, Russia e Cina. Tutti questi sono Stati i quali hanno il potere di veto nel Consiglio di Sicurezza e, per ciò, un’impunità internazionale assicurata. Gli Stati Uniti sono arrivati anche ad approvare una legge nel 2002, la American Service Members’ Protection Act, che proibisce ai Governi ed alle organizzazioni federali, statali e locali statunitensi di adire alla Corte. In aggiunta, tale legge impedisce alla Corte l’estradizione di qualsiasi cittadino nordamericano, vieta che essa stessa possa eseguire investigazioni negli Stati uniti ed autorizza il Presidente della Repubblica ad utilizzare “tutti i mezzi necessari ed adeguati per ottenere la liberazione di qualsiasi [funzionario statunitense o alleato] detenuto o incarcerato, al posto, o dietro sollecitazione, della Corte Penale Internazionale”.
In realtà la CPI ha avviato solo processi per crimini commessi nella Repubblica democratica del Congo, Uganda, Repubblica Centroafricana e Sudan. In tutti questi casi, ugualmente ad altri tribunali internazionali, la CPI ha potuto presentarsi davanti alla opinione pubblica come un intento garantista per proiettane nella sfera globale il principio di soggezione di tutti i poteri, pubblici o privati, al rispetto dei diritti umani. Sicuramente, tanto per le proprie limitazioni quanto in ragione della sua strumentalizzazione da parte dei Paesi più potenti, essa continua ad essere un strumento deficitario per la consecuzione della giustizia e per il ristoro delle vittime.
Come alternativa a questi limiti, proprio alcuni tribunali statali cominciarono ad invocare la loro competenza nel giudicare sui crimini contro l’umanità. L’idea di fondo era che la “rilassatezza nella deliberazione” di qualsiasi Stato nel compimento delle sue obbligazioni internazionali autorizza l’intervento di un altro Stato il quale, in rappresentanza della comunità internazionale, potrebbe supplire tali mancanze. In questo modo, tutti gli Stati dovrebbero e potrebbero esercitare la propria giurisdizione di fronte a delitti specialmente gravi, che attentano ad un ordine giuridico proiettato più in là delle proprie frontiere.
In ossequio di questi principi, la Francia giudicò e condannò in contumacia all’ergastolo l’infausto capitano argentino Alfredo Astiz. Allo stesso modo, la giustizia italiana condannò a venti anni di reclusione due alti capi militari cileni nello stesso momento in cui altri militari cileni ed argentini furono accusati da diversi Giudici italiani, spagnoli, svedesi, tedeschi e statunitensi. In Spagna, lo sviluppo della giustizia internazionale fu possibile in virtù dell’art. 23 della LOPJ e della ratifica delle varie Convenzioni internazionali. In tal modo infatti venne intesa tale giurisdizione dal Tribunale Costituzionale spagnolo correggendo l’indirizzo di quello Supremo nel caso del genocidio guatemalteco. […]
Il messaggio era chiaro[…]. Si dava infatti ragione all’illustre Beccaria il quale affermava che non esiste prevenzione più efficace, nei confronti di alcuni delitti, ché quella di persuadere il proprio autore del fatto che non incontrerà luogo, sulla Terra, nel quale possa rimanere impunito.
Paradossalmente, uno dei primi tribunali in cui si fece eco di questo tipo di argomentazioni fu la Corte Suprema di Israele. Finita la Seconda Guerra Mondiale, molti degli accusati di delitti aberranti erano fuggiti in altri Paesi, soprattutto in America. Uno di essi fu Adolf Eichmann, un gerarca nazista con cittadinanza tedesca rifugiato in Argentina. Questi fu sequestrato e traslato in Israele, dove fu giudicato e condannato a morte per i delitti di genocidio commessi durante il regime. Israele non era il forum comissi delicti, però la Corte Suprema giustificò la competenza dei tribunali israeliani basandosi, precisamente, sul principio della competenza universale. In termini processuali, l’operato di Israele era del tutto obiettabile. Più comprensibile, al contrario, era l’argomentazione di fondo della sentenza: ogni volta che si commette un crimine internazionale di primo grado, oltre alle vittime, è la comunità internazionale colei che risulta danneggiata.
Al di là dei principi, però, il ricorso alla giurisdizione universale è prosperato in modo contraddittorio, sottomesso al ferreo imperativo della prepotenza del più forte. Il caso spagnolo non fa altro che confermarlo. La giurisdizione universale operò senza ulteriori controversie finché non interferì con il buon decorso delle relazioni diplomatiche e dei negozi internazionali. Essa infatti venne posta in disparte quando cercò di porre sotto luce pubblica i crimini commessi in Tibet o contro i seguaci di Falun Gong, o sui voli della CIA, le torture a Guantanamo, i massacri di Gaza e l’assassinio in Irak del periodista Jose Curso.
La cosa certa è che molte delle predette iniziative erano pienamente giustificate. Le accuse contro gli Stati Uniti ed Israele per commissione di delitti contro l’umanità sono state spalleggiate dalle Relazioni di numerosi organismi internazionali, ONG e collettivi di difesa dei diritti umani, molti dei quali con sede in questi stessi Paesi. Lo Sato d’Israele, inoltre, è uno dei Paesi che più ha incompiuto le risoluzioni dell’ONU e della Corte internazionale di Giustizia, mantenendo legalizzate pratiche politiche aberranti come gli “omicidi selettivi” o la tortura di prigionieri. In questo contesto, le azioni davanti ai Tribunali spagnoli ebbero l’innegabile virtù di potenziare la discussione intorno ai tremendi crimini che erano in gioco, tanto nel Paese dei presupposti responsabili quanto in quelli delle vittime. Negli Stati Uniti, in Palestina e nello stesso Israele, cominciò a radicarsi la possibilità di attivare Commissioni di Investigazione, ed incluso di avviare processi giudiziali per dirimere le responsabilità. Alla fine, invece, si impose la ragione di Stato. Piuttosto che riconoscere il carattere illegale di molte attività perpetuate dall’Amministrazione Bush, il Presidente Barack Obama dichiarò che “si deve guardare avanti e non indietro”. Un posizione che, considerata nelle sue future conseguenze, bloccherà qualsiasi intento di stabilire le responsabilità per i crimini commessi da parte dell’apparato statale. […]
Come risultato di tale pressione, il Governo spagnolo, con l’approvazione dei settori più conservatori della opposizione, ha imposto la limitazione della giurisdizione universale dei suoi tribunali, non curandosi del compimento dei suoi compromessi con le Convenzioni internazionali sottoscritte. Per conseguire il suo obiettivo, poi, si è servito di una via di dubbiosa legittimità formale, come è il meccanismo di emendamenti al progetto di legge di Riforma della Legislazione Processuale per la costituzione dell’Ufficio Giudiziale. Con questa riforma, l’esercizio della giurisdizione universale rimane soggetto al presupposto che esistano vittime spagnole, che i responsabili si trovino nel Paese e, comunque, che un Tribunale internazionale o del Paese dove accaddero i fatti non stia già procedendo alla sua persecuzione.
Agli occhi del Governo, forse, questa decisione appare come una manovra efficace e come l’unica risposta possibile in termini diplomatici. Senza alcun dubbio, trattandosi di una classe politica che aspira a cercare credibilità attraverso l’invocazione dei diritti umani e dello Stato di diritto, tale manovra costituisce un pericoloso esercizio da apprendista mago. A partire da adesso, infatti, saranno molti coloro che capiranno, e non a torto, che la giustizia istituzionale è, prima di tutto, giustizia al servizio dei vincitori e dei potenti, e rare volte il contrario. L’estensione di tale percezione porta con sé una innegabile carica delegittimante. Ma soprattutto rafforza l’idea che per rendere effettivo il diritto internazionale sui diritti umani, non basta invocarlo negli spazi istituzionali: occorre farlo risuonare al di là di questi, e spesso, contro i suoi stretti interessi di congiuntura.
A ciò hanno perseguito, con rigore e per molto tempo, esperienze come quelle dei “tribunali etici”, il cui obiettivo è stato quello di denunciare i limiti dei tribunali realmente esistenti, ed esigere il compimento, senza eccezioni, del diritto internazionale sui diritti umani. Questi tribunali, integrati da attivisti, giuristi, intellettuali, movimenti sociali ed associazioni di vittime, hanno conseguito vincolare la commissione di gravi delitti si sangue, come la tortura sistematica ed il genocidio, a delitti economici di differente tipo. Queste furono, ad esempio, le conclusioni dei Tribunali Russel I e II, dedicati ad investigare sui crimini commessi in Vietnam, e dei Tribunali etici che hanno studiato la responsabilità del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondale o di certe imprese transnazionali nella violazione dei diritti umani di base nei Pesi del Sud.
Tutte queste iniziative rendono chiaro che l’effettività del “mai più” esige, sicuramente, chiedere il perfezionamento, e non la retrocessione o strumentalizzazione, di meccanismi già esistenti, come i tribunali internazionali o il principio di giurisdizione universale, in modo che possano dare voce a tutte le vittime e garantire il proprio diritto alla verità. Ma soprattutto, mostrano la imperiosa necessità di portare avanti un compito più vasto e complesso: lo sviluppo, su differenti scale, di un sistema incisivo di controlli politici e giuridici capaci di rimuovere i privilegi, di Stato e mercato, qualora siano alla radice delle violazioni più gravi del principio di uguale dignità delle persone e dei popoli.


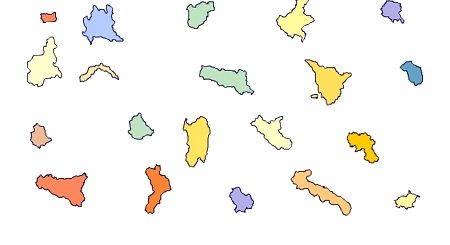



























Cara Cinzia, questo articolo demistifica abbastanza la retorica dei diritti umani. Ma a mio avviso non del tutto. Credo che l'unica tesi accettabile sia quella di Danilo Zolo. I Tribunali internazionali esercitano e non possono che esercitare la giustizia dei vincitori; dunque una non giustizia. Sul punto il mio pensiero si trova espresso qua: https://www.appelloalpopolo.it/?p=351