La quinta colonna del liberalismo: “French Theory” e potere come flusso
di SIMONE GARILLI (FSI Mantova, Lombardia)
Negli ultimi decenni la teoria del potere ha vissuto una sorta di rivoluzione, con effetti pratici certamente regressivi per le classi popolari.
Ha prevalso un filone teorico che vede nel potere un flusso invece che un insieme coordinato di istituzioni politiche ed amministrative. Questo potere liquido attraverserebbe le istituzioni indagate tradizionalmente dalla filosofia politica e condizionerebbe minuziosamente il comportamento degli individui attraverso metodi ben più subdoli ed efficaci del combinato lineare legge-repressione.
Insieme ad una produzione intellettuale in alcuni casi molto raffinata si è così imposto un nuovo immaginario collettivo che vede nella finanza trans-nazionale e acefala il dominus dei popoli inermi e degli stessi Stati nazionali. I centri di potere tradizionali, di natura immediatamente politica, sarebbero stati rimpiazzati dai poteri diffusi della globalizzazione finanziaria.
Il contributo francese
Centro teorico di questa rivoluzione è stata la Francia degli anni Sessanta e Settanta, nella quale hanno inciso autori di sicuro valore e di varia estrazione disciplinare; il più importante fra essi mi sembra essere stato Michel Foucault.
L’assioma degli studi foucaultiani è piuttosto semplice: il potere è per sua natura oppressivo. Ne deriva un corollario pratico: chi voglia davvero spendersi per la libertà deve battersi contro ogni forma di potere.
Più nel dettaglio, il potere agisce come agente e produttore di verità che legittimano le varie e diffuse pratiche oppressive. È cioè attraverso un regime di veridizione (il ‘discorso’, nel lessico foucaultiano) che ogni sistema di potere decide cosa è vero e cosa è falso, cosa si può dire e cosa no e finanche cosa è pensabile e cosa non lo è, influenzando in modo diretto ma soprattutto indiretto il comportamento degli individui. Compito dell’intellettuale è mostrare come agisce il sistema di veridizione del proprio tempo per offrire a chi voglia resistergli una serie di strumenti analitici. L’intero lavoro di ricerca del filosofo francese si svolge così intorno ad alcuni dispositivi sociali (la prigione[1], le strutture ospedaliere e psichiatriche[2], la sessualità[3], lo Stato[4]) al fine di metterne a nudo i discorsi veritativi che ne informano la razionalità operativa e che producono oppressione.
Se la verità è potere e il potere è oppressione, come Foucault sembra suggerire, se ne dovrà dedurre che la verità intesa in senso ontologico non esiste. La storia foucaultiana procede per “rotture epistemologiche” che sostituiscono regimi di veridizione con altri. Cambia il discorso sulla follia, sulla sessualità, sullo Stato – e di questi cambiamenti Foucault costruisce pregevolissime genealogie – mentre l’unica costante è il potere, che non è istituzione bensì flusso capace di riformularsi secondo pratiche discorsive diverse di epoca in epoca e di ridisegnare così ogni volta i confini del vero e del falso, cioè la sua razionalità pratica.
La sfida politica consisterebbe, così stando le cose, nello sdoppiamento di sé: ad un io sociale che deve giocoforza nuotare nell’acquario politico e sociale del suo tempo, andrebbe affiancato un io trans-storico capace di astrarsi dal sistema di verità e potere in cui si è trovato a vivere, relativizzandolo. La resistenza si giocherebbe sul terreno della veridizione e dovrebbe essere solo negativa, perché ogni pretesa di conquistare il potere per usarlo a fin di bene produrrebbe un esito scontato: ricadere in una nuova forma di oppressione, posto che potere e verità sono oppressione.
Decostruzione senza ricostruzione: il potere a briglia sciolta nel “Trentennio Pietoso”
È subito evidente la carica individualistica e anti-statalista di una filosofia politica di questo tipo. Ad una fase decostruttiva del potere che si viene configurando secondo linee di fuga strettamente individuali – e che non sarebbe saggio condannare di per sé – Foucault non accompagna una fase ricostruttiva della lotta di classe intorno al potere, rinunciando così a condizionare il sistema di oppressione complessivo; sistema che pertanto sarà ancor più libero di agire, perché alla sua forza oppressiva si aggiungerebbe il supporto incosciente degli stessi individui nella misura in cui decidessero di sottrarsi ai corpi intermedi che ne rappresentano principi e interessi (partiti e sindacati su tutti).
È la storia degli ultimi trent’anni abbondanti.
Secondo Paolo Leon, compianto studioso della dinamica strutturale del capitalismo, alla radice dei movimenti libertarti e anti-statalisti che tra gli anni Sessanta e Settanta si prendono la scena politica c’è un’illusione ottica di natura microeconomica che coinvolge non solo i capitalisti, ma anche i sindacati e i lavoratori. Se è infatti assodato, a partire da Smith, che il singolo capitalista produce effetti macroeconomici involontari mentre tende alla ricerca del massimo profitto individuale, un meccanismo simile è valido anche per le altre categorie socio-economiche inserite, che lo vogliano o meno, nella dinamica riproduttiva del modo capitalistico. La natura macroeconomica della microeconomia non è però “visibile” al singolo individuo. Il singolo, sia esso un imprenditore, un lavoratore o un rappresentante politico-sindacale, tende a sottovalutare le funzioni e gli effetti della politica economica dello Stato. In particolare, nelle condizioni di piena occupazione, alti salari e stato sociale tipiche del Trentennio Glorioso
[…] il sindacato assegna a se stesso il merito per gli aumenti salariali e il miglioramento dei diritti nello stato sociale, e ignora il ruolo della politica economica, dell’obbiettivo della piena occupazione, e soprattutto del tasso di cambio fluttuante. Così, sindacato e imprese, nelle circostanze, si rivelano attori microeconomici e, salvo rare eccezioni, diffidano dell’intervento pubblico, vuoi perché interferisce nelle vertenze sindacato-impresa, vuoi perché il ceto politico si ritiene in concorrenza con questa stessa contrattazione, vuoi perché temono il riflesso inflazionistico sui loro crediti, vuoi perché temono le conseguenze delle politiche antinflazionistiche. In tutto ciò, è possibile che si alteri anche la soggettività dei lavoratori, perché anch’essi ciechi all’economia nel suo complesso (altri direbbero che la classe operaia non era realmente diventata una classe dirigente). Se, infatti, attribuiscono alle proprie capacità il merito dei maggiori salari (della riduzione delle ore lavorative, dello stato sociale, ecc.) e acquistano i modi di essere individualistici dei capitalisti (consumi, status, ecc.), allora il sindacato e l’intervento pubblico appariranno loro (alla nuova classe media) meno necessari[5].
Ci si può chiedere, continua Leon
[…] se i movimenti popolari degli anni Sessanta e Settanta, suscitati dalla libertà economica fornita dalla piena occupazione, non abbiano ritenuto inutile fardello le forme tradizionali di rappresentanza sociale e politica, e non si siano trasformati in domande libertarie e individualistiche, e se ciò, alla fine, non abbia creato il consenso alle successive politiche antistatali e antisindacali del Primo Ministro Tatcher e del Presidente Reagan[6].
La distorsione microeconomica che inganna i lavoratori non deve tuttavia essere intesa come caratteristica ontologica e quindi irreversibile dell’essere sociale, poiché deriva proprio dai rapporti di produzione tipici del capitalismo, i quali poggiano le loro fondamenta sul terreno filosofico utilitarista. L’imprenditore che taglia il costo del lavoro durante una crisi economica, così pensando di ampliare i margini di profitto o quantomeno ripristinare quelli precedenti alla crisi, spesso non si rende conto che in tal modo sta tagliando i redditi di coloro che dovrebbero comprare il suo prodotto, destinato perciò a rimanere invenduto e a sollecitare altri tagli e una nuova contrazione della produzione. Ma il punto decisivo è che, anche rendendosene conto, il singolo imprenditore non potrebbe fare altrimenti perché da solo non ha la forza di invertire la composizione utilitaristica complessiva. Paradossalmente, anche se tutti gli imprenditori “vedessero” gli effetti macroeconomici delle loro azioni l’esito sarebbe lo stesso, essendo i loro investimenti basati sulle aspettative di vendita e regnando l’incertezza circa il comportamento degli altri imprenditori. Solo lo Stato può invertire il ciclo negativo, visto che in linea teorica può fare a meno del vincolo agli investimenti derivante dalla domanda in calo decidendo di non rispondere alla logica utilitaristica della massimizzazione del profitto. Perché ci riesca, naturalmente, ha bisogno di muoversi all’interno di un impianto economico sovranista che consenta di finanziare la maggiore spesa con nuovi “segni monetari” e di controllare il sistema finanziario nazionale, piegandolo ai suoi fini.
I lavoratori che rinunciano a farsi Stato attraverso i corpi intermedi (partiti e sindacati) stanno in realtà rinunciando a “prendere per la collottola il capitalismo” e a piegarlo ad una logica macroeconomica non utilitaristica, e gli stessi corpi intermedi, quando si convincono di poter prosperare senza le regia dello Stato, stanno gettando le basi per la loro irrilevanza futura; questa inconsapevolezza, infatti, è all’origine della postura corporativa che vanno assumendo perlomeno i suoi vertici nazionali.
Leon ci fa notare che ciò è accaduto proprio quando i corpi intermedi erano all’apice della loro forza, perché il benessere relativo delle classi lavoratrici ha fatto loro dimenticare qual è l’attore che in ultima istanza lo garantiva: appunto lo Stato.
Barba e Pivetti vanno ancora più a fondo e ne La scomparsa della sinistra in Europa ci dicono che se ciò è potuto accadere è perché i partiti popolari dei lavoratori non hanno mai governato il Trentennio Glorioso, ma si sono limitati a cavalcare l’onda prodotta dalle stesse forze politiche del capitalismo, consce che senza riconoscere la legittimità delle rappresentanze popolari – in un contesto potenzialmente rivoluzionario come era quello che aveva portato alla Resistenza prima e ad una Costituzione anti-fascista e anti-liberale poi – il rischio di uno scivolamento italiano ad Est sarebbe stato troppo alto.
Dal punto di vista della cultura socialista accadde perciò che
La natura conflittuale del sistema fu progressivamente persa di vista, così come finì per essere perso di vista il ruolo dell’azione collettiva come determinante del progresso sociale all’interno del capitalismo.
In effetti,
negli scritti dei maggiori intellettuali di quel ventennio di fatto sparirono, insieme alle classi e alla questione generale dei rapporti di forza tra salariati e percettori di redditi da capitale e impresa, le questioni connesse con la capacità dello Stato di influire su tali rapporti di forza e sull’esito del conflitto distributivo[7].
Si trattò, detto in altri termini, della sostanziale subalternità dei rappresentanti dei lavoratori alla filosofia utilitaristica, la quale impedì a queste forze di elaborare idealmente una struttura sociale alternativa da realizzarsi quando i presupposti del capitalismo dal volto (relativamente) buono andavano scomparendo alla fine degli anni Settanta. Al Trentennio Glorioso ideato e nel complesso gestito dalle forze del capitalismo andava fatto seguire, con le buone o con le cattive, un Trentennio socialista e sovranista, ma per farlo era necessaria una egemonia indiscussa tra le classi dirigenti e popolari che rendesse pensabili e politicamente legittime norme e politiche illiberali, nel senso letterale del termine. Tra esse, in prima istanza, un rigoroso controllo delle importazioni per allentare il vincolo esterno della bilancia dei pagamenti. Non erano, a quei tempi, velleità settarie, dato che il Partito Comunista Italiano raggiunse a metà degli anni Settanta il suo massimo risultato storico sia alle amministrative che alle politiche (intorno al 35%) e nel 1980 il fronte composto da socialisti e comunisti vinse in Francia le elezioni andando al governo.
Ma nulla di tutto ciò accadde, e le forze di sinistra col passare degli anni iniziarono addirittura a gestire in prima persona la transizione al Trentennio Pietoso facendosi avanguardia non delle istanze popolari, ma dei simulacri ideologici del grande capitale: la “modernizzazione”, “il libero commercio internazionale”, “la libera concorrenza”, “gli Stati Uniti d’Europa”.
La graduale espulsione dell’elemento socialista dal corpo politico della Sinistra aprì praterie per la cosiddetta French Theory, che più di ogni altra cosa fu, appunto, una rivoluzione della teoria del potere, non a caso prodotta da intellettuali critici post-marxisti, spesso rabbiosamente anti-comunisti; rivoluzione teorica anti-dialettica e perciò predisposta a superare, senza conservarla, la teoria classica del potere, accettando come condizione irreversibile il potere-flusso che il liberalismo nella sua fase controrivoluzionaria andava costruendo e ancor più propagandando come nuovo ed esclusivo orizzonte della filosofia e dell’analisi politica.
[1] Si veda in particolare Sorvegliare e punire, 1976.
[2] Si vedano in particolare Storia della follia nell’età classica, 1963, e Nascita della clinica, 1967.
[3] Si veda in particolare la trilogia intitolata Storia della sessualità, comprendente La volontà di sapere, 1978, L’uso dei piaceri, 1984, e La cura di sé, 1985.
[4] Si vedano in particolare Sicurezza, territorio, popolazione, 1977-78, e Nascita della biopolitica, 1978-79.
[5] P. Leon, Il capitalismo e lo Stato, Castelvecchi, Roma, 2014.
[6] Ivi.
[7] A. Barba, M. Pivetti, La scomparsa della sinistra in Europa, Imprimatur editore, Roma, 2016.



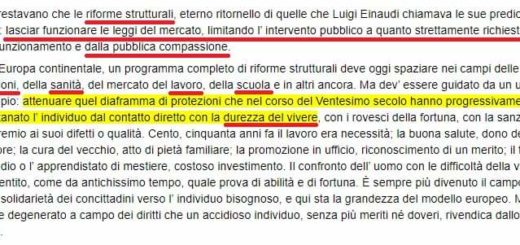




























Molto interessante, ma mi pare che si commetta il solito errore dialettico della rimozione psicologica.
L’autore sembra suggerire la vecchia e stantia tesi del “tradimento della sinistra” che è pericolosamente vicino all’autoconsolatoria strada adottata dai vecchi compagni delusi: “quella non è la “vera sinistra” ma solo una “destra mascherata”.
Spiace dirlo, ma se l’obiettivo è quello di liberare l’umanità dai grandi mali che la affliggono (famiglia, proprietà, Stato), come esplicitamente messo all’ordine del giorno da Engels, allora la coerenza appare assoluta.
“Al Trentennio Glorioso ideato e nel complesso gestito dalle forze del capitalismo andava fatto seguire, con le buone o con le cattive, un Trentennio socialista e sovranista”
L’autore però spiega chiaramente che il percorso da seguire sarebbe stato sovranista, quindi riaffermando l’entità costituzionale e statale, e non con l’eliminazione dello stato (la famiglia e la proprietà).
L’obiettivo del FSI, naturalmente, non è liberare l’umanità da famiglia, proprietà e Stato. L’FSI non si qualifica come marxista, sebbene alcuni dei suoi militanti leggano Marx, Engels o Lenin e tutti, credo, li tengano in dovuta considerazione.
Per il resto, non c’era in me nessuna intenzione di suggerire la tesi del “tradimento a sinistra”, perché considera la categoria di ”tradimento” pre-politica, soggettivistica, e quindi poco utile all’analisi politica. Io credo che col senno di poi (e solo col senno di poi) l’analista debba ragionare in termini deterministici (“se è andata così un motivo c’è”) e quindi in termini oggettivi. La Sinistra ha oggettivamente espulso la sua componente socialista, ed è assurdo pensare che si sia trattato della somma di tanti tradimenti personali. Una tale mole di tradimenti non può che dipendere da un traino esterno, strutturale, cioè da uno spirito del tempo peculiare che si tratta di conoscere, in modo da liberarsene.
Ed in questo sono in disaccordo.
Anzi, noto una coerenza tremenda nella sinistra italiana, che come nota Cesaratto è sempre stata avversa a Keynes.
Semplicemente, il socialismo non può portare all’escatologia universale messianica, indi ora come ora provano con il neoliberalismo.
Chi lo sa, magari ce la faranno.