Materialismo al tramonto
di Rocco Ronchi
fonte Il manifesto
Da tempo la sinistra italiana ha fatto del materialismo solo una delle tante «tradizioni» che (faticosamente) convivono all’interno della sua imprecisata galassia ideologica, quasi il retaggio polveroso di un’epoca definitivamente tramontata. I destini del materialismo, come metodo di analisi e come fondamento della prassi politica, e quelli della sinistra politica non sono inscindibilmente legati. Ne fa fede, appunto, la nostra sinistra. Vale però la pena di chiedersi che cosa diventi una sinistra senza materialismo.
La risposta non è difficile. Diventa quello che effettivamente è oggi in Italia: un movimento di «opinione» che contende ad altre «opinioni» il diritto di essere opinione «dominante». L’arena della contesa è la sfera dell’«opinione pubblica». Su tale opzione di fondo si è costruita l’ipotesi del partito democratico. Fin dalla scelta del nome è resa esplicita l’intenzione programmatica di rompere con l’eredità «materialista» del passato. Un riferimento anche vago al «socialismo» lo avrebbe invece implicato.
Le conseguenze di questa precisa opzione ideologica sono la cronaca politica degli ultimi anni. In primo luogo, quel fenomeno registrato dalla chiacchiera giornalistica come «buonismo» e stigmatizzato dagli avversari come difetto di «realismo». Divenuta opinione, la sinistra non può infatti che essere la paladina delle buone intenzioni e delle buone pratiche contro le cattive intenzioni e le cattive pratiche attribuite sistematicamente all’avversario. Nell’ambito della contesa politica, essa si autocomprende come la portatrice dell’opinione vera – vera perché disinteressata, vera perché votata al bene pubblico – di contro all’opinione falsa perché viziata dall’interesse privato e dal calcolo egoistico. D’altronde la verità di tale opinione non può avere altro fondamento che una persuasione cocciuta. Nessuna scienza, infatti, la sorregge e la giustifica, dal momento che il materialismo come scienza della prassi è stato liquidato dalla stessa sinistra come inutilizzabile ferrovecchio «marxista».
In secondo luogo, il moralismo e lo snobismo estetico. Fattasi questione di opinione, la lotta politica cessa di essere «politica». Prende piuttosto la forma prepolitica e impolitica del ribrezzo morale e della ripugnanza estetica. Non ha torto Berlusconi quando afferma di essere il collante dell’opinione di sinistra («il partito di Repubblica»). In tanti, in questi ultimi anni, hanno avuto modo di constatare come persone indubbiamente «di destra» si siano risolte a fiancheggiare la sinistra, perché per cultura, per rettitudine morale, per buona educazione, trovavano insopportabile – sul piano estetico e su quello morale – le performance del capo e della sua oscena cricca. Il giudizio politico era sostanzialmente irrilevante. Ora, il sentimento di disgusto è certamente giustificato, tuttavia c’è da chiedersi se possa essere efficace per una trasformazione reale dello stato di cose, se possa funzionare politicamente o se non sia piuttosto il segno di una metamorfosi della sinistra in una specie di «ceto sociale» (ampio ma minoritario) caratterizzato dalla condivisione intellettuale degli «eterni ideali» del buono, del bello, del vero e del giusto. Presso questi palati idealisti il «buon gusto» sostituisce la «coscienza di classe» e il Kitsch – definito dallo scrittore Hermann Broch l’equivalente estetico del male morale – diviene il nemico da combattere. In tempi certamente più duri dei nostri e, perlomeno, altrettanto privi di speranza, un vecchio materialista come Bertolt Brecht si faceva beffe di questo genere di sinistra. Invece dei leghisti, doveva fronteggiare Hitler all’acme della sua potenza, eppure lanciava frecciate al vetriolo agli intellettuali di sinistra che vendevano Ansichten o Meinungen (opinioni) all’angolo della strada, credendo «idealisticamente» che «persino il fatto che avete fame dovete apprenderlo dai libri» (la citazione è tratta da Dialoghi di profughi, opera di sconcertante attualità composta durante l’esilio finlandese di Brecht e che da tempo immemorabile è purtroppo sparita dalle nostre librerie)
Infine, la contraddizione ultima in cui si viene a trovare una sinistra mondatasi dal materialismo: essa diviene movimento d’opinione nel momento in cui, per ragioni esclusivamente materiali, la sfera dell’opinione pubblica è venuta meno. Il consenso razionale che la sinistra cerca suppone infatti un’opinione pubblica di taglio kantiano, una specie di grande «coro» composto da uomini liberi e assennati di fronte al quale gli attori della scena politica devono proporre le loro opinioni. Con il voto l’opinione pubblica giudicherebbe e la palma del vincitore dovrebbe andare all’opinione migliore. Tale supposizione «razionalistica» (molto «alla Habermas») spiega perché poi, sotto sotto, a dispetto delle tante botte prese, la sinistra non riesca a farsi una ragione delle sue ripetute sconfitte e inclini così verso il risentimento e il disprezzo aristocratico nei confronti di quella stessa gente che vorrebbe persuadere.
Ma l’opinione pubblica non è la sfera della libera discussione razionale. È piuttosto un prodotto artificiale, una costruzione materiale dei media. A caratterizzarla sono paura dell’isolamento e gregarismo, mimetismo e violenza. Un materialista non coltiva illusioni sulle masse e non matura, quindi, risentimenti elitari. Un materialista sa, come scrive Jean Paul Sartre nella Critica della Ragion dialettica, che le opinioni della maggioranza si producono per contagio, in quanto ognuno nella massa pensa, desidera e «opina» secondo l’Altro. Gramsci fissava materialisticamente nell’egemonia l’obiettivo della pratica politica socialista: per cominciare a vincere bisognava cioè occupare il posto dell’Altro, divenire il principio di un nuovo contagio emotivo ed ideologico. Gilles Deleuze, negli anni ‘70, parlava di «concatenazioni collettive di enunciazione» che si devono diffondere epidemicamente. La destra lo fa quotidianamente occupando militarmente le casematte della comunicazione sociale. Ignorare o sottovalutare questo livello dello scontro, fare spallucce quando si solleva la questione «materiale» della comunicazione e del suo monopolio di fatto, dando a intendere che si hanno ben altri e più profondi problemi di cui occuparsi, significa per la sinistra abdicare in anticipo al proprio ruolo critico.
Il materialismo aveva assicurato alla sinistra un fondamento scientifico. La «novità» del marxismo rispetto all’eterna e indeterminata fame di giustizia, che caratterizza strutturalmente un’umanità gettata in una situazione di «penuria» (l’espressione è ancora del Sartre «dialettico»), è tutta qui. Gli offesi, per una volta, hanno avuto a disposizione per la loro lotta, non una morale, ma una scienza: una scienza della storia e una scienza della natura. Con il marxismo, la filosofia, come scienza della verità, è entrata prepotentemente nell’arena della lotta politica e gli offesi hanno finalmente potuto fare a meno di una morale astratta, con il suo corredo ideologico di ideali e di valori. Brecht lo aveva capito benissimo: divenuti scienziati materialisti, gli ultimi si potevano liberare dal ricatto della virtù, alla quale venivano educati per sopportare stoicamente la loro miseria oggettiva. Il marxismo, per lui, assume il valore del Metodo, nel senso cartesiano e scientifico del termine. Lo qualifica con l’aggettivo «Grande» perché assicura non solo la conoscenza certa ma anche la liberazione dell’uomo e la possibilità di una vita finalmente «gentile», «al di là del bene e del male» (il marxismo di Brecht, da questo punto di vista, è profondamente nietzscheano). Senza tale incondizionata fiducia nella filosofia (cioè nella scienza), perfino gli orrori del comunismo, vale a dire la sua strutturale amoralità pragmatica, resterebbero senza spiegazione.
Alle spalle della sinistra attuale non vi è allora, come ingenerosamente si crede, il vuoto delle idee. L’imprecisione ideologica che la caratterizza, financo nel nome (che vuol dire infatti «democratico»?), è figlia di una crisi schiettamente filosofica. Non è soltanto la crisi del Grande Metodo quella che genera la nostra sinistra «post-moderna» e «post-materialista», ma è la crisi dell’idea stessa di scienza, della possibilità cioè di fondare la prassi concreta su di una episteme stabile (della società e della natura). Una crisi tutta novecentesca della quale è perfino inutile tracciare la storia tanto è nota. Venuto meno il rapporto con l’Assoluto, non restavano che i valori, gli ideali eterni di giustizia, le tradizioni più o meno nobili alle quali fare riferimento e con le quali sperare di persuadere una opinione pubblica artefatta: le «opinioni», insomma. L’alternativa di fronte alla quale una sinistra «leggera» si è trovata a scegliere era, dopotutto, quella posta dal vecchio Platone all’inizio della filosofia: o scienza o opinione, verità o retorica, pedagogia o seduzione. Se oggi le si rimprovera di assomigliare troppo al suo avversario è perché, rinunciando al materialismo, la scelta era obbligata: opinione, retorica, seduzione.
Il vicolo cieco nel quale si è cacciata è ben espresso da una grande mistica cristiana, materialista e platonica, Simone Weil. La Weil osservava, infatti, che quando le opinioni regnano sovrane, quando la scienza non è più in grado di guidare l’azione, la sola legge che decide quale opinione prevarrà è quella della forza e del prestigio: forza e prestigio della retorica, forza e prestigio del denaro, forza e prestigio delle armi. Tutte doti, lo sappiamo, date in grande profusione proprio all’avversario che vorremmo combattere. Se, dunque, non si vuole assistere alla definitiva metamorfosi della sinistra in ceto sociale minoritario, la questione teorica e pratica del materialismo (il Grande Metodo) deve essere posta all’ordine del giorno. Lo si dovrà fare però senza indulgere in tentativi ingenui di «rifondazione». La crisi del materialismo, la crisi novecentesca dell’episteme, dunque anche la crisi del marxismo, deve essere parte integrante nel nuovo discorso teorico materialista. Le ragioni che rendono allora particolarmente interessante oggi la lettura di un testo giudicato per molto tempo out of date come la Critica della Ragion dialettica di Jean Paul Sartre sta proprio nella sua pretesa di andare materialisticamente oltre il materialismo storico e dialettico.
In un saggio denso, arduo e appassionante titolato La materia della storia. Prassi e conoscenza in Jean Paul Sartre (Ets, Pisa 2009), che ha il sapore del corpo a corpo intellettuale con un pensiero difficile e sfuggente, Florinda Cambria ha chiamato questo esperimento «materialismo assoluto». Sartre, scrive, non pensa la materia come dato inerte o come fatto costituito, ma come prassi in atto, come un farsi che si fa e che non è mai completamente fatto, e spoglia questo fare dalla dimensione «soggettiva» e «umana» che sembrerebbe implicare (anche nel suo pensiero precedente), per restituirlo allo «sfondo di immanenza» che lo contiene. C’è insomma fungente alle nostre spalle una specie di totalità aperta e in divenire che ci «avviluppa» (l’espressione è di Sartre), in cui i confini dell’organico e dell’inorganico, del naturale e della protesi tecnologica, dell’umano e del non umano, sfumano fino a perdersi.
La materia dei materialisti assoluti assume allora i contorni di questa totalità che non è né storia umana né natura oggettiva e che non cessa di presentarsi, con le sue «esigenze», in tutte le concrete «situazioni di penuria e di lotta» nelle quali siamo gettati.
Kalle e Ziffel, i due protagonisti del Dialogo di profughi di Brecht, avrebbero senz’altro apprezzato questo modo profondamente spinoziano di parlare della materia, così diverso, a giudizio di Ziffel, da quello dei «tedeschi» (cioè degli intellettuali), «i quali sono poco dotati per il materialismo. Anche quando ce l’hanno, ne fanno subito un’idea, e allora è materialista uno che crede che le idee derivino dalle condizioni materiali e non viceversa, e della materia non se ne parla più». Parlarne nuovamente è invece oggi assolutamente necessario. Per questo bisogna salutare come un importante evento editoriale la recente pubblicazione del dimenticato libro di un trascurato autore «marxista», Josef Dietzgen, L’essenza del lavoro mentale (Mimesis), un autodidatta di genio, conciatore di pelle e agitatore rivoluzionario internazionalista, che aveva suscitato, al suo primo apparire, nel 1869, gli entusiasmi di Marx e di Engels (il volume contiene inoltre in appendice la prima edizione critica integrale in italiano della Acquisizione della filosofia del 1895). Come ricorda il curatore del volume, Paolo Sensini, Dietzgen, muovendo da un’analisi materialistica del processo della conoscenza, spinge la sua ricerca fino all’elaborazione di una nuova filosofia della natura, di indubbio sapore spinoziano, nella quale la materia si spoglia della sua veste «metafisica» e «filosofica». Non più semplice cosa inerte data in spettacolo a un soggetto separato ma totalità che ci avvolge da ogni parte e di cui la conoscenza è un aspetto costitutivo, una continuazione con altri mezzi, quelli caratteristici della specie umana, come la funzione clorofilliana lo è per le piante. «Lo spirito umano, scrive Dietzgen, spiegato filosoficamente e che si autoriconosce, è un frammento, una parte della natura assoluta». Parole insolite per un materialista «duro e puro», che ci ricordano però come «materialismo», per i socialisti, non fosse soltanto sinonimo di una «teoria» ma indicasse una prassi avente come meta nientemeno che la reintegrazione dell’uomo nell’assoluto.


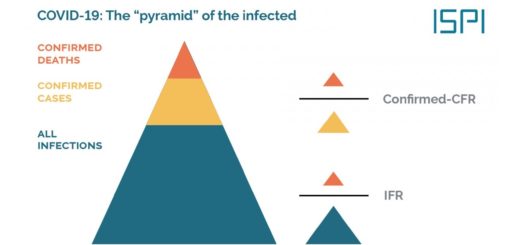


























Commenti recenti