Gli eroi di Conrad alla conquista della virilità
di GIAMPIERO MARANO (RI Varese)
Un secolo fa gli scrittori modernisti come Mann, Musil, Kafka, Joyce (e, in Italia, Svevo, Tozzi, Pirandello, Montale) diagnosticarono con precisione infallibile la grave crisi di senso in cui si dibatteva la civilizzazione. Da allora, nessun cambiamento è venuto a incidere significativamente sul corso degli eventi. Con rapidità sconcertante la Megamacchina tecnoscientifica che si è avviata agli esordi dell’era moderna ha prodotto un’umanità terminale via via ridotta a mera espressione biologica: nevroticamente paralizzati come la Eveline dei Dubliners, dissipiamo enormi energie in uno sforzo di autoconservazione sempre più ignaro della bellezza e della grandezza del rischio.
Nel saggio L’eroe virile (Einaudi, 2021, 109 pp., 15 euro) Alberto Asor Rosa riflette invece su un autore della generazione immediatamente precedente al modernismo, Joseph Conrad, soffermandosi su tre celebri racconti (o romanzi brevi), scritti nell’arco di circa un ventennio (1899-1917): La linea d’ombra, Cuore di tenebra, Tifone. In tutti, osserva il critico, ricorre il motivo dello scontro dell’uomo con forze soverchianti: quelle dell’Assenza (La linea d’ombra), della Cecità (Cuore di tenebra) e della Violenza (Tifone), simboleggiate rispettivamente dalla bonaccia, dalla tenebra e dall’uragano.
Asor Rosa pensa giustamente che i protagonisti dei tre racconti conradiani rappresentino “il senso di un costume collettivo” e insieme “il destino di un’intera civiltà umana”, cioè quella occidentale, colta nel momento della transizione dal paradigma, in parte ancora preindustriale (mi rifaccio per questo spunto allo Zolla dell’Eclissi dell’intellettuale), dell’eroe borghese virile a quello dell’inetto novecentesco: dove la virilità, secondo Asor Rosa, “consiste nel tener fede eroicamente al rigore di una missione senza scopo né contenuto”, insomma nella “vocazione alla resistenza morale”.

Quest’ultima fa leva sulla “forza potenzialmente invincibile”, dice il critico, “del proprio essere se stessi, diversamente dagli altri, se necessario, contro tutto” – e si ricordi al riguardo quanto afferma il giovane capitano protagonista di The Shadow Line: “Io stavo in piedi tra i miei uomini come torre ferma, inaccessibile al male (impervious to disease), cosciente solo dell’infermità dell’anima mia”.
L’allusione all’“infermità” non deve stupire: da sempre (da Gilgamesh in poi, intendo) oltrepassare la linea d’ombra per conquistare la virilità fa tutt’uno con l’acquisizione della consapevolezza dei limiti e delle lacune insiti nella virilità stessa. Nessuna sfida titanica al cielo, nessuna hybris; tutt’al più, il pericolo, come avviene al Kurtz di Cuore di tenebra, di andare incontro alla degenerazione, che è del resto il destino di qualsiasi cosa si muova sotto il sole, come osserva Asor Rosa.
Kurtz, in effetti, “retrocede” al livello degli indigeni (Conrad insegna che le differenze tra gli uomini si fondano soltanto sulle azioni che essi compiono) fra i quali ha scelto di vivere: non è diverso, ha accolto nella sua anima la “profondità selvaggia” (depths of the wilderness) che anche il razionalista Marlow, protagonista del racconto, scopre dentro se stesso. Commenta Asor Rosa: “la grande identità occidentale di Kurtz (…) presentava lesioni e fratture, che la suprema solitudine di quegli spazi e il fascino dei riti selvaggi avevano penetrato e conquistato irrimediabilmente”.
Oggi più di ieri la conquista della virilità appare un’impresa proibitiva, certamente impossibile senza prendere coscienza di quelle lesioni e fratture (vieppiù allargatesi, intanto, con il venir meno del katechon metafisico) e del fatto che la “immense darkness” rimane continuamente in agguato, non solo nell’infuriare della tempesta oceanica di Tifone o nella foresta equatoriale ma nel cuore stesso della civiltà: “le tenebre sono dappertutto”, leggiamo nelle righe conclusive del saggio di Asor Rosa, “nessuno può pensare di liberarsene tranquillamente, neanche quando le vince”.


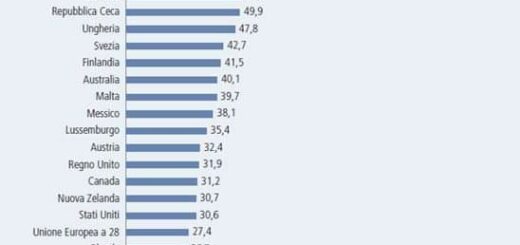
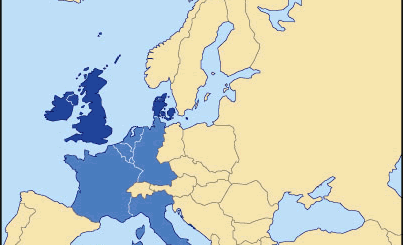




























Commenti recenti