Sull’europeismo retorico
di GIAMPIERO MARANO
Nel saggio L’Italia nell’Unione Europea (edito quest’anno da Rubbettino) Stefano D’Andrea isola e analizza quella particolare manifestazione o articolazione del pensiero unico liberale che egli chiama “europeismo retorico”. L’uso dell’aggettivo “retorico” (e non, ad esempio, “ideologico” oppure “dogmatico”) tiene conto di come la retorica sia stata tradizionalmente considerata il regno dell’incantamento e dell’illusione. La retorica non ha per oggetto né il reale né l’idea ma, come spiega Roland Barthes riflettendo sull’attualità del “verosimile” di Aristotele, preferisce raccontare ciò che il suo pubblico considera possibile, anche se non lo è, a scapito di quello che, seppure effettivamente possibile, viene da quel pubblico stesso respinto.
L’europeismo retorico consiste allora, secondo D’Andrea, nella “tendenza a credere che ogni passo verso l’integrazione [europea] percorso in passato sia stato positivo e che ogni possibile passo verso l’integrazione debba comunque essere accettato”. D’Andrea denuncia la palese fallacia e irrazionalità di questa inclinazione e giunge alla conclusione inevitabile che essa costituisca un “ostacolo al buon senso, alla concretezza e al realismo”.
Già di per sé la sola esistenza di questa retorica suona in modo implicito come un atto di accusa ai molti intellettuali, anche celebri, che ne sono stati irretiti in misura più o meno incisiva, dando prova di uno scarsissimo senso della realtà. Si pensi, fra gli altri, a Morin e a Steiner, l’uno perso in sublimi fantasticherie intorno al progetto di un super-stato federale europeo il cui indirizzo economico dovrebbe ispirarsi al New Deal di Roosevelt, l’altro convinto (forse anche per il desiderio di salvare le specificità delle singole culture locali minacciate dalla globalizzazione anglosassone) che la crescente collaborazione (?) fra le nazioni europee condurrà all’unificazione politica del continente sul modello americano.
D’Andrea osserva, inoltre, che l’influenza negativa dell’europeismo retorico ha ispirato alla classe politica italiana decisioni di enorme importanza come quelle che negli anni Novanta portarono all’adesione all’euro e all’Unione Europea, mentre oggi impedisce la riflessione sulle ragioni della “catastrofe economica”, come la definisce l’autore, che ha travolto l’Italia dopo Maastricht.
Fra i pochi che negli ultimi dieci o venti anni hanno saputo esprimere una posizione in controtendenza rivelatasi lungimirante vanno ricordati Massimo Bontempelli, il quale già nel lontano 2001 avvertiva che l’Europa a cui dobbiamo prepararci lasciando la sovranità nazionale è soltanto quella della moneta e delle banche, e Costanzo Preve, contestatore dell’economicismo (“ideologia spontanea degli imprenditori e dei loro teologi, gli economisti, che mentre fumano la loro pipa-totem emettono mantra in lingua inglese, lingua sacra del capitalismo”) professato da Bruxelles: una fede fanatica che ha provocato, di fatto, la crisi della classe media, la precarizzazione del lavoro, il declino della scuola pubblica, l’aumento della pressione militare statunitense.
Ma i casi di Bontempelli e Preve restano piuttosto isolati. Da noi in certi momenti si è addirittura verificata una sinergia letale tra l’europeismo e un ripugnante disprezzo di sé che è sfociata grosso modo in questa posizione: siccome gli Italiani sono privi, per svariate ragioni storiche, del senso dello Stato, e sono tendenzialmente così anarcoidi e individualisti da raggiungere l’eccellenza soltanto come imprenditori del crimine, essi possono coltivare una sola speranza di salvezza, cioè che li governino gli stranieri (i Tedeschi).
In sostanza, si persiste nell’errore già condannato da Gramsci, quando accusava gli intellettuali italiani di concepire sé stessi come un corpo separato, di non comprendere che non si dà politica senza la “connessione sentimentale” (il gramsciano Pasolini dirà di sentirsi “attaccato [al popolo] nel calore degli istinti”) con la nazione. C’è da sperare perciò in un cambio di passo da parte di figure finora latitanti sotto questo aspetto (artisti, insegnanti, scrittori, ecc.).
Nello stesso tempo, è necessario porre senza timidezze e imbarazzi di sorta la questione fondamentale che D’Andrea solleva nel suo libro: la funzione emancipatrice e solidaristica assegnata allo Stato dalla nostra Costituzione non può essere svolta con la stessa efficacia da un’organizzazione sovranazionale che nasce già nel dopoguerra come “strumento della politica atlantica”, per usare un’espressione di Lelio Basso, e a tutela interessi economici e finanziari di segno opposto a quelli propri dei ceti medio-bassi, cioè del demos.
[“Critica italiana”, 2.10.2022]



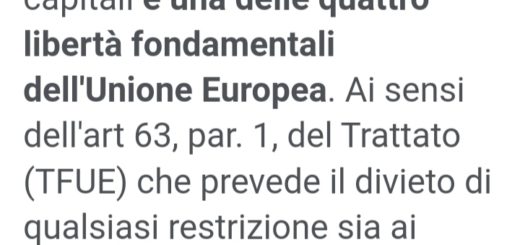


























Commenti recenti