Candidarci alle elezioni del 2023. Ad ogni epoca la sua rivoluzione
di Simone Garilli (RI Mantova)
Per un partito popolare che stia tentando di emergere e di incidere nella vita della nazione le elezioni politiche sono l’appuntamento in assoluto più importante. È quasi banale ricordare il perché: prima di riuscire a candidare su base nazionale il proprio simbolo, il proprio programma, i propri candidati e il proprio stile, ma direi persino il proprio metodo, la propria organizzazione e il carattere dei propri militanti, il partito, semplicemente, non esiste. È sano e razionale che sia così, perché uno Stato nazionale, per dimensioni e complessità, richiede per essere governato la capacità di innalzarsi dalle lotte locali e di corto raggio, per quanto importanti, e di incidere sul terreno sovrastrutturale della politica, della cultura e delle idee. In altri termini, per governare uno Stato moderno serve, come ingrediente imprescindibile, la visione d’insieme, a volo d’uccello, che consenta di ricollegare le particolarità territoriali in un’azione politica organica ed equilibrata.
È per queste ragioni che è del tutto naturale se un partito popolare impiega anni per farsi conoscere e votare anche nella più piccola delle città. Prima viene il momento nazionale, il certificato di nascita del partito davanti alla nazione, poi il momento locale.
Se le elezioni politiche sono sempre decisive per un partito popolare, lo sono particolarmente in una fase storica “reazionaria”, nella quale gli spazi sociali per acquisire notorietà prima e al di fuori degli appuntamenti elettorali sono risicati o quasi inesistenti. Istituzioni svuotate di poteri, sindacati e partiti deboli, attivismo in luogo della militanza, frammentazione estrema delle classi lavoratrici, sono alcuni dei sintomi di queste fasi nelle quali le elezioni rappresentano forse l’unica vera occasione di parlare al popolo nel suo insieme e di segnalare la propria esistenza.
Ci troviamo senz’altro in una fase “reazionaria”, ma non è la prima della nostra storia unitaria e non sarà l’ultima. Può servire dunque volgere lo sguardo al passato, alla storia di uno dei grandi partiti popolari italiani del Novecento e a un frammento significativo del dibattito che al suo interno si svolse intorno all’alternativa tra parlamentarismo e rivoluzione.
La riflessione mi è stata suggerita da alcune letture che riguardano il partito comunista italiano e le figure dei due suoi più celebri dirigenti: Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti.
Ebbene, più ne leggo e più mi rendo conto di quanto possano essere attuali le gesta e gli scritti di entrambi, ben presto accomunati dall’intima convinzione di dover trasformare il Partito Comunista d’Italia (PCd’I), nato come rivoluzionario nel 1921 sull’onda del “biennio rosso” e dell’impresa bolscevica in Russia, in soggetto politico democratico e riformista, sebbene in un senso radicale a molti Italiani oggi sconosciuto.
Nel linguaggio politico di Togliatti si trattava di trasformare il partito comunista in un “partito nuovo”, che si facesse “soggetto decisivo” di una “democrazia progressiva” rispettosa del nuovo quadro istituzionale post-fascista. Nel 1944 la tesi era ormai sostenuta apertamente dal segretario, ma già Gramsci l’aveva elaborata, in modo ovviamente indipendente, durante la lunga gestazione dei Quaderni del Carcere (1929-1935) e, ancora prima, all’interno delle cosiddette “Tesi di Lione” (1926), il documento politico da lui stesso elaborato e votato dalla maggioranza dei delegati al III congresso del Partito per mezzo del quale la corrente sinistra capitanata da Amedeo Bordiga finì in minoranza.
Cerchiamo di capire brevemente cosa divideva Gramsci, e poi Togliatti, dalla retorica rivoluzionaria del bordighismo, e perché tutto ciò è di grande attualità.
Il PCd’I nacque da una scissione interna al Partito Socialista Italiano, accusato di ritardare, o peggio soffocare nella culla, la rivoluzione del proletariato che sarebbe seguita di lì a poco anche in Italia. I sommovimenti operai del biennio 1919-1920, in effetti, rendevano lo scenario del tutto verosimile, ma nonostante quella stimolante apparenza le pretese rivoluzionarie si spensero di fronte all’offensiva squadrista e alla nascita del Partito Nazionale Fascista, capace di prendere il potere profittando del rischio calcolato (male?) dai notabili liberali e poi, soprattutto, di mantenerlo per un ventennio.
È storia nota, mentre lo è meno il dibattito intellettuale e politico che si dispiegò negli anni e decenni seguenti intorno alla natura e alla funzione storica del fascismo, in particolare all’interno del partito comunista italiano. Tra le varie interpretazioni proprio quella gramsciana è particolarmente degna nota.
Il contributo teorico di Gramsci consistette nel vedere prima e meglio di altri che il fascismo non sarebbe stato fenomeno provvisorio, ma di lungo o lunghissimo respiro, capace di attuare quella “rivoluzione passiva” di cui l’intellettuale torinese scrisse ampiamente durante la sua permanenza nelle carceri di regime. Il fascismo, in altre parole, era stato in grado di incidere profondamente sull’“educazione politica” delle classi popolari, compresa in certa misura la classe operaia a cui il partito rivoluzionario avrebbe dovuto rivolgersi per prendere il potere e mantenerlo a sua volta. Il fascismo non solo aveva stoppato la rivoluzione, ma l’aveva resa impossibile, se mai fosse stata un’opzione concreta alle porte del 1922; e impossibile non tanto sul lato operativo, dato che non sarebbero in astratto mancate le forze per rovesciare il regime, ma sul lato politico, ovverosia sul lato del consenso di massa e di lungo periodo di fronte a una prospettiva comunista e alla ovvia reazione che ne sarebbe seguita.
Fu questa una conclusione a cui Gramsci, paradossalmente, poté giungere in relativa libertà, proprio perché libero non era. Chi al contrario, come Togliatti, si trovava a dover dirigere clandestinamente e dall’estero un partito legato alle parole d’ordine rivoluzionarie sulle quali era nato solo pochi anni prima, non poteva che dissimulare in qualche misura le nuove convinzioni, che pure nel frattempo coltivava.
In questo consiste lo spartiacque nella storia del partito comunista italiano: nel rendersi conto, prima al livello individuale e delle più alte sfere dirigenziali, poi gradualmente e faticosamente al livello dei quadri intermedi, e infine in certa misura anche al livello di base, che la via per la rivoluzione era preclusa nel breve e nel lungo termine. Era dunque precluso il comunismo, mentre i giochi erano aperti per una prospettiva socialista di riforma graduale e radicale della struttura capitalistica, riservando al PCI il ruolo di perno del sistema democratico e parlamentare che nel frattempo doveva essere accettato, legittimato e addirittura protetto da attacchi esterni.
Per uno studioso del comunismo italiano appassionato e attento come Luciano Canfora è in questa strategia riformista radicale di lunga durata, capace di resistere alle oscillazioni ideologiche e strategiche dell’Unione Sovietica e ai tentativi di boicottaggio di oscuri poteri nazionali e internazionali, che si scorge la grandezza politica di Palmiro Togliatti, non un semplice “tattico”, ma molto di più.
Con le parole dello stesso Canfora:
“[Togliatti] cerca di far capire che il fatto macroscopico della vittoria (a suo tempo) del fascismo, della sua lunga durata e del suo radicamento ‘corruttore’ di tutte le classi, nonché il tipo di forze politiche e sociali molteplici che contro di esso, man mano, si sono mobilitate (e, fattore non da poco, l’alleanza militare che lo sta sconfiggendo), impongono, ad un Partito che può anche continuare a denominarsi «comunista», una strategia di lungo periodo del tutto nuova. […] [che il nuovo scenario] impone con urgenza di cambiare obiettivi e ri-orientare la concreta azione politica per un partito che abbia saputo far tesoro dell’esperienza, e intenda operare non predicare”[1].
“Radicamento corruttore di tutte le classi”.
Cosa è stato, se non questo, il lungo trentennio neoliberale che ha iniziato ad agire sul corpo ormai fragile e indifeso della classi popolari dopo la definitiva mutazione del partito comunista e la caduta in disgrazia degli altri partiti della Prima Repubblica?
Ancora Canfora, commentando l’attualità dei Quaderni, nota che:
“Antonio Gramsci investe tutto se stesso nella politica mentre sembra avviarsi ormai la marcia trionfale della rivoluzione […] e muore mentre il fascismo appare vincente dovunque. Perciò uno dei fili conduttori principali del suo pensiero è l’analisi del fenomeno costituito dal fascismo, cioè dal principale soggetto e fattore politico-sociale che ha reso impossibile la rivoluzione socialista in Italia. […] Non a caso il suo pensiero ritorna di attualità ogni volta che il rapporto delle forze in campo è a favore della reazione, e la rivoluzione è sconfitta o rinviata sine die, o comunque reinterpretata come lungo processo di trasformazione […] Perciò egli è così attuale oggi, quando abbiamo ormai alle spalle vent’anni di storia successiva allo sgretolamento dell’ultimo prodotto statale delle rivoluzioni europee del Novecento, e il socialismo sopravvive soltanto in quanto gestione alternativa del sistema economico vigente”[2].
Dunque, l’insegnamento che possiamo e dobbiamo cogliere, oggi, dall’evoluzione del pensiero dei due massimi dirigenti comunisti, è cristallino: non si dà rivoluzione in una fase storica reazionaria, quando i rapporti di forza siano pesantemente sbilanciati a favore delle classi dominanti. Dove per rivoluzione si intende, a scanso di equivoci, il colpo di mano da parte di una minoranza popolare (una classe) in seguito alla quale si apre una fase costituente che capovolge l’ordinamento precedente soffocando la reazione.
Nel dibattito odierno sulla funzione dell’anti-europeismo, allora, dovremmo partire da una domanda ben precisa: è nostro compito costruire il partito-avanguardia, della rivoluzione di classe, o il partito di massa, del socialismo democratico e parlamentare?
A seconda dell’analisi di fase e della risposta a questa domanda ci si organizza per un fine, che deve essere sempre chiaro ed esplicito, almeno all’interno del partito che lo persegue.
Accenniamo a una risposta. In che fase siamo? Credo che tutti saremo d’accordo nel rispondere che ci troviamo in una fase saldamente reazionaria, nella quale le classi popolari si trovano in condizioni di estrema debolezza e la “corruttiva” ideologia neoliberale è radicata profondamente nella maggioranza, nonostante qualche primo segnale di risveglio.
Se la fase è questa, sarà conseguente rispondere anche alla seconda questione: partito-avanguardia o partito-massa? In tutta evidenza la seconda opzione, non essendo minimamente all’orizzonte una classe rivoluzionaria in grado di egemonizzare le altri classi popolari, realizzare il colpo di mano e resistere alla reazione del sistema sull’onda dei consensi maggioritari di cui gode nella società.
Infine, dall’analisi e dalla scelta di campo, deve emergere la prassi. Qual è il mezzo di gran lunga più efficace, di fronte alla “rivoluzione passiva” neoliberale, per trasformarsi in partito-massa e iniziare il lungo processo di risveglio e riunificazione delle classi popolari? In assenza di prospettive strettamente rivoluzionarie, e in assenza d’altra parte di un impedimento giuridico e formale all’esercizio della democrazia parlamentare (a differenza che in epoca fascista) senza alcun dubbio le elezioni politiche, vale a dire l’accettazione non soltanto dello scenario parlamentare, che è dato per scontato e ci entusiasma, ma anche di una dolorosa realtà: la stragrande maggioranza del popolo, oggi, consuma politica, e ritiene perciò di non aver altri doveri se non quello di apporre una x sulla scheda elettorale ogni cinque anni. Per il resto del tempo, quando si occupa di politica, lo fa consumandola sui social o dalla televisione. La dimensione politica nelle fabbriche, nelle sezioni locali di partito o nelle piazze è venuta quasi totalmente a mancare, se non in rari casi riguardanti una stretta minoranza che esprime necessità corporative, comprensibilmente dati i rapporti di forza.
Non a caso Riconquistare l’Italia, al suo quinto anno di vita come partito, decimo se si conta anche la fase associativa, si è dato uno scopo di fase ben definito per i prossimi due anni: costruire in ogni collegio l’esercito che nei mesi precedenti alle elezioni del 2023 marcerà come un sol uomo per raccogliere le firme, farsele autenticare, presentare una lista di buoni e ottimi candidati in grado di occupare gli spazi mediatici e pubblici che la legge garantisce e di far notare il partito, la sua singolarità, la sua natura romantica e popolare, diffondendo i suoi principi e un programma coerente e raffinato, che promanerà dalla Costituzione del 1948 e dal presupposto del recesso dall’Unione Europea.
Se possibile e necessario, per riuscire nell’impresa Riconquistare l’Italia dovrà unire le sue forze in un’alleanza con una o più formazioni anti-europeiste, che condividano l’importanza dell’appuntamento elettorale e abbiano saputo costruire, negli anni, un solido nucleo di militanti perlomeno in alcuni collegi.
Questo è tutto ciò che dobbiamo fare nei prossimi due anni, all’ombra dei riflettori nazionali, lasciando in certa misura libertà di scelta sulle azioni più consone per raggiungere il fine a ogni gruppo locale e a ogni militante, dato il carattere e le capacità che esprimono.
Presentare alla nazione il simbolo di Riconquistare l’Italia, da solo o a fianco di quello di altri partiti anti-europeisti, è il primo fondamentale passo del nostro tentativo “di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Ad ogni epoca la sua rivoluzione.
[1] Luciano Canfora, La metamorfosi, Laterza, Bari, 2021, pag. 17.
[2] Luciano Canfora, Gramsci in carcere e il fascismo, Salerno Editrice, Roma, 2015, ed. digitale.


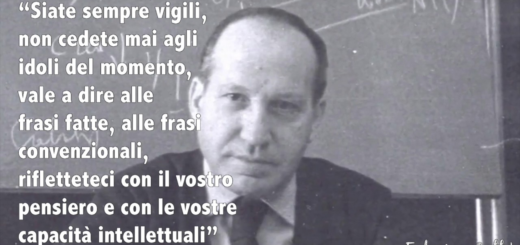





























Commenti recenti