È tutta “colpa” della Germania? L’inguaribile miopia dei progressisti
di SIMONE GARILLI (FSI Lombardia)
In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore Gustavo Piga, economista non ortodosso, progressista ed europeista, insiste ancora una volta sulla necessità di un’unione fiscale europea contro l’austerità, per evitare la risacca nazionalista. La frontiera del “più Europa”, con annessa critica alla Germania colpevole del rigore e dei populismi, è l’ultima e la più dura a morire. Non ci si spinge ormai a chiedere un governo federale europeo sul modello statunitense, essendo sempre più evidente che gli “egoismi nazionali” (cioè la cultura, la storia, le istituzioni e in ultima istanza la sovranità nazionale) sono irriducibili alla limitata e disciplinata autonomia degli Stati americani. Si ripiega allora su una più modesta unione fiscale continentale, come se questa non avesse bisogno di un’eguale consenso da parte delle singole nazioni per inverarsi. Anche l’ultima frontiera dell’europeismo, quindi, è destinata a sgretolarsi di giorno in giorno. La lunga durata dei cambiamenti storici strutturali non consente previsioni precise, ma sembra scontato che un grande sconvolgimento istituzionale sia sempre più vicino, in Europa.
Da quel momento non potrà che esasperarsi anche lo scontro politico e ideologico fra i singoli Stati nazionali. Di certo la disgregazione dell’euro e dell’Unione Europea, con la sua ricomposizione su altra scala (euro del Nord, doppio euro, oppure monete nazionali legate fra loro da cambi semi-fissi) metterà al centro del dibattito il tema dell’austerità tedesca, con il rischio che tutte le responsabilità del fallimento europeista siano riversate sulla geopolitica mercantilistica della Germania. Sarebbe un errore, perché non si apprezzerebbe la natura storica del progetto di integrazione europea, che è francese e americana, in particolare. La Germania, lungi dall’esserne l’ideatrice, ne è in un certo senso la vittima, a cui è stata di fatto imposta una disciplina politica lasciando libero sfogo al mercantilismo economico. Sarebbe più corretto, in effetti, parlare di ‘geoeconomia’ tedesca, piuttosto che di geopolitica[1]. La Germania europea è una creazione atlantica, e non è in alcun modo un progetto dei tedeschi, come dimostra la costante (e oggi crescente) avversione di quella popolazione all’idea del federalismo europeo. Non è da sottovalutare, a questo proposito, il fatto che dopo la riunificazione al popolo tedesco non fu concesso nemmeno un referendum consultivo per esprimersi su Maastricht e dintorni. La Germania rinunciò al marco e alla Bundesbank come ultimo e più significativo atto espiatorio dei disastri nazionalistici novecenteschi che aveva prodotto (di certo non da sola) e in cambio della riunificazione, che spaventava Francia, Gran Bretagna e naturalmente Stati Uniti. Solo il senso di colpa, che aveva consentito alla dottrina ordoliberale dello Stato minimo di penetrare nel tessuto connettivo della Germania federale nel secondo dopoguerra, ha poi permesso ad una classe dirigente europeista di governare un popolo non europeista e di trascinarlo in un progetto sostanzialmente anti-tedesco, e quindi, per derivazione, anti-popolare.
Va notato, in effetti, che sia la dottrina ordoliberale sia l’eurozona per tornare utili al mercantilismo tedesco richiedono salari reali inferiori alla produttività, e quindi un arretramento della quota salari rispetto a quella dei profitti, con ristagno della domanda interna e prosciugamento degli investimenti. Lo Stato sociale, in questo contesto, ha l’unico scopo di sostenere politicamente un sistema iniquo in prima istanza per i lavoratori tedeschi, con lo Stato che da imprenditore strategico si fa stampella e ammortizzatore dei disastri sociali prodotti dal mercato. Di qui gli sforamenti tedeschi dei Trattati europei per finanziare dei cuscinetti sociali che rendessero accettabile persino l’Agenda 2010, cioè la precarizzazione selvaggia del lavoro attraverso gli ormai noti mini-jobs. Questa è la Germania dentro l’euro, nonostante la gran parte degli intellettuali abbagliati dallo sfavillante modello tedesco non lo abbia riconosciuto a lungo: precarietà, quota salari decrescente, mercantilismo e i tanto esaltati ammortizzatori sociali, a chiudere un cerchio non replicabile in vitro. Già, perché il modello tedesco è sostenibile solo e soltanto dal centro, mentre è per definizione impraticabile dalle periferie europee, inclusa la Francia, essendo un gioco a somma zero in cui uno vince e tutti gli altri perdono. Vince la Germania, ma non tutta la Germania, bensì quella delle grandi aziende internazionalizzate; perdono tutti i lavoratori tedeschi, esclusi forse solo i lavoratori che di quelle grande aziende sono dipendenti. Proprio essi contribuiscono ad alimentare il mito dell’operaio tedesco che non solo si becca fior di quattrini ogni mese, ma poi incassa anche ingenti premi di produttività. Se è vero, ad esempio, per l’operaio della Volkswagen, che dire di tutti gli altri? E delle infrastrutture obsolescenti? E dell’importazione da Est e da Sud di migranti che abbassano il costo del lavoro, anche per sopperire al non casuale declino demografico interno? Non sono distorsioni di un modello virtuoso, ma il lato oscuro (perché oscurato) di un modello politicamente insostenibile per i Paesi concorrenti e per la stessa classe dirigente che lo ha attuato, sul medio periodo.
Questa la necessaria premessa. Non una Germania neo-imperiale, ma una Germania accerchiata sin dal secondo dopoguerra e poi condotta a piccoli passi in un vicolo cieco: l’europeismo atlantico. Logico che la classe dirigente tedesca, nell’orizzonte post-riunificazione, abbia rinunciato ad una autonoma politica estera solo in cambio di una consistente contropartita, perfettamente complementare alla sua nuova dottrina ordoliberale. Si tratta, appunto, di un euro formato marco, con una Banca centrale europea modellata sulla Bundesbank, disinteressata cioè alla piena occupazione e focalizzata sul solo controllo della stabilità monetaria, per un’inflazione “sotto ma vicino” al 2% annuo.
Perciò, se è ingenuo parlare di “colpe” per quanto riguarda i PIIGS – e sono quindi da rigettare le vergognose categorie pre-politiche che anche noi italiani ci sentiamo appioppare da qualche decennio (corrotti e spreconi) – nemmeno si può fare lo stesso errore con la Germania, riducendo il popolo tedesco ad una massa informe di freddi e banali calcolatori colpevoli della disintegrazione europea. L’insuccesso del progetto europeista non può essere addebitato alla Germania, né tantomeno ai tedeschi, che mai l’hanno richiesto.
In effetti la Germania di Angela Merkel, da organismo complesso quale è, non si è limitata a digerire un preparato che mentre la arricchiva di crediti di dubbio valore e di posizione economiche anche molto vantaggiose mirava a spogliarla di autonomia geopolitica. Come sostenuto da diversi e autorevoli commentatori di quel Paese[2], negli anni dell’euro il sentimento “nazionalistico” è cresciuto sotto traccia ed è poi affiorato carsicamente in un primo progetto politico fumoso e fallimentare (Piratenpartei) e in un secondo ben più solido (Alternative für Deutschland). L’ambiguità e l’immobilismo di Angela Merkel sono quindi il frutto non tanto di un moderatismo congenito suo e del partito, ma di un contesto interno finalmente capace di condizionare l’europeismo tendenziale della Cancelliera. Proprio la crescita sostenuta di AfD ha portato la CDU a riconsiderare l’enfasi retorica con la quale si parlava di integrazione europea, di salvataggi o di eurobond. Ogni giorno che passa l’unione fiscale europea è più lontana, mentre il federalismo vero e proprio non è mai stato in gioco. E d’altro canto i contatti, ancora prevalentemente economici, con la Russia di Putin e con la stessa Cina sembrano aver avuto negli ultimi tempi una decisa accelerazione[3].
Che senso ha, allora, riproporre ancora e ancora il miraggio di un’unione fiscale europea concessa da una Germania colpevole ma redenta? La miopia progressista, con particolare forza in Italia, tende a rimuovere la prospettiva della disgregazione di euro e Unione Europea, come fosse tabù, nonostante sia ad oggi evidentissimo che altra prospettiva politica non c’è, data la natura reazionaria, anti-popolare e imperialista del progetto unionista, sin dall’inizio.
La scelta, non più eludibile, è tra un patriottismo con forti accenti socialisti – legato in Italia al testo simbolico e normativo della Costituzione e al principio politico della sovranità nazionale che le è implicito – e un europeismo di maniera che ha come unica prospettiva un sempre più accentuato autoritarismo, sia pur confezionato nel solito bel pacchetto liberale. Autoritarismo che, peraltro, da liberale potrebbe trasformarsi in tempi non lunghi in illiberale, secondo uno schema molto simile a quello degli anni Trenta. Almeno a quel punto, cioè quando sarebbe troppo tardi, gli intellettuali progressisti riconoscerebbero la differenza sostanziale tra nazionalismo e patriottismo, o continuerebbero a bollare come retrogradi e nazionalistici anche i richiami alla Costituzione socialdemocratica del ’48?
Apriamo a questo punto una breve parentesi strategica. Naturale che, dopo l’ennesima “trappola Versailles”[4] imposta alla Germania con i progetti connessi dell’Unione Europea e dell’euro, il risentimento popolare tedesco abbia prodotto non una uscita keynesiana e socialdemocratica dalla crisi, ma le politiche di austerità. Il dibattito europeo, impostato su basi moralistiche fin dall’inizio (euro e Bce per controllare una riunificazione a cui seguirebbe necessariamente, per natura germanica, il Quarto Reich), ha poi giustificato una risposta altrettanto moralistica, fastidiosa e criminale, nei confronti dei Paesi del Sud Europa, Italia e Francia incluse. Se l’austerità è un nemico del popolo italiano e della sovranità nazionale, lo è per definizione anche la Germania che ne è testarda fautrice. Ma limitarci a questo sarebbe un gravissimo errore. Allargare la prospettiva storica e geografica sulla natura dell’Unione Europea ci permette di relativizzare la dannosissima politica tedesca, inserendola nel suo contesto geopolitico. Non ne escono meglio gli Stati Uniti e la Francia, anzi. Non ne esce per nulla bene, in prima istanza, la classe dirigente italiana che ha permesso al criminale progetto europeista di fare il suo corso e che adesso alza il ditino contro la Germania irresponsabile solo perché il Fondo Monetario Internazionale ha cambiato idea sull’austerità europea (per ragioni di raggiunta insostenibilità geopolitica)[5]. Se di nemici del popolo italiano vogliamo parlare, allora, ne abbiamo perlomeno uno lontano e uno vicino, con quello lontano che, al di là del lato più direttamente materiale, ha indotto senza dubbio anche un imbarbarimento culturale nella popolazione italiana e nella sua classe dirigente. Entrambi andranno affrontati. A logica quello vicino va affrontato per primo[6], per recuperare al livello nazionale leve economiche fondamentali, ma non è affatto escluso che in futuro, quando la classe dirigente tedesca di matrice europeista sarà stata cacciata da nuovi partiti popolari, per affrontare il nemico lontano sia necessaria una politica amichevole nei confronti della Germania e dei suoi alleati, fra i quali potremmo trovare la Russia.
Per chiudere torniamo al punto di partenza: c’è poco da chiedere a pseudo intellettuali come Gustavo Piga. La chiara sconfitta della loro ultima frontiera ideologica – di recente arricchita da un miope sentimento anti-tedesco – sarà l’unico e involontario contributo al progresso sociale che potranno fornire, dopo decenni di disastri. In effetti, quando anche l’ultimo appello ad una unione fiscale europea democratica e keyensiana verrà ridicolizzato dai rapporti di forza e dall’esasperazione sociale, potrà completarsi il benefico distacco popolare dall’orizzonte corrotto della Sinistra (moderata e non). Della stessa categoria di Sinistra, oggi, non c’è più alcun bisogno, vista la precisa parabola storica a cui questa filosofia politica si è consegnata logicamente. C’è bisogno eccome, invece, della categoria ben più ampia e promettente di Socialismo, purché la si rinnovi a partire da una lettura rigorosa ma critica di Marx e dei migliori marxisti. Su questo, altrove.
[1] Di ‘geoeconomia’ tedesca ha scritto il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, nell’editoriale del numero 4/2011 della rivista. Si legge in particolare: “Se un Generalplan tedesco non esiste, tuttavia i percorsi geoeconomici della Repubblica di Berlino, in linea con la proiezione internazionale delle sue grandi aziende (come E.ON Ruhrgas in Russia, Siemens, Volkswagen e BMW in Cina) e delle sue robuste fondazioni di partito (Adenauer ed Ebert), la ridisegna non solo come potenza centrale d’Europa ma come fattore inaggirabile sulla scena globale. Il confine fra geoeconomia e geopolitica è sfumato”.
[2] Ad esempio Ulrike Guérot, fondatrice dell’European Democray Lab (EDL), che nel sopracitato numero 4/2011 di Limes scrive: “Quella sensazione di «essere di nuovo qualcuno» trova espressione nelle innocenti bandiere tedesche e in quello che gli osservatori stranieri definiscono «nazionalismo economico tedesco» o «nazionalismo costituzionale», emerso ad esempio nel recente dibattito sugli squilibri della bilancia commerciale nell’Unione Europea o nella sentenza della Corte costituzionale federale sul Trattato di Lisbona. La fedeltà ai propri princìpi e la superiorità economica fanno presto a tradursi nella pretesa di avere l’ultima parola nel dibattito economico e giuridico europeo. Dopotutto, la Germania basta a se stessa e vorrebbe solo essere lasciata in pace. Questo nuovo provincialismo tedesco si è espresso anche nella decisione di astenersi dal voto sulla risoluzione 1973 in sede Onu 9. Perché la Germania ha di fatto troppo potere in Europa per pretendere di non esercitarlo. Il dilemma è proprio questo. Oggi Berlino non è in grado di rispondere alla domanda: «Il potere per ottenere cosa?». Domanda che a Bonn non è mai stata posta.
[3] La vicenda del gasdotto North Stream è la più evidente dimostrazione di come con l’economia la Germania tenti di far rientrare dalla finestra un’autonomia geopolitica che aveva cacciato dalla porta accettando il progetto europeo. Si legga questo articolo.
[4] Si segnala a tal proposito un altro illuminante editoriale di Lucio Caracciolo, al numero 9/2016 di Limes (La sindrome di Versailles).
[5] Si legga, ad esempio, questo articolo della Stampa.
[6] Si veda a questo link il punto 14 del Documento di analisi e proposte del Fronte Sovranista Italiano (“Combattere e sconfiggere prima il nemico vicino; poi il nemico lontano“).



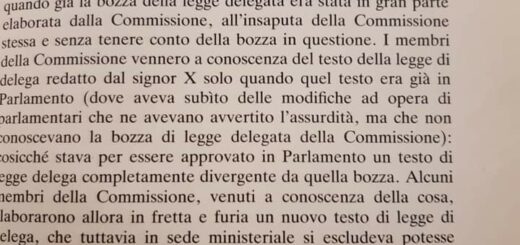



























Commenti recenti