Le teorie politiche radicali e la pubblicità
di Stefano D'Andrea
La contestazione del sistema di vita occidentale e dell’assetto politico-economico italiano è condotta da molteplici punti di vista. Si tratta di critiche svolte piuttosto o esclusivamente con il pensiero e le parole, che con le azioni, perché l’azione sembra divenuta impossibile. Eppure le contestazioni – le idee e le proposte – esistono e lentamente di diffondono.
C’è chi concentra la critica sull’unipolarismo statunitense e desidera il multipolarismo, constatando una tendenza all’affermazione di quest’ultimo.
Altri sono convinti che vi sia poco vantaggio nel trascorrere dall’unipolarismo al multiporalismo se non si modifica il “modello di sviluppo”. La formula “nuovo modello di sviluppo” è obiettivamente generica e inidonea a designare alcunché; invero si tratta di una formula e non di un concetto, perché un concetto è il contenuto o significato di una formula. Tanto che, leggendo le proposte più analitiche di coloro che la utilizzano, emergono divergenze, persino qualche contrasto e comunque diversi ordini di priorità. Inoltre, molti contestano proprio il concetto di modello di sviluppo e il termine sviluppo in sé stesso, sostenendo che sia privo di significato pratico e di valore positivo anche il concetto di sviluppo sostenibile. Da qui l’idea della decrescita o meglio della “acrescita” come suole precisare il principale teorico della medesima, il quale ha ammesso che decrescita è uno slogan, correlativo a quello di crescita.
L’idea della decrescita, o forse meglio della acrescita, è abbracciata anche dagli antimoderni, che criticando il produttivismo sia di matrice liberale che di matrice marxista, da un lato, perorano l’essenziale e contestano l’inutile, dall’altro, constatano che i cittadini occidentali sono vittime di un mostruoso sistema di controllo.
I keynesiani e i marxisti, per lo più ormai ex marxisti convertiti al keynesismo, guardano alla distribuzione della ricchezza, si compiacciono della crisi della ideologia cosiddetta neoliberista (anche se sono consapevoli che la crisi della ideologia non ha ancora comportato la crisi degli assetti di potere che l’hanno generata) e propongono suggerimenti per redistribuire la ricchezza, invero prestando quasi sempre poca o nessuna attenzione sia ai profili non (strettamente o direttamente) materiali della vita dei cittadini occidentali, e italiani in particolare, sia ai profili materiali relativi alla vita dei lavoratori autonomi, dei contadini, degli artigiani e dei commercianti, i quali, svolgendo professionalmente attività in concorrenza con il capitale, ovvero lavorando “professionalmente” (anche) per il capitale, hanno, mediamente, visto diminuire nell’ultimo decennio i loro redditi (non, invece, il tenore di vita, sostenuto dall’indebitamento).
Pure le teorie alle quali preme principalmente il tema dell’affermazione della sovranità monetaria dei popoli, talvolta, non si discostano dal piano economico-materiale; esse, insomma, promettono più ricchezza, meno debiti e nient’altro. Mentre in altre varianti delle medesime teorie il principio della sovranità monetaria del popolo si lega a profili spirituali (la parola, per la capacità di designazione sintetica di innumerevoli profili della vita umana, deve essere senz’altro sdoganata): indipendenza, autonomia, ecc.
Un certo antieuropeismo, generale o speciale, ossia relativo ad alcuni profili dei trattai europei, caratterizza pressoché tutte le teorie critiche. Mentre l’invocazione della nostra Costituzione riscuote il consenso della maggioranza delle teorie, non dell’unanimità. Anche la necessità una nuova e severa disciplina del “diritto dei mercati finanziari” va finalmente facendosi strada, invero, non soltanto all’interno delle teorie radicali. Infine, la critica della società dei consumi, cara agli antimoderni, è diffusa e si stringe ora con l’una ora con l’altra delle teorie segnalate, salvo quelle strettamente economicistiche e sovente essa si lega alla critica della “videocrazia” sulla quale, anche sul web è possibile leggere pregevoli contributi (per esempio quello di Andrea Inglese, “Videocrazy” o del fascismo estetico – cfr. http://www.nazioneindiana.com/2009/09/09/videocracy-o-del-fascismo-estetico/ – anche se non concordiamo con la scelta della formula “fascismo estetico”).
Sarà necessario riuscire ad elaborare una sintesi organica e coerente, che soddisfi il più possibile le diverse istanze e ciò al fine di creare un partito alternativo al partito unico delle due coalizioni (sul “partito unico delle due coalizioni” ci permettiamo di rinviare ad un nostro recente articolo: https://www.appelloalpopolo.it/?p=106). Senza la sintesi organica e coerente, infatti, le teorie sono destinate a restare tali e non hanno alcuna possibilità di trasformarsi in azione politica. E per trovare la sintesi dovranno essere individuati i collanti e gli elementi comuni alle diverse istanze critiche.
Orbene, poca o nessuna importanza danno le teorie critiche, o almeno molte di esse, alla pubblicità. Chi ha studiato a fondo il tema si è limitato alla descrizione del fenomeno, sovente condotta con grande profondità di analisi, e a prevedere l’impossibilità della riduzione della pubblicità. Secondo Baudrillard, Il sistema degli oggetti, 1968, trad. it., Milano, 1972, p. 221, senza la pubblicità, ci sentiremmo orfani: “Soppressa la pubblicità, ci si sentirebbe frustrati di fronte ai muri vuoti. L’uomo non si sentirebbe soltanto frustrato, privato di una possibilità (anche ironica) di gioco e sogno, ma a livelli più profondi penserebbe che la società non si occupi di lui”. Forse i sostenitori delle teorie critiche accolgono quest’ultima conclusione: della pubblicità non potremo mai più fare a meno. E tuttavia, osserviamo, se si muove da quel presupposto è inutile svolgere critiche al sistema, il quale, senza una severa limitazione della pubblicità potrà, al più, essere scalfito; mai rovesciato o severamente riformato. Sul tema della pubblicità, perciò, intendiamo portare l’attenzione, posto che, a nostro avviso, l’idea della limitazione della pubblicità può e deve essere uno dei collanti e quindi uno dei pilastri della auspicata sintesi organica e coerente.
Crediamo, infatti, che il centro propulsore del sistema sia – in misura pari, se non maggiore, del potere dei gestori del grande capitale finanziario, e del dominio statunitense, soltanto parzialmente indebolito negli ultimi anni – la pubblicità, la quale svolge quattro funzioni, senza le quali la vita dei paesi occidentali, e dell’Italia per quel che più ci preme, sarebbe completamente diversa da quella che è. Per questo abbiamo scritto nel nostro manifesto che “La pubblicità deve essere ridotta. Una lenta ma inesorabile riduzione della pubblicità: questa è la strada” (https://www.appelloalpopolo.it/?p=22).
In primo luogo, la pubblicità concorre a creare i linguaggi, gli stili, i desideri, i problemi, le soluzioni, le gerarchie di valori e quant’altro presiede alla vita associata del popolo. La pubblicità concorre in misura notevole a “formare” i cittadini, che sono come sono perché vivono in un mondo dominato dalla pubblicità e che sarebbero diversi se la pubblicità fosse, non dico vietata, ma notevolmente limitata. Questa influenza non può essere negata. È la funzione “indicativa” della pubblicità, che si accosta alla funzione “imperativa” (Baudrillard, Il sistema degli oggetti, cit.,p. 211). Orbene, chi esercita questo potere? I detentori di grandi capitali, italiani e stranieri, specificamente i detentori dei “marchi” (i quali lo esercitano per mezzo dei pubblicitari e acquistando “spazi pubblicitari” dai venditori di pubblicità). Essi, con il tempo, si sono andati affiancando alla scuola, all’università, alla famiglia, alla chiesa, ai partiti, ai sindacati, alle altre formazioni sociali, alla letteratura e alla filmografia e, pian piano, hanno rafforzato e sono riusciti a rendere assolutamente dominante la loro posizione, anche grazie alla potenza della tecnica con la quale esercitano il potere, mentre tutti gli altri concorrenti, anche per colpe e limiti propri, perdevano capacità di influenza, al punto che quest’ultima in molti casi ha addirittura finito per estinguersi.
Se solo si riflette che i soggetti perdenti – nella disputa per il potere di “formare” i cittadini – o sono uomini e quindi lavoratori che creano l’opera (letteraria o cinematografica) o insegnano (i maestri e i professori), o sono soggetti collettivi, costituiti da uomini i quali fanno (o meglio dovrebbero far) “vivere” i primi con il lavoro e/o l’impegno gratuito, o sono istituzioni pubbliche appartenenti a tutti i cittadini, considerati in posizione di uguaglianza a prescindere dalla differenze economiche, non si dovrebbe nutrire alcun dubbio che il potere dei titolari di marchi di formare i cittadini debba essere limitato, a favore di poteri – perché i “poteri” (giuridici, come la scuola pubblica, ovvero di fatto, come la chiesa e come la famiglia) sono sempre esistiti e sempre esisteranno – più democratici, nascenti dal basso e comunque poteri dell’uomo e frutto del lavoro degli uomini e non del capitale. Le legittime e quasi sempre fondate critiche alla scuola, all’università, alla chiesa, ai partiti, ai sindacati e ad altre formazioni sociali implicano che quelle istituzioni devono, eventualmente, essere riformate. Invece, il potere dei titolari dei marchi di formare l’opinione pubblica deve essere distrutto.
In secondo luogo, la pubblicità ha un luogo, quasi “naturale”, all’interno del quale vive e senza il quale sarebbe pressoché ininfluente: i media, ossia i mezzi che altri detentori di capitali e detentori al tempo stesso di un capitale-marchio (Fininvest, RCS, e così via) utilizzano per “informare” e intrattenere i cittadini e, così, formare l’opinione pubblica. Come già abbiamo avuto modo di scrivere (cfr. https://www.appelloalpopolo.it/?p=163), il potere di formare l’opinione pubblica di questa seconda forma o specie di capitale è enormemente rafforzato dal fatto che l’attività di “informazione” e di “intrattenimento” è in gran parte finanziata dalle società titolari di marchi, le quali pagano le società titolari dei media – sovente dominate, nei consigli di amministrazione, dalle banche o con queste indebitate e quindi dalle banche condizionate -, affinché pubblicizzino i loro marchi e prodotti (e il denaro speso per la pubblicità è detratto dal reddito ai fini del pagamento delle imposte!). Non è un caso che al vertice politico dell’Italia si trovi un venditore di pubblicità (è questo il campo in cui Berlusconi si è rivelato un “grande imprenditore”: vendere gli occhi e con essi le menti dei cittadini alle società che hanno interesse a pubblicizzare i loro marchi e prodotti). La limitazione della presenza della pubblicità sui media non soltanto ridurrebbe o estinguerebbe il potere dei detentori dei marchi (esercitato attraverso i pubblicitari) di formare il modo di essere dei cittadini, bensì, al tempo stesso, limiterebbe il potere del capitale detentore dei media di formare l’opinione pubblica. E ciò a tutto vantaggio del principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini, che potrebbero fondare sul lavoro, individuale o cooperativo, attività, imprenditoriali o meno, di informazione e intrattenimento, potendo concorrere (con siti, blog, giornali, riviste), non dico ad armi pari ma quasi, con i media appartenenti al grande capitale. Se fosse introdotto il divieto di inserire pubblicità sugli organi di informazione e di intrattenimento, i grandi quotidiani nazionali dovrebbero chiudere o comunque ridurre notevolmente le pagine. E lo stesso vale per le riviste appartenenti ai grandi gruppi editoriali. Le televisioni private generaliste scomparirebbero o trasmetterebbero poche ore al giorno e dovrebbero guadagnare dalla vendita diretta di trasmissioni e spettacoli ai cittadini, anziché, come accade ora, dalla vendita degli occhi e delle menti dei cittadini ai titolari di marchi che pagano la pubblicità. Ugualmente, le televisioni private non generaliste dovrebbero cercare di ricavare profitti dalla vendita diretta dei loro spettacoli e documentari agli spettatori e non, come accade ora, dalla vendita degli occhi e delle menti dei cittadini ai detentori di marchi che pagano per potersi far conoscere e imprimere nella mente degli spettatori, non soltanto il marchio e il prodotto, ma uno stile di vita. È chiaro che molti grandi media chiuderebbero e sarebbe spezzato o comunque di gran lunga limitato il “dominio delle onde” (per un accenno e per una importante citazione relativa al dominio delle onde si veda S. Latouche, La fine del sogno occidentale – saggio sull’americanizzazione del mondo, 2000, trad. it., 2002, s.l., p. 10) e con esso si indebolirebbe anche la sudditanza culturale e quindi politica nei confronti degli Stati Uniti che tale dominio esercitano da lungo tempo.
In terzo luogo, la pubblicità consente uno “sviluppo” economico che altrimenti non si avrebbe: enormi investimenti su un “nuovo prodotto” non sarebbero pensabili se non esistesse la possibilità di creare con immediatezza il desiderio del prodotto mediante gigantesche campagne pubblicitarie. Una limitazione severa della pubblicità comporterebbe, dunque, in modo automatico, una “decrescita”, per lo più a tutto discapito dell’inutile e a tutto vantaggio di un ritmo di cambiamento della vita associata più lento e quindi più umano. Diminuirebbe, altresì la tendenza all’indebitamento dei cittadini, con conseguente difesa del valore costituzionale del risparmio.
In quarto luogo, la pubblicità è un arma formidabile del capitale contro il lavoro, nel senso che impedisce o rende estremamente difficili iniziative economiche fondate principalmente sul lavoro, rispetto ad altre basate su grandi quantità di capitale (i marchi sono una delle forme più disgustose di capitale e di rendita). La pubblicità concorre a creare grandi mercati, i mercati internazionali e i mercati nazionali, e rende difficili iniziative economiche fondate principalmente sul lavoro, o magari su quantità modeste di capitale che ben potrebbero svolgersi su mercati di più ridotte dimensioni. Sotto questo profilo la lotta per la limitazione della pubblicità dovrebbe andare di pari passo ad una più vasta contestazione della disciplina dei marchi. Si pensi soltanto al contratti di franchising, la cui diffusione, in molti settori commerciali, ha espulso dal mercato i veri commercianti, per sostituirli, in molte occasioni, con dipendenti che soggiacciono al titolare del marchio come fossero mezzadri.
Dunque: sottrazione al grande capitale, detentore dei marchi o dei media che pubblicizzano i marchi, del potere di “formare i cittadini”, gli stili di vita, i desideri, le gerarchie assiologiche e quant’altro; e tutto ciò a favore del potere (di formare i cittadini) di istituzioni pubbliche, enti collettivi e attività, imprenditoriali o meno, fondate sul lavoro e comunque su una quantità minore (più umana) di capitale; sottrazione al grande capitale del potere di formare l’opinione pubblica, a favore del pluralismo dell’informazione, del principio di uguaglianza e della effettiva libertà di manifestazione del pensiero; distruzione delle grandi imprese improduttive, venditrici di “pubblicità”, ossia degli occhi e delle menti dei cittadini ad altri detentori di grandi quantità di capitali; valorizzazione del lavoro contro il capitale; rallentamento dello sviluppo economico; aumento della possibilità di sviluppare mercati locali e lotta al mercato globale; riduzione dell’indebitamento dei cittadini e valorizzazione del risparmio; liberazione dalla dipendenza culturale e politica dagli Stati Uniti e dal “dominio delle onde” che essi esercitano; indipendenza autonomia e sovranità del popolo italiano.
Solleviamo la domanda: sono logiche e coerenti le critiche antisistema se non si inserisce dentro ciascuna di esse il proposito di diminuire notevolmente il potere della pubblicità di conformare quella società alla quale si muovono le critiche? La risposta ci sembra che debba essere negativa. Le obiezioni relative alle difficoltà e alle conseguenze, eventualmente negative, che la realizzazione del proposito produrrebbe nell’immediato (per esempio sulla occupazione di taluni lavoratori), vanno prese in considerazione soltanto dopo aver accolto il principio e inciderebbero soltanto sui contenuti dei provvedimenti e delle proposte da elaborare e da porre a fondamento di un’auspicabile battaglia politica, la quale sarebbe anche e soprattutto una battaglia di liberazione nazionale, per la sovranità del popolo, per la autonomia e sovranità dei singoli cittadini, e per la valorizzazione del lavoro.



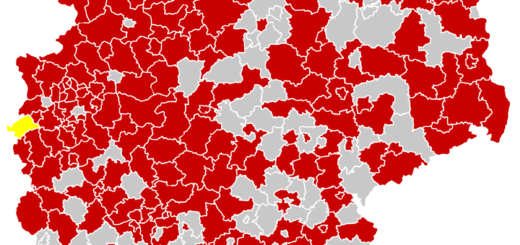



























Finnalmente qualcuno che solleva il problema. Aldilà delle macchinose considerazioni fatte su questo articolo che possono essre condivisibili o meno, resta il fatto che un controllo non tanto sulla pubblicità ma in senso più radicale sui "media" è indispensabile per avere una società libera. Ci tengo a precisare che con la parola "controllo" io intendo totale eliminazione non tanto deii programmi pubblicitari quanto dei "media" stessi, limitatamente a quelli con copertura nazionale, favorendo invece lo sviluppo di quelli a copertura locale. Questo perchè cosi si può avere un'informazione meno controllata dai potentati economici, più variegata e più legata alla realtà locale della persona che legge quel giornale o guarda quella televisione. Naturalmente nulla impedisce ai "media" locali di parlare/scrivere su tematiche nazionali e internazionali. Per quanto riguarda la pubblicità come elemento influenzante la pubblica opinione faccio notare che data la frammentarietà di questa media locali esso divverrebbe un problema automaticamente risolto, visto il poco interesse che i potentati economici potranno avere a publiccizzare un loro prodotto/servizio su un giornale/video a copertura locale, e che nel caso decidessero di avere una copertura nazionale dovrebbero trattare con una miriade di interlocutori, ognuno con una testa e soprattutto ognuno "padrone a casa sua" inquanto questi media sono per loro struttura fatti da piccoli imprenditori locali finanziariamente indipendenti, per cui diventa di fatto impossibile tenatre di "gestire" l'opinione pubblica attraverso questa pluralità di interlocutori. Concludendo desidero far notare a chi ha scritto l'articolo che il problema non si risolve gestendo la pubblicità, ma gestendo i "media".
Tassare e non detassare la pubblicita' trasforma il mondo sotto molteplici punti di vista: la lotta al capitale marchio non deve essere inferiore a quella contro il capitale finanziario: sono due capitali parassiti (come quello fondiario). E colpisce i media nazionali e internazionali esattamente come il tuo divieto. Di fatto li vieteresti senza vietarli. Appariresti molto piu' liberale. E in realta' lo saresti. Perche' privare i cittadini italiani del diritto di vedere un telegiornale di berlusconi al modico prezzo di un euro e mezzo e una partita di calcio al modico prezzo di 15 euro e un film al modico prezzo di 10-20 euro?