Il postmoderno italiano (parte I)
di GIAMPIERO MARANO (FSI Varese)
L’opera postmoderna cita, assembla, riscrive. E pratica così un gioco assassino che ha l’obiettivo di liberarsi dell’ombra opprimente dell’autore, grumo di pensiero e resistenza critica inassimilabile dal globalismo in ascesa veemente quanto fluida.
Come la dottrina tradizionale dell’arte, ma da una prospettiva esattamente rovesciata, anche il postmoderno mette in discussione la centralità dell’autore. È vero che, come sostiene Roland Barthes, l’inizio della scrittura coincide con l’ingresso dell’autore nella propria morte; ma questa morte interpretata dalla Tradizione come un “trasumanar”, un ingresso nel divino che è in noi “più vicino della vena giugulare”, diventa con il postmoderno (e con il conseguente revival epigonale dei generi letterari) slittamento necrofilo nell’infraumano.
L’autore, coscienza matura e sofferta della modernità, viene soppiantato dall’ego regressivo e infantile di cui parla Christopher Lasch nel celebre La cultura del narcisismo (1979). Che i narcisi postmoderni italiani siano attratti dagli Stati Uniti non deve stupire. Uno di loro, il protagonista di Treno di panna (1981) di Andrea De Carlo, emigra a Los Angeles cercando fortuna e successo. Le atmosfere della metropoli imperiale con il loro sfoggio abbagliante di potenza lo affascinano irresistibilmente, a tal punto che il ritratto appena abbozzato di un’amica americana assume una certa valenza connotativa:
non era attraente: priva di eleganza, poco sensibile. Ma la sua sicurezza mi colpiva, il suo modo di muoversi attorno come se non potesse sbagliare in ogni caso (…) ricomponeva la realtà come voleva, senza curarsi delle sfumature. Questo le dava una forza incredibile. La ragazza italiana che era in vacanza con me mi è sembrata incerta al confronto, piena di esitazioni.
Si compie invece tra la nativa Lombardia e la Francia la formazione del giovane omosessuale Barbino in Seminario sulla gioventù (1984), romanzo d’esordio di Aldo Busi, autore dal talento esuberante e intenso del quale si dovrà riparlare. Picaro beffardo ma lucidissimo, Barbino insegue il sogno sincero e disperato di un’indipendenza che non riesce a dissimulare la forte matrice narcisista:
E non avendo di meglio da fare, osservo come tengo la sigaretta fra le dita, come la infilo fra le labbra piene di sangue coagulato dall’astinenza, come estrometto il fumo calcolandone l’intensità. Mi specchio con acuto piacere, e non penso che a aumentare il compiacimento. E se poi nel fumo gira un cerchietto, mi sento, so anche sentirmi felice. Così mi piace pescare nei miei minuti fra una solitudine e l’altra. Mi piace il mio collo, così alto e forte, quando i miei occhi scavano nella mia immagine riflessa. Mi piace il gioco impercettibile delle mie membra che penetrano lo specchio e lasciano i propri contorni anche quando se ne discostano, per tornare subito a vedere se ci sono ancora. Apprezzo la mia faccia delinquenziale.
Al contrario del fratello Dolfo, rassegnato a una vita di piatta e passiva accettazione del sopruso, egli lotta contro tutti i vincoli del passato e della società, non nel segno dell’ideologia e dell’antagonismo politico ma sul filo di un’attitudine fintamente esoterica che conferma l’influenza della Controtradizione sulla letteratura del Novecento:
Aggiustando il tiro attraverso anni di tirocinio alla mira, concentrandosi su un bersaglio detto nemico, il più grosso fallimento dell’intelligenza è quello di non essersi mai accorta che quel bersaglio, ora dopo ora, siamo diventati noi, che la canna della pistola o le nocche del tuo indice si sono ripiegate contro il tuo stesso cuore.
Un atteggiamento di fondo non dissimile è rivelato anche da Marco Lodoli in Diario di un millennio che fugge (1986), quando sembra suggerire che l’immane sindrome depressiva tardonovecentesca possa davvero avere qualcosa in comune con l’abbandono virile proprio dei mistici:
Ricopio fedelmente. Che la vita sia plagio. L’originalità è ingratitudine: raddoppiare, triplicare all’infinito, affinché tutto sia identico, finché sia pura esistenza, pietà del mondo intero in se stessi. Tutte uguali sono le mosche nel pugno di Dio…
L’archetipo di questo nichilismo rinunciatario, camuffato con rimandi speciosi a Meister Eckhart, resta comunque Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco, solitamente considerato il manifesto del postmoderno italiano. Leggiamo alcune righe dell’explicit del romanzo:
Sprofonderò nella tenebra divina, in un silenzio muto e in una unione ineffabile, e in questo sprofondarsi andrà perduta ogni eguaglianza e ogni disuguaglianza (…) sarò nel fondamento semplice, nel deserto silenzioso dove mai si vide diversità, nell’intimo dove nessuno si trova nel proprio luogo.
Mentre un’ironia cinica e fintamente democratica celebra l’apoteosi della letteratura di consumo, e insieme a questa i “Diritti dell’uomo spettatore” (Guy Debord), il testo, omologato e impoverito stilisticamente, depotenziato ontologicamente, viene chiamato a svolgere una funzione encomiastica e ancillare nei confronti del nuovo dominus: il mainstream massmediatico, immortalato con un profluvio di riferimenti a insulsi gruppi musicali, come avviene in Ellis (e nei suoi epigoni italiani), a programmi televisivi, film dozzinali, cartoni animati, fumetti.
La storia poi, privata di monumentalità e fughe prospettiche, si trasforma nella biblioteca-labirinto dell’Abbazia o nel bazar archeologico autoreferenziale già prefigurato con angoscia da Rimbaud: a questo archivio sterminato gli anemici esteti della nuova sinistra, indossati i panni del ribelle anticonformista, attingono per celebrare i fasti dell’open society liberale.
[continua]



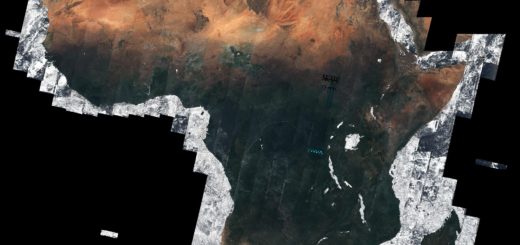



























Una risposta
[…] Qui la prima parte del saggio, e qui la seconda […]